



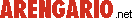
La settimana in rete
I sessant'anni della bomba atomica
Repubblica, il diavolo e l´acqua santa
a cura di Franco Isman - 7 agosto 2005
6 agosto '45: così cambia la storia
Aldo Rizzo su La Stampa del 5 agosto
Hiroshima, sessant'anni fa. Un luogo e una data che hanno cambiato la storia del mondo per sempre. Era il 6 agosto 1945. Alle otto quindici minuti e diciassette secondi, ora giapponese, si aprì il portello del B29 Enola Gay e la bomba da quattro tonnellate (nome in codice, Little Boy) iniziò la sua vertiginosa caduta. Erano previsti 44 secondi prima dello scoppio. L'artificiere Morris Jeppson scandì il tempo a bassa voce. Quando il tempo stava per scadere, ci fu un momento di panico. Jeppson urlò: "Non scoppia!", e Bob Caron, il mitragliere di coda, disse: "Niente. Non succede niente". Due secondi dopo, una luce abbagliante, agghiacciante, raggiunse l'aereo.
…
«La prima bomba forse giustificabile, la seconda un crimine»
Massimo Gaggi sul Corriere della Sera del 6 agosto
NEW YORK — «Sganciare una bomba atomica su Hiroshima fu un atto di guerra legittimo? 60 anni dopo, è ancora difficile dare una risposta netta. Tecnicamente fu un atto illegale: l'attacco contro obiettivi civili è formalmente vietato. Ma allora anche tutta la "guerra fredda", basata sulla minaccia di russi e americani di distruggersi reciprocamente, è stata una illegalità protrattasi per decenni».
Celebre per le sue battaglie a difesa dei diritti civili ed umani, ma non privo di realismo politico, Alan Dershowitz, avvocato e professore di diritto ad Harvard, riflette sull'attacco nucleare deciso dal presidente Truman nell'agosto del 1945, andando oltre il terreno strettamente giuridico. Per l'uomo che ha difeso in tribunale imputati come Mike Tyson, O.J. Simpson e Claus von Bülow, su questo terreno la legalità formale non è tutto: «Del resto la stessa Corte internazionale di giustizia non si è mai espressa chiaramente sull'impiego di armi nucleari: due anni fa ha stabilito che non possono essere usate, a meno che non sia assolutamente indispensabile per la sopravvivenza di un Paese. Una formulazione ambigua che si presta a varie interpretazioni. Ed è un'ambiguità voluta».
Lei, insomma, non avrebbe condannato Truman...
«L'unica cosa di cui sono certo è che il lancio di una seconda bomba, quella di Nagasaki, non ebbe alcuna giustificazione. Quello fu sicuramente un crimine: era passato troppo poco tempo dalla prima esplosione, i capi giapponesi dovevano ancora capire bene cosa era successo. Della prima bomba, invece, discuteremo all'infinito».
Il bersaglio fu una città, non un insediamento militare, i morti furono quasi tutti civili...
«È vero, ma poi lei vede che ci sono casi di sterminio che non vengono mai condannati dalla comunità internazionale, mentre gli israeliani sono stati condannati perché in un'azione che aveva per obiettivo la distruzione di un nucleo di terroristi, sono morti anche cinque civili. Viviamo in un mondo in cui uccidere cinque persone è omicidio, ucciderne un milione è politica. Ripeto: l'illegalità formale di un attacco nucleare è fuori discussione, ma per giudicare se una simile azione può avere una sua legittimità, se è politicamente accettabile, bisogna andare oltre. Il governo Usa giustificò il ricorso all'arma atomica con una sorta di "analisi costi-benefici": se Tokio non si fosse arresa, gli americani avrebbero dovuto invadere il Giappone, con un costo in termini di vite umane molto più alto, sia tra i civili che tra i militari delle due parti. Secondo me le cose non stavano in questi termini: l'invasione del Giappone non avrebbe provocato un numero di vittime civili pari o superiore ai morti di Hiroshima e Nagasaki. È invece vero che sarebbero morti cento o duecentomila soldati americani. Il quesito morale è proprio questo: un grande Paese democratico ha il diritto di preferire la vita dei suoi soldati a quella di un pari numero di civili di un Paese nemico?».
Lei che risposta dà?
«Come si può giudicare un "trade off" morale come questo? Certo, il diritto internazionale vieta di colpire i civili. Ma per una democrazia che sta difendendo il mondo da dittature spietate — che tra l'altro hanno cominciato per prime ad attaccare obiettivi civili, ricorda i bombardamenti nazisti su Londra? — quei soldati sono i suoi figli che si stanno sacrificando per una causa giusta».
…
La lunghissima estate del `45
La bomba ha 60 anni. Lo sterminio delle donne e degli uomini di Hiroshima e Nagasaki non è stato un modo per finire subito la guerra contro un nemico ormai vinto e in cerca di resa ma un crimine contro l'umanità rimasto impunito che anticipa la politica di George Bush.
Vittorio Capecchi su il Manifesto
Da sessanta anni, ad ogni anniversario dello sterminio delle donne e degli uomini di Hiroshima e Nagasaki, la domanda a cui si tenta di rispondere è: «perché?». Oggi, grazie all'ampia documentazione a disposizione, a questa domanda si può rispondere senza particolari incertezze. Ma non solo. La domanda, da generico sgomento di fronte all'orrore che quell'avvenimento continua a suscitare, può essere meglio formulata e articolata: perché il presidente americano Truman autorizzò un crimine contro l'umanità dopo che il Giappone si era arreso? E come è stato possibile che questo crimine contro l'umanità sia rimasto impunito?
La bomba: inutile per la resa del Giappone
La sequenza degli eventi puo essere ricostruita nel dettaglio. La Germania ha firmato la resa l'8 maggio 1945 e anche il Giappone è ormai pronto ad arrendersi: non ha più un apparato militare offensivo con «milioni di persone senza casa e le città distrutte nella percentuale del 25-50%» (dichiarazione dell'8 luglio 1945 dell'Us-British Intelligence Committee). Ciò che accade nel mese di luglio è particolarmente importante: è una storia in cui si intrecciano i rapporti tra Usa e Urss per il controllo del Sud Est asiatico, la volontà degli scienziati di sperimentare la bomba atomica, la decisione di sterminio di un presidente americano, il destino della popolazione inerme di due città giapponesi.
Documenti, a lungo rimasti segreti e censurati, mostrano che la resa del Giappone avviene il 12 luglio quando l'imperatore giapponese, attraverso il suo primo ministro Togo, invia un telegramma all'ambasciatore Sato a Mosca in cui chiede alla Russia (che non ha ancora formalmente dichiarato guerra al Giappone) di fare da intermediaria per trattare la resa. L'imperatore è per una resa incondizionata e chiede solo che questa non comporti la sua destituzione per salvaguardare la «sacralità» della sua figura (condizione, del resto, che verrà accettata dal governo americano, ma solo dopo aver sperimentato le due bombe atomiche). Truman è a conoscenza della resa dell'imperatore, come risulta dal suo diario autografo (reso pubblico dopo gli anni `70) in cui scrive il 18 luglio: «Stalin aveva messo a conoscenza il Primo Ministro del telegramma dell'imperatore giapponese che chiedeva la pace. Stalin mi disse inoltre cosa aveva risposto. Era fiducioso. Credeva che il Giappone si sarebbe arreso prima dell'intervento russo». Da notare che sempre nello stesso diario Truman aveva annotato il giorno prima che «Stalin dichiarerà guerra al Giappone il 15 agosto. Quando avverrà, sarà la fine per i giapponesi».
Il 16 luglio, intanto, era stato fatto il primo test della bomba atomica nel New Mexico e Truman era stato ufficialmente informato che il risultato del test era positivo: la bomba era pronta e poteva essere sganciata sul Giappone. La fine della guerra e la resa del Giappone sono previste entro poche settimane (tra il 18 luglio e il 15 agosto). Ciononostante, la decisione di Truman è quella di usare la bomba, distruggere due intere città giapponesi e condannare ad una morte atroce uomini donne, bambini inermi. Ancora una volta la domanda è: perché?
La bomba: per dominare il dopoguerra
La risposta oggi convergente da tutte le fonti è che ciò ha influenzato la decisione di Truman non era un temuto prolungamento della guerra (ormai di fatto terminata) ma il dopoguerra: se l'Urss avesse dichiarato formalmente la guerra al Giappone il 15 agosto, le sue armate avrebbero potuto entrare prima di quelle americane nel Giappone arreso ed in ogni caso, nel dopoguerra, gli Stati uniti avrebbero dovuto spartire con l'Urss la loro sfera di influenza nel Sud Est asiatico. Si tratta di una ipotesi confermata da una osservazione di Winston Churchill, il 23 luglio 1945: «E' chiarissimo che al momento gli Stati uniti non desiderano la partecipazione russa alla guerra con il Giappone». Nella stessa direzione vanno altre testimonianze. Nel diario di James V. Forrestal (ministro della marina Usa) si può leggere che «il segretario di stato Byrnes aveva una gran fretta di concludere la questione giapponese prima che i russi entrassero in gioco». Il fisico Leo Szilard (che firmò il 7 luglio del 1945 la prima petizione contro l'utilizzo della bomba atomica) nel 1948 ha scritto: «Mr. Byrnes non argomentò che l'uso della bomba atomica contro le città del Giappone fosse necessario per vincere la guerra. Egli sapeva, come anche tutto il resto del governo, che il Giappone era battuto sul campo. Però Byrnes era molto preoccupato per la crescente influenza della Russia in Europa». Anche Albert Einstein (New York Times, 14 agosto 1946) affermò che nella decisione di gettare le due bome atomiche la causa principale era stato «il desiderio di metter fine con ogni mezzo alla guerra nel Pacifico prima della partecipazione della Russia. Io sono certo che se ci fosse stato il presidente Roosevelt questo non sarebbe accaduto. Egli avrebbe proibito un'azione del genere». Sembrerebbe, dunque, che ci troviamo di fronte ad un crimine contro l'umanità come «misura preventiva».
La bomba: chi era contro e chi a favore
Contro l'uso dell'atomica si dichiararono le massime autorità militari. Dice il generale Dwight D. Eisenhower: «Ero convinto che il Giappone fosse già sconfitto e che il lancio della bomba fosse del tutto inutile... In quel momento il Giappone stava cercando un modo per arrendersi il più dignitosamente possibile. Non era necessario colpirli con quella cosa spaventosa». E dello stesso tipo sono le dichiarazioni dell'ammiraglio William Leahy, capo di stato maggiore: «I Giapponesi erano già sconfitti e pronti alla resa. L'uso di questa arma barbara contro Hiroshima e Nagasaki non ci fu di nessun aiuto nella nostra guerra contro il Giappone. Nell'usarla per primi adottammo una norma etica simile a quella dei barbari nel medioevo. Non mi fu mai insegnato a fare la guerra in questo modo, e non si possono vincere le guerre sterminando donne e bambini». Leahy individua anche il gruppo che è stato più a favore: «Gli scienziati ed altri volevano sperimentarla, date le enormi somme di denaro che erano state spese nel progetto: due miliardi di dollari». Quindi, a parte il limitato gruppo dei fisici che era sulle posizione di Szilard e Einstein, c'è un gruppo consistente di attori legati al costosissimo progetto Manhattan che desidera «rendere produttivo l'investimento».
Si arriva così al 25 luglio, quando il Comitato presieduto da Truman e Byrnes (con anche la presenza del rettore dell'Università di Harward James Conant, invitato al Comitato «a nome della società civile», che vergognosamente appoggia lo sterminio) ordina al generale Caarl Spatz dell'Air Force la «missione atomica» su quattro possibili obiettivi (Hiroshima, Kokura, Niigata e Nagasaki) indicando una data provvisoria (il 3 agosto).
La prima bomba atomica scenderà sul centro di Hiroshima il 6 agosto alle ore 8,15 del mattino quando le scolaresche vanno a scuola e le donne e gli uomini al lavoro; la seconda scenderà il 9 agosto alle 11,02 nel quartiere più povero (prevalentemente cattolico) di Nagasaki (tra le due bombe arriva, ormai ininfluente, la dichiarazione di guerra della Russia al Giappone).
Per documentare l'entusiasmo che l'annuncio di questo crimine contro l'umanità riceve negli Stati uniti si può ricordare la testimonianza del fisico Sam Cohen sulla sera del 6 agosto 1945: «Quella sera, Oppenheimer non passò dall'ingresso laterale, fece piuttosto una entrata trionfale come Napoleone al ritorno di una grande vittoria. Mentre entrava, tutti - a eccezione forse di una o due persone - si alzarono in piedi applaudendo e battendo i piedi; erano veramente orgogliosi che ciò che avevano costruito avesse funzionato ed erano orgogliosi di se stessi e di Oppenheimer».
La bomba: come fu mistificata
Nonostante l'euforia, Truman si rende conto che non può rivelare al mondo che ha ordinato un crimine contro civili senza che ve ne fosse bisogno per finire la guerra. Due sono le strategie utilizzate: la menzogna e la censura. La prima menzogna (quella con le gambe corte) è detta da Truman alla radio il 9 agosto quando afferma che «la prima bomba atomica è stata sganciata su Hiroshima, una base militare». La seconda menzogna (quella con le gambe lunghe) serve a nascondere che il Giappone aveva già dichiarato la resa: la bomba è «giustificata» dal numero di morti americani evitato. Come affermò Truman il 15 dicembre 1945: «A me sembrava che un quarto di milione dei nostri giovani uomini nel fiore degli anni valesse un paio di città giapponesi».
Viene poi fatta scattare una durissima censura sia negli Stati uniti che in Giappone. Ad Eisenhower viene inviato il 2 aprile 1946 un memorandum in cui si ordina: «Da nessuno dei documenti destinati alla pubblicazione deve risultare che la bomba atomica fu lanciata su un popolo che aveva già cercato la pace» e nel 1946 venne approvato l'Atto dell'energia atomica che prevedeva l'ergastolo e la pena di morte per chi divulgasse «documenti protetti da segreto con lo scopo di danneggiare gli Stati uniti». In Giappone il silenzio stampa e la censura di qualunque commento critico all'uso dell'atomica furono ferrei fino al 1949.
Le due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki non hanno segnato, dunque, la fine della seconda guerra mondiale ma l'inizio di una nuova era. Quella che usa lo sterminio come misura preventiva, separa l'economia e la politica dall'etica, difende la «neutralità» della ricerca scientifica, legittima la menzogna e l'impunità per chi ha il potere. Il neoliberismo alla Bush è stato anticipato sessanta anni fa da Harry Truman.
Tra la gente della città del dolore dove le colombe sono "mutanti"
Renata Pisu su la Repubblica del 5 agosto
HIROSHIMA - NEL PARCO della Pace, l´altro ieri il vandalo ha agito: a colpi di martello ha tentato di cancellare la scritta incisa sul Cenotafio che circonda la lapide con i nomi delle vittime della bomba. Prima che la polizia intervenisse, aveva fatto in tempo a rendere illeggibile la parola amayachi, errore, del famoso epitaffio che recita: Riposino in pace tutte le anime di coloro che qui giacciono, noi non ripeteremo il medesimo errore. Ora, di notte per non disturbare i visitatori, una squadra di scalpellini è al lavoro per ripristinare la parola ambigua: errore. Sarà di nuovo leggibile la mattina del 6 agosto quando alle otto e quindici minuti, tutta la città ricorderà in silenzio l´errore di sessanta anni fa. Ma l´errore commesso da chi? Quale errore?
Un sopravvissuto di ottantacinque anni, Haruko Hirata, commenta: «Forse il vandalo non è un vandalo, forse è anche lui un hibakusha, un bombardato come me, un sopravvissuto come me. Io non capisco cosa significhi errore. Che noi giapponesi abbiamo commesso l´errore di fare la guerra e siamo stati castigati in questo modo? Oppure che l´errore è stato sganciare quella bomba? Allora, chi ha commesso l´errore? Quale è mai l´errore?»
Il vecchio siede su di una panchina del Parco della Pace, parla come se vaneggiasse, tutti i sopravvissuti, gli hibakusha, a modo loro vaneggiano. E´ la terza volta che vengo a Hiroshima, sempre ho incontrato degli hibakusha che non ci stanno tanto più con la testa. Sarà per la bomba? Sarà per l´età? Ma quante verità dicono, le loro parziali e universali verità. Una monaca buddista dalla testa rasata, fa cenno al vecchio di stare zitto, gli sussurra: «Qui si prega per la pace e basta, per la pace universale».
…
Comunque, siccome la prima industria di Hiroshima è la Pace, il disarmo nucleare, e la città non è più un luogo ma un logo, meglio tenere viva la tensione che in questi giorni neri - vedi Iran, vedi Corea del Nord - rischia di calare. E lo si fa con tutti i mezzi e mezzucci, con tutto il business del Pikadon, espressione onomatopeica per il grande bum della bomba A, lampo e scoppio, pika don! Così puoi comprare tovagliette, spille, bicchieri, asciugamani da spiaggia, borse, portachiavi, con su scritto "Hiroshima Peace ": puoi mangiare in uno dei cento Peace Coffee Shop, o dormire all´Hotel Peace International o al Peace Universal, fare indigestione di una Peace in cui, ti rendi conto, nessuno crede più tanto perché, almeno qui a Hiroshima, definita la Mecca della Pace, tutti prosperano sul Pikadon Shobai, il business del Pikadon, cioè della bomba.
…
il concetto di pace a Hiroshima ha una connotazione politica: il business del Pikadon è anti imperialismo americano, però dopo che il comunismo ha dichiarato bancarotta, non vengono più tedeschi della Germania dell´Est a portare corone di fiori, non vengono più sovietici, cioè russi. Vengono soprattutto americani "buoni". «Pentiti?»domando. «No, Ma non so perché. Non capisco perché gli Stati Uniti non dovrebbero chiedere formalmente scusa come noi dovremmo chiederlo alla Cina per il massacro di Nanchino».
…
«Abbiamo soltanto un altro referente, noi di Hiroshima, Auschwitz, cioè il male assoluto», mi dice il sociologo Yotaro Konaka, il quale detesta il fatto che quando si parla della bomba i giapponesi si pongano sempre come vittime dimenticando di essere stati carnefici.
…
La storia che racconta non è conclusa, come quella di Anna Frank, e anche lei come persona non è conclusa, vive in una prolungata agonia. Quella che viviamo tutti noi giapponesi», conclude.
La vive lui, che è vicino ai settanta anni. Non i giovani giapponesi che di Hiroshima e Nagasaki hanno sentito parlare vagamente, quattro righe nei testi scolastici, quattro righe senza spiegazioni equivalenti all´oblio. O alla rimozione? Nella calura di Hiroshima, alle due del pomeriggio, il tassista che mi porta all´Ospedale dei sopravvissuti, continua a ripetermi che è stato fortunato, tutti morti in casa sua meno lui che aveva sei anni. «Guardi, guardi la pelle della mia faccia», mi dice toccandosi la guancia destra. La pelle è come accartocciata, scura, devastata dalla fiammata di sessanta anni fa. Continua a ripetere «mi dispiace, mi scuso» un modo di dire giapponese che in realtà significa "mi sento in colpa, mi sento in debito". In quanto sopravvissuto si sente in colpa nei riguardi dei morti.
Del vecchio ospedale della Croce Rossa non resta più niente. Ne hanno costruito uno nuovo dove non ci sono più tracce visibili dei primi effetti della Bomba A: schegge di vetro conficcate nei muri, frammenti delle finestre esplose, muri come cera colata e rappresa per il calore di quell´inferno.
…
"Pikadon! Pikadon souvenir!". Questo resta, il business. Nel centro della città che è tutta nuova, una città giapponese trendy e consumista come tutte le altre, centinaia di migliaia di pellegrini della Pace venuti da lontano in questa Lourdes dell´Estremo Oriente, deambulano nell´afa da una pagoda a una stele, da una simbolica tomba a un´altra, da un tempio a una Sacra Fiamma, dal Museo della Bomba al Memorial: pregano incessantemente sgranando rosari buddisti o cristiani, ripetendo mantra che purtroppo risuonano senza senso dopo che l´errore si è ripetuto ancora una volta.
…
In Giappone quest´anno tre film di guerra fanno cassetta, ed è la prima volta che l´esercito e la marina giapponesi, cioè delle Forze di Autodifesa, collaborano con lo show business. Mi dice Oshii Mamoru, il regista delle Anime più cult, il genio al quale si ispira Quentin Tarantino, che finalmente in questi film i militari giapponesi sono belli, sono eroi, sono creature venute dai manga, i fumetti, la letteratura giudicata "inferiore" e per questo non controllata. «Da bambino - mi racconta Oshii che oggi ha cinquant´anni - leggevo manga in cui noi giapponesi sterminavamo gli americani». «Storie del futuro?». «No, del passato, dell´Ottocento. Noi avevamo un´arma superiore e vincevamo». E allora? «Allora il fatto è che in Giappone non si è mai parlato di bomba atomica e di guerra. è sempre stato un tabù, ha imperato la mistica del pacifismo però sotto l´ombrello nucleare americano. Che si tratti l´argomento anche in film popolari, è una catarsi, una liberazione».
«Ma l´undici settembre ha avuto un senso per voi?». «No, noi stiamo vivendo una realtà dell´immagine e basta. La guerra è lontana, non ha realtà. Da noi non si parla mai dell´Iraq, non esiste! La guerra è tabù. Hiroshima è tabù, è una vostra icona», conclude Oshii «conservatela, se volete».
Con la forza e con la ragione
Il doppio passo di Blair
Gianni Riotta sul Corriere della Sera del 6 agosto
Il 14 settembre 2001, con le rovine del World Trade Center fumanti, il maggiore dell'esercito americano Sonya Finley, docente all'Accademia di West Point, tracciò sulla lavagna un grafico con due curve, Libertà e Sicurezza. Se cresce una può decrescere l'altra, spiegò ai cadetti, al minimo della libertà e massimo della sicurezza c'è il Grande Fratello di Orwell, noi godiamo di libertà, qui in alto nella curva, ma a quanti diritti siamo disposti a rinunciare per non restare inermi davanti al terrorismo? L'equazione di Sonya Finley, libertà contro sicurezza, è l'algebra delle società colpite dalla violenza politica.
Da ieri, con il discorso del premier inglese Tony Blair su emigrazione, estradizione e libertà dopo i 52 morti e i 700 feriti della strage di luglio a Londra, il calcolo infinitesimale della tolleranza e della resistenza al terrore fa un passo avanti. Un passo complesso, ma da cui nessun leader potrà prescindere e sul quale la nostra classe dirigente (se ancora una ne abbiamo) dovrebbe meditare. Blair ha annunciato provvedimenti per estradare con meno burocrazia gli stranieri sospetti di legami con il terrorismo, privare della doppia cittadinanza i paladini delle stragi, prolungare il fermo dei sospetti fino a 90 giorni (oggi sono 14), sciogliere due organizzazioni violente, Hizb ut Tahir e al Muhajiron, del fanatico sceicco Omar Bakri Mohammed.
I siti Internet che reclutano kamikaze, li addestrano o diffondono propaganda jihadista verranno monitorati e, se recidivi, azzerati. Le moschee estremiste rischiano la chiusura, il diritto di asilo sarà negato ai militanti qaedisti. «Se necessario» ha detto Blair nel discorso leggibile su www.number-10.gov.uk «rivedremo lo Human Rights Act» e mettere le mani ai diritti umani. Nella patria della Magna Charta, che diede asilo a Karl Marx e si innamorò di Garibaldi, è prova di quante incognite abbia l'equazione libertà-sicurezza. Il segnale di Blair non ha possibili fraintendimenti: «Coloro che hanno abusato della nostra tolleranza e socievolezza... coloro che incitano all'odio» hanno scambiato la società aperta per decadente basso impero e la democrazia per inanità. «Emigrare non è un diritto... chi vive qui gioca secondo le regole del nostro stile di vita e ha il dovere di condividerne e difenderne i valori».
Il giorno dopo il cupo proclama del compagno di Osama bin Laden, Ayman al Zawahiri, che kalashnikov in primo piano ha minacciato nuovo sangue in Gran Bretagna, Tony Blair accetta la sfida della forza contro le stragi e della ragione nella battaglia delle idee. Le democrazie non si faranno piegare per inerzia, se lo stato maggiore salafita punta su una mancanza di reazione etica, considerando gli infedeli tutti debosciati, il premier inglese dice «Vi sbagliate». Ma resterà deluso chi, in casa nostra, si affrettasse senza averlo letto a mettere il feticcio di Blair davanti a fracassone campagne di qualunquismo, dai dirigenti della Lega Nord che chiudono le moschee con banali pretesti ai Tartarini di Tarascona dello scontro di civiltà in salmì. L'offensiva di Blair non omologa Islam e terrorismo, ma contrappone «la piccola minoranza fanatica... alla buona reputazione della maggioranza dei musulmani» in Inghilterra. Dichiara che la chiusura delle moschee intolleranti sarà approvata da una commissione «in accordo con la comunità islamica... con la totale libertà di culto e nel rispetto della religione e della cultura, per decidere come meglio integrare le parti della comunità oggi poco integrate ».
…
Ma Al Qaeda sta fallendo
Donald Rumsfeld sul Corriere della Sera del 5 agosto
Il mese scorso la Gran Bretagna è stata attaccata due volte da un nemico che approfitta dell'apertura delle società libere per uccidere e terrorizzare dall'interno di quelle stesse società. Poco dopo il massacro del 7 luglio, esprimendo il sentimento dei suoi connazionali, un americano ha scritto all'ambasciata britannica a Washington: «Chi attacca Londra non conosce la storia. Chi ha fatto questo scoprirà che non esistono amici migliori di un britannico, né un nemico peggiore».
In seguito a una tale atrocità, è fondamentale per noi tentare di comprendere ciò che spinge gli estremisti a compiere stragi. Come già per attacchi precedenti, i fondamentalisti e i loro simpatizzanti addurrano le solite vuote giustificazioni, che in passato includevano antichi oltraggi reali o presunti, tra i quali: il dispiegamento di truppe statunitensi in Arabia Saudita dopo il 1991, al fine di evitare un attacco di Saddam Hussein; la fondazione di Israele nel 1948; la dissoluzione dell'Impero ottomano circa 80 anni fa; la Reconquista della Spagna, strappata ai Mori nel 1492; le Crociate, la prima delle quali risale al 1095.
Oggi la principale motivazione è la campagna condotta dalla coalizione contro gli estremisti in tutto il mondo e la cosiddetta «occupazione» di Paesi musulmani da parte dell'Occidente. In realtà, le forze della coalizione operano in Afghanistan e Iraq su richiesta di governi democraticamente eletti. Sono stati gli estremisti, non la coalizione, a prendere di mira e assassinare innumerevoli civili musulmani nei barbarici attacchi degli ultimi mesi. C'è chi pare convinto che soddisfare le richieste dei fondamentalisti—ritiro da Afghanistan e Iraq incluso — possa porre termine alle loro pretese e scongiurare futuri attacchi.Ricordiamo, però, che quando i terroristi colpirono l'America l'11 settembre 2001, era un governo islamico radicale a guidare l'Afghanistan e a ospitare capi di Al Qaeda, di fatto indisturbato dalla comunità internazionale. Mentre Saddam Hussein restava saldamente aggrappato al potere in Iraq e pareva conquistare consenso per i suoi tentativi di porre fine alle sanzioni delle Nazioni Unite.
In realtà, gli estremisti islamici hanno a lungo mostrato interesse per un possibile attacco alla Gran Bretagna. Nel gennaio 2003, la polizia britannica ha evitato un probabile attacco con la ricina—una sostanza velenosa—due mesi prima dell'inizio dell'Operazione Iraqi Freedom. Nei vent'anni precedenti l'11 settembre, ben prima dell'impegno della coalizione in Afghanistan e Iraq, gli estremisti hanno continuato a uccidere e sequestrare civili innocenti in luoghi come Teheran, Beirut, Arabia Saudita, Berlino, New York, navi nel Mediterraneo o jet in volo sulla Scozia.
Gli estremisti non cercano il negoziato con l'Occidente. Vogliono che l'America, la Gran Bretagna e gli altri alleati della coalizione abdichino ai propri principi e rinneghino l'impegno con gli amici musulmani nel mondo. Nel 2002,Osama Bin Laden invocava la deposizione dei governi islamici moderati. Il visionario progetto di Al Qaeda di imporre intolleranza e radicalismo si estende molto al di là del Medio Oriente. In particolare, ciò che gli estremisti non tollerano è il riconoscimento dell'uguaglianza tra uomini e donne e la libertà di espressione, segni distintivi delle società libere.
Appena qualche giorno dopo il primo attacco di Londra, un fondamentalista, accusato di aver assassinato un regista olandese per un film ritenuto offensivo nei confronti dell'Islam, dichiarava pubblicamente che avrebbe ucciso ancora se ne avesse avuto l'opportunità. Non c'è «pace separata» che tenga, con un simile nemico. Gli attacchi dell'11 settembre hanno provocato l'ira e la reazione di un Paese e di una civiltà. Da allora, gli estremisti hanno perso ospitalità e sostegno popolare in Afghanistan e Iraq, sono ricercati in tutti i continenti da una coalizione globale che non ha precedenti.
Hanno risposto con mezzi di ogni tipo, dagli zaini alle auto, per uccidere centinaia di persone innocenti in Spagna, Turchia, Kenya, Indonesia, Russia e, ora, a Londra. Tentano di distruggere ciò che non hanno saputo costruire in mille anni e di uccidere persone che non sono riusciti a persuadere. Hanno fallito l'11 settembre. Stanno fallendo in Iraq e in Afghanistan. Conoscendo i britannici, possiamo affermare che con gli attacchi di Londra gli estremisti hanno senza alcun dubbio fallito ancora.
Un killer all'Onu
apertura de il Manifesto del 2 agosto 2005
Aveva detto «l'Onu non esiste», «se il palazzo di Vetro perdesse dieci piani oggi non farebbe differenza», «io non uso la carota». Questo raffinato diplomatico si chiama John Bolton. Scavalcando il senato che rifiutava di approvare la nomina, con una procedura mai usata dal 1948, ieri George W. Bush lo ha nominato ambasciatore degli Stati uniti all'Onu. E' l'ultimo colpo di piccone al Palazzo di Vetro, che tra poco (se ci riesce) compirà sessant'anni
Repubblica, il diavolo e l´acqua santa
editoriale di Ezio Mauro su la Repubblica del 3 agosto
I FATTI sono questi. Carlo De Benedetti, imprenditore e azionista di maggioranza del Gruppo Espresso e dunque di questo giornale, ha progettato sei mesi fa con Mediobanca e Lazard la creazione di un fondo per il risanamento di aziende in crisi, aperto naturalmente al concorso di altri soggetti imprenditoriali e finanziari italiani. Silvio Berlusconi, venuto a conoscenza del progetto, ha chiesto di poter investire in questo fondo e come lui sono entrati nell´iniziativa altri nomi di spicco del capitalismo italiano.
Ma Berlusconi e De Benedetti non sono soltanto due imprenditori. Il primo è il presidente del Consiglio e il capo della destra italiana. Il secondo fa parte di un mondo - questo giornale prima di tutto, il Gruppo Espresso, l´associazione "Libertà e Giustizia" - che in questi anni ha denunciato le anomalie e le storture del progetto politico e culturale di questa destra, e in particolare del suo leader, Berlusconi. Il fatto che questi due personaggi investissero insieme nella creazione dello stesso fondo (sia pure senza alcun patto di sindacato e nessun accordo di alcun tipo) ha fatto scandalo e continua a farlo. E si capisce perché, visto che i due per più di un decennio sono stati in Italia come il diavolo e l´acquasanta.
Le reazioni sono di tre tipi. La prima è interna alla sinistra, e sostiene che quell´intesa è comunque un errore in principio, perché non si fanno accordi di alcun tipo con Berlusconi, visto anche l´oggettivo ampliamento del conflitto d´interessi che il nuovo progetto può comportare. De Benedetti risponde che non c´è nessun accordo, nessun patto, soltanto un investimento comune, e il management sarà totalmente autonomo dagli azionisti.
La seconda reazione è quella dei giornali familiari del Cavaliere, che hanno immediatamente cavalcato l´operazione quasi fosse una benedizione insperata, esaltandola addirittura come una Jalta del capitalismo. Rivelando così un´ansia di sdoganamento e di legittimazione stupefacente dopo dieci anni di pubblica avventura politica del Cavaliere.
Infine, c´è la reazione di chi non ha mosso un dito quando la P2 stava assaltando l´informazione e oggi pensa (in realtà spera) che il semplice investimento di Berlusconi in un fondo creato da De Benedetti basti per sconfessare la linea politica che Repubblica ha tenuto in questi anni e serva per farla cambiare in futuro.
Francamente, questa è l´opinione più sconcertante. Il decennio populista che abbiamo attraversato con la sua sconfessione di ogni regola, deve aver fiaccato coscienze e culture anche esterne all´organizzazione politica berlusconiana, se si può pensare tranquillamente che l´imperativo proprietario può travolgere ormai ogni storia, ogni tradizione, qualsiasi autonomia culturale.
In tutti questi anni Repubblica ha dato i suoi giudizi sulla vicenda politica italiana tenendo conto sempre dell´interesse del Paese, e proprio a partire dalla storia libera e autonoma del suo progetto informativo e culturale. Lo ha fatto per il libero convincimento professionale e civile di una redazione straordinaria, in piena sintonia e continuità con il progetto iniziale dei fondatori, Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo. Ma lo ha fatto in pieno accordo con l´azionista De Benedetti, che ha condiviso e appoggiato tutte le battaglie del nostro giornale, e che non ha certo cambiato idea oggi.
Dunque, non abbiamo nulla da cui guardarci, nulla di cui pentirci (salvo i normali errori di chi fa un lavoro quotidiano, e che sono comunque e sempre responsabilità del direttore). Soprattutto, non sentiamo alcuna contraddizione con noi stessi e con il giudizio che – spesso nel silenzio e nella connivenza altrui – abbiamo dato di questi anni sventurati per l´Italia, nella lettura giuridica del professor Cordero, nell´immagine di Makie Messer usata a proposito da Eugenio Scalfari quando il Cavaliere l´imponeva.
In questi ultimi dieci anni il giornale ha semplicemente scritto ciò che pensava, e che la sua cultura gli dettava. Nessuno ci ha chiesto di cambiare e nessuno ce lo chiederà, con buona pace degli avvoltoi, forse infastiditi dal successo del nostro giornale. In ogni caso, cambiare sarebbe impossibile, con l´Italia che abbiamo davanti. I giudizi che abbiamo dato e che diamo oggi su Berlusconi non nascono dall´ideologia che non ci appartiene ma dalla convinzione che – voglio ripetere con chiarezza ciò che scrivo da più di dieci anni – questa destra italiana rappresenti un´anomalia nelle democrazie occidentali per il conflitto d´interessi, il monopolio dell´agorà televisivo, le leggi ad personam che stravolgono lo Stato di diritto, la sua cultura populista.
Tutto questo non per il dettato di una qualche proprietà, ma per la nostra comune valutazione di cittadini e di giornalisti, coscienti di contribuire a creare un´opinione pubblica informata e partecipe. Consapevoli, anche, che questa è la funzione e la natura di Repubblica, fin dalla fondazione scalfariana, ed è l´identità del Gruppo Espresso, difesa dalle redazioni come dal management e dalla proprietà.
Ci vuol tanto a capire che per tutte queste ragioni l´identità di Repubblica e il suo patto trentennale coi lettori non sono modificabili, né piegabili a contingenze e convenienze? Non tutti i giornali sono trapiantabili nelle zone di terreno più favorevoli e più fertili del momento, come fossero un vaso di fiori. È accaduto in Italia, certo, ma non accadrà a Repubblica.
Spiace doverlo ricordare a dei liberali. Spiace ancora di più doverlo ribadire a dei giornalisti.
Perché dico no a Berlusconi nel fondo
lettera di Carlo De Benedetti su la Repubblica del 6 agosto
CARA Repubblica, cari lettori, cari giornalisti e collaboratori del Gruppo Espresso, caro Eugenio, caro Ezio, in questi giorni mi sono reso conto che si attribuisce alla mia persona una grande responsabilità sulla scena italiana, sia come individuo, sia come azionista di maggioranza del Gruppo Espresso-Repubblica, ai cui giornalisti ho sempre garantito la massima libertà di espressione. È certamente una comunanza di idee e di ideali che ci ha fatto incontrare tantissimi anni fa (Eugenio, ricordi i primi incontri con te e Carlo Caracciolo agli inizi degli anni Settanta?) e ci ha unito attraverso tante battaglie. La passione civile e politica che mi anima dagli anni lontanissimi del Politecnico di Torino, ha portato oggi alla mia identificazione con il Gruppo Espresso, con le persone che lo hanno diretto, lo dirigono e vi lavorano, con i suoi lettori.
In questi ultimi giorni, per errore o in malafede, si è presentata come "alleanza" un´eventuale partecipazione di Silvio Berlusconi a una iniziativa da me pensata e che sarà da me presieduta, con la partecipazione di altri importanti imprenditori. C´è perfino chi ha voluto trattare questo argomento sotto il capitolo della questione morale, alla stregua delle gravi vicende che abbiamo appreso su operazioni finanziarie, tali da gettare ombre e sospetti sul comportamento della stessa Banca d´Italia. E c´è chi ha cercato di approfittare dell´episodio per attaccare il Gruppo Espresso-Repubblica con riferimento alla mia veste di azionista di maggioranza. Non ho letto un solo commento sul merito dell´iniziativa da me assunta, ma solo sul presunto, e inesistente, accordo con Berlusconi.
Desidero dunque chiarire e ribadire, come già avevo fatto attraverso Il Sole 24 Ore del 29 luglio e il Financial Times del 3 agosto, come sono andate le cose.
1. Circa sei mesi fa ho dato incarico a Mediobanca e a Lazard di sviluppare finanziariamente e legalmente una mia idea per creare un fondo per il risanamento di medie aziende italiane.
2. Ho avuto di recente con Silvio Berlusconi un incontro conviviale, da lui richiesto da tempo, dopo che erano passati 16 anni dal nostro ultimo colloquio.
Verso la fine dell´incontro, in cui non si è parlato né di politica né di editoria, Berlusconi mi ha chiesto, incidentalmente, quali fossero i miei futuri progetti imprenditoriali. Ho accennato all´idea del fondo. Berlusconi mi ha chiesto quale fosse il mio investimento e mi ha prontamente chiesto, con gentilezza, se avremmo accettato lo stesso investimento da parte sua. Con altrettanta semplicità gli ho risposto di sì. Non ci sono stati, né potevano esserci, né accordi né patti.
Ma oggi, avendo constatato i malintesi e, soprattutto, le speculazioni che si sono fatte sull´episodio, ribadisco il mio assoluto impegno a considerare come prioritario il mio ruolo di editore del Gruppo Espresso-Repubblica. Per questo e solo per questa ragione, ho fatto sapere a Berlusconi, sia pure ringraziandolo per la disponibilità, che rinuncio al suo investimento.
Sono decenni che faccio l´imprenditore in Italia e so bene che ci sono prezzi che bisogna imparare a pagare. Ma questa volta c´è qualcosa in più. C´è stato il tentativo di attaccare, attraverso la mia persona, il Gruppo Espresso-Repubblica. Questo non lo voglio e non lo posso accettare perché credo profondamente in quella comunità di ideali che è il mondo di Repubblica, dal quale nessuno, neppure il più vantaggioso degli investimenti, potrà mai allontanarmi. I miei critici in malafede, però, sappiano che io andrò avanti con il mio fondo, proprio come l´ho annunciato, nella convinzione che sia una buona cosa per gli azionisti ma anche per il Paese nel quale vedo, con viva preoccupazione, configurarsi come iniziative imprenditoriali avventure finanziarie sotto esame della magistratura.
Politica, affari e il fondo di De Benedetti
Silvio Berlusconi su la Repubblica del 7 agosto
SIGNOR direttore, nel suo editoriale di mercoledì scorso, dal titolo "Repubblica, il diavolo e l´acqua santa", Lei non ha mancato di insistere sulla sua convinzione che il centrodestra italiano rappresenti un´anomalia nelle democrazie occidentali per quattro ragioni: il conflitto d´interessi, il monopolio televisivo, le leggi ad personam, la cultura populista.
Permetta al diavolo almeno di replicare. Non certo sulle sue convinzioni che io rispetto, nonostante rivelino una sua personale ostilità che non credo di meritare, quanto sui fatti, o meglio sulla loro manipolazione.
Vengo ai punti specifici della sua requisitoria.
Conflitto di interessi. Non starò a ricordare la genesi della legge che lo regola. Osservo soltanto che si tratta di una legge severa, che affida il controllo ad autorità indipendenti e che è stata approvata definitivamente, dai due rami del Parlamento, soltanto grazie alla determinazione dell´attuale maggioranza.
Rispetto a questa legge non c´è stato atto governativo che sia stato ritenuto illegittimo e dunque volto a favorire i miei interessi, economici o di qualunque altro genere. In assenza di atti ufficiali, fossero pure di semplice natura istruttoria, nessuno è titolato a sostenere la tesi che il governo sia condizionato dal conflitto d´interesse. Farlo equivale a emettere condanna nei confronti di qualcuno prima ancora che si istruisca un processo. Un atteggiamento totalmente illiberale, questo sì, distorsivo dello Stato di diritto.
Monopolio televisivo. Non mi limito ad osservare che l´attuale assetto del mercato radiotelevisivo vede, oltre ad una vastissima presenza di emittenti locali, due grandi protagonisti in competizione aperta tra loro e altri, attualmente con minori ascolti ma con grandi potenzialità di espansione come Sky del gruppo Murdoch e La7 del gruppo Telecom.
Né mi limito a ricordare che il monopolio statale in campo televisivo è stato rotto proprio dall´affermarsi del gruppo che ho fondato, che ha aperto il mercato pubblicitario alle imprese di medie e piccole dimensioni con notevolissimi vantaggi per tutta l´economia ed ha offerto al pubblico maggiore libertà di scelta, tanto che nel referendum del 1995 la maggioranza degli italiani si pronunciò a favore della parità di condizioni tra concorrente pubblico e concorrente privato.
Voglio invece sottolineare il fatto che, in questi anni di governo Berlusconi, l´azienda pubblica, la Rai, ha combattuto ad armi pari con Mediaset, ed ha in molti casi superato in ascolti Mediaset. Non crede che, se fossi stato spinto dai miei interessi imprenditoriali, avrei agito per ottenere l´esatto contrario?
Basta poi guardare i telegiornali e i programmi di approfondimento (compresi quelli di Mediaset) per rendersi conto che non esiste monopolio né controllo sull´informazione da parte del Presidente del Consiglio.
Io e il governo che presiedo siamo oggetto di critiche e di polemiche - sia nei telegiornali della Rai che in quelli delle tv private - più di ogni altro governo che ci ha preceduto. Questo è indubitabile. Al contrario di quanto è capitato e capita al sottoscritto, nessuno tra i politici nostri oppositori ha mai potuto nemmeno lamentare un personale caso di censura o di attacco a proprio danno.
Leggi cosiddette ad personam. Su questo punto è stata compiuta in questi anni una manipolazione che ha dell´incredibile. E che non ha tenuto alcun conto di un fatto fondamentale. Cioè che il Presidente del Consiglio e altri esponenti del suo partito, sottoposti a processi penali (infondati e per esclusivi motivi politici), non hanno ricevuto alcun beneficio da leggi che, invece, hanno agevolato nei loro diritti di difesa migliaia di cittadini.
Se si esclude la provvisoria sospensione di poche settimane dei procedimenti nei miei confronti seguita all´approvazione del cosiddetto "lodo Maccanico", dal nome dell´esponente del centrosinistra che lo aveva proposto, nessuna legge che ha innovato aspetti importanti della procedura penale ha procurato "vantaggi" giudiziari a me o ad esponenti del mio partito.
Quanto al "lodo", esso è stato cassato dalla Corte Costituzionale non per il merito, ma perché la Corte ha ritenuto che fosse necessaria una legge di natura costituzionale piuttosto che una legge ordinaria. Ma Le ricordo che tutte le forze politiche consideravano, e credo tuttora considerino, assolutamente necessaria una norma che protegga le più alte cariche istituzionali dall´azione penale durante lo svolgimento del loro mandato. Una norma che esiste in quasi tutti i Paesi europei. Dunque si tratterebbe non di una legge ad personam, ma di una legge a tutela delle istituzioni. Tutela necessaria visto il debordante protagonismo di alcuni procuratori della Repubblica che anche in questi giorni stanno occupando la ribalta.
Cultura populista. Qui entriamo nel campo dei puri giudizi politici. Ma anche in questo caso l´accusa mi appare frutto di un atteggiamento di snobismo intellettuale che considero un vizio di certa aristocrazia culturale del nostro Paese. Si è mai chiesto la ragione dell´anomalia tutta italiana nella diffusione dei quotidiani, che sono acquistati da meno di 6 milioni di italiani al giorno? Forse il nostro è un popolo di analfabeti o di indifferenti? O non è forse vero il fatto che l´intellighenzia nazionale è distante anni luce dai problemi che interessano realmente i cittadini?
Non mi stupisce allora che anche Lei consideri populista chi sa parlare ai cittadini con un linguaggio semplice, comprensibile a tutti, e non si rifugia nel gergo elitario, il cui scopo è escludere dalla conoscenza dei fatti e dalla comprensione dei problemi la grande maggioranza degli elettori. Quello che Lei chiama populismo, con qualche, mi consenta, punta di sussiego, io lo considero l´essenza della democrazia. Perché chi governa e chi si occupa della cosa pubblica ha il dovere di far comprendere a tutti il suo pensiero.
Comportarsi diversamente potrebbe far venir meno il suo giudizio tranciante, ma esprimerebbe certamente un´idea della politica e della cittadinanza che risale a prima della conquista del suffragio universale.
Un ultimo punto, e mi scuso per la lunghezza della mia missiva, riguarda la lettera apparsa ieri, su queste stesse colonne, a firma dell´ing. De Benedetti. Prendo nota, con rammarico, del fatto che l´ingegnere, pur essendo persona certo navigata da anni nel duro mondo degli affari, non ha saputo resistere al massacro mediatico, e tutto politico, che investe immediatamente chiunque osi entrare in rapporto con me. Lo capisco, perché io questo massacro ingiusto lo soffro sulla mia pelle quotidianamente da quando ho osato togliere il potere ad una sinistra che si era illusa di avere già vinto.
Non vorrei, Signor direttore, che questa stessa sinistra e che molte persone che la pensano come Lei si illudessero ancora una volta.
Il direttore Ezio Mauro risponderà domani al presidente del Consiglio
Mose, ecco le opere contestate
Barriera mobile per Venezia, le vedute aeree dei 17 interventi che i comuni lagunari ritengono abusivi. Cacciari: "Lunardi le abbatta"
Roberto Bianchin su la Repubblica del 5 agosto
VENEZIA - Spetta al ministro Lunardi abbattere il Mose fuorilegge. A sostenerlo è il Comune di Venezia, secondo il quale compete al ministro delle Infrastrutture ordinare la sospensione dei lavori del sistema di barriere mobili contro l´acqua alta che lui stesso ha fatto iniziare, e disporre la demolizione delle opere costruite finora perché «difformi» rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, comunali e regionali, oggi vigenti.
La «diffida» a Pietro Lunardi è contenuta nel dossier che il Sindaco di Venezia Massimo Cacciari ha inviato al ministro e al governatore della Regione Veneto Giancarlo Galan, sulla base di una relazione dell´architetto Giovanni Toniato, dirigente dell´ufficio comunale «Controllo del territorio».
…
Le violazioni alle leggi in vigore riscontrate dai tecnici comunali nei cantieri del Mose, dove verranno installate le barriere mobili, sono 17: sette sulla «bocca di porto» di Malamocco, sei su quella di Chioggia, quattro su quella del Lido. Sono le «bocche» che mettono in comunicazione il mare con la laguna.
Sulla «bocca» di Malamocco sarebbero abusive, secondo il Comune, la costruzione di una conca di navigazione per le grandi navi e della relativa «spalla» di sostegno, i rinforzi al molo nord, l´eliminazione di una parte del molo sud, la realizzazione di un sostegno alle barriere mobili, il rafforzamento del muro del forte di San Pietro, e lo scavo di un canale per le opere di cantiere. Su quella di Chioggia sarebbero fuorilegge la realizzazione di un porto-rifugio per i pescherecci e dei relativi moli di sponda, la demolizione di parte del molo esistente, lo scavo di una porzione della battigia, la costruzione di un nuovo molo di contenimento dell´isola di Pellestrina e la formazione di una nuova isola vicino al forte Barbarigo. Sulla «bocca» del Lido, gli abusi riguarderebbero la realizzazione di un porto-rifugio per le barche, la costruzione di una nuova isola davanti a Sant´Erasmo, il rafforzamento del molo sud e lo scavo di un canale per il cantiere.
Se ministero e Regione non interverranno, il Comune di Venezia, insieme a quelli di Chioggia e Cavallino, si rivolgerà alla magistratura. E la battaglia del Mose si trasferirà nelle aule giudiziarie.
…
«Noi non possiamo intimare nulla allo Stato - spiega Cacciari - però abbiamo segnalato le violazioni che abbiamo riscontrato, e abbiamo chiesto al ministero e alla Regione che cosa hanno intenzione di fare a questo punto». Maria Giovanna Piva, presidente del Magistrato alle acque, che è il braccio operativo del ministero delle infrastrutture, da cui dipende la costruzione del Mose, sostiene invece che tutti i lavori in corso sono «pienamente legittimi», perché l´approvazione del progetto Mose da parte della commissione per la salvaguardia di Venezia avrebbe «sanato» le violazioni urbanistiche riscontrate dal Comune. Le associazioni ambientaliste contrarie alla grande opera si sono costituite in una «Assemblea permanente No Mose». Simbolo uno squalo e lo slogan: «Il Mose fa bene solo a chi lo fa».
Enea: l'ingegnere fantasma bocciò Rubbia
Ente per l'energia, il vicecommissario (con laurea sospetta) che dà lezioni al Nobel.
Ex senatore leghista, condannato per aver preso «una sega per marmi», nel curriculum indica gli studi all'Ecole Polytechnique di Friburgo, fondata quando aveva 34 anni.
Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera del 2 agosto
Rubbia è un somaro, firmato «el Valvola». Ecco la sintesi, povera Italia, del serrato dibattito scientifico sulle sorti dell' Enea. L'accusa d'esser un «sonoro incompetente» fatta al premio Nobel per la Fisica, ghigliottinato dal governo, parte infatti da un elettricista, già senatore della Lega, promosso per vie misteriose vice-commissario al l'ente per l'energia.
…
Regis, neo vice-commissario Enea: in Italia non risulta laureato benedetto dal titolo di «ingegnere» perfino nel decreto di nomina presidenziale senza che l'Ordine degli ingegneri abbia idea di dove si sia mai laureato.
Partiamo dalla coda? Siamo a metà luglio. Carlo Rubbia, accusato d'avere un carattere ruvido, di essere insofferente alle osservazioni e di avere fatto traboccare il vaso con un articolo su Repubblica contro il Cda, bollato come «il branco», è sbattuto fuori dall'Enea che, azzerato nei vertici, viene affidato ad una terna. Commissario, su indicazione forzista, è Luigi Paganetto, Preside della Facoltà di Economia a Tor Vergata, vice-commissario Corrado Clini (nell'élite del ministero dell'Ambiente da anni, ben visto da socialisti e An) e l'«ing.» Claudio Regis, appoggiato dal Carroccio. Il quale, trionfante per l'ascesa nell'Olimpo della scienza, liquida il presidente deposto con parole affilate: «Nessuno mette in discussione le competenze di Rubbia sulle particelle, ma quando parla di ingegneria è un sonoro incompetente».
Un giudizio avventato. In linea con la storia dell'uomo. Il quale, quando stava a Palazzo Madama, era stato espulso dall'aula per avere barrito: «Aveva ragione chi invocava la legge Merlin per chiudere questo Parlamento: è un bordello!». Prima ancora, andando incontro ad una condanna per vilipendio delle istituzioni, era stato, se possibile, più volgare: «I magistrati sono come i maiali: se ne tocchi uno, si mettono a urlare tutti».
Ma chi è quest'uomo magrolino che tratta un premio Nobel come Albert Einstein non tratterebbe l'asino della classe? Nato a Biella nel 1944, Regis compare la prima volta agli onori delle cronache, locali, nei dintorni di Telebiella, la prima emittente privata del Paese, nata via cavo nel 1971 per iniziativa di Peppo Sacchi. Era allora, stando ai ricordi dei pionieri della tivù, il rappresentante dell'Ampex, il sistema di registrazione videomagnetica che offriva la possibilità di tagliare i tempi morti. Bravissimo nel risolvere ogni problema elettrico, aveva un nomignolo con cui a Il Biellese ancora lo ricordano: «Valvola». Che fosse laureato in ingegneria era ignoto a tutti. Sveglio, però, lo era. E gli amici dell'epoca se ne sarebbero accorti ritrovandoselo prima al comando della Lega biellese. Poi in consiglio comunale. Poi, come dicevamo, a Palazzo Madama. Dove sarebbe stato ricordato solo per una battaglia contro la messa al bando della fabbricazione delle mine anti-uomo («la questione è stata affrontata in modo demagogico, cedendo all'emotività della pubblica opinione!») e per il curriculum fornito alla Navicella: «Laureato in ingegneria. Imprenditore.
Ha studiato presso l'Ecole Polytechnique. Presidente di una società operante nel settore della ricerca aerospaziale. Esperto di relazioni internazionali». Dov'è questa Ecole Polytechnique? Boh... Relazioni internazionali con chi? Boh...
…
Insomma: un cursus honorum. Sufficiente al governo attuale per proiettarlo, nel dicembre 2003, su designazione del ministro dell'Istruzione, nel Cda dell'Enea.
Uomo giusto al posto giusto. Figura nel sito internet dell'ente scientifico come «ing. Regis». Scrive sulla rivista on-line Kosmos articoli sull'«Idrogeno fonte di energia, realtà o mito», firmandosi «Claudio Regis, ingegnere Enea». Partecipa a convegni come quello all'università di Fisica di Pisa tra le reverenze degli astanti: «Buongiorno Ingegnere, prego Ingegnere, dica Ingegnere». Querela gli ex soci definendosi nero su bianco, nell'atto giudiziario, «ing. Regis» e «consigliere del Premio Nobel Rubbia». Finché, caduto il genio scostante che lui «consigliava», Berlusconi lo nomina vice-commissario dell'Enea confermandogli il titolo perfino nel decreto: «ing. Regis».
…
Ma certo, sdrammatizza Regis a Economy che gli dedica 12 righe: non ha studiato in Italia ma alla Ecole Polytechnique di Friburgo. Però, aggiunge, si considera «comunque un ingegnere a tutti gli effetti». Resta da vedere se, dato che non può legalmente fregiarsi del titolo, lo considerino tale almeno a Friburgo, dove la Scuola d'ingegneria risulta esser stata fondata quando il nostro era già in là con gli anni: nel 1978.
Dettaglio divertente. Com'è curiosa la foto fatta all'indirizzo di Londra dove il fustigatore di Rubbia risulta essere residente: «Sw3 London-30 Beauchamp Place». Sapete che c'è, a quell'indirizzo? La trattoria «La Verbanella». Specializzata, forse, in fettuccine spaziali e neutroni al ragù.
Napoli, famiglia di 20 falsi invalidi
Per l'Inps erano paralitici e ciechi
Scoperta truffa da 3 milioni di euro, usate diagnosi non veritiere
Fulvio Bufi sul Corriere della Sera del 2 agosto
NAPOLI — Un'intera famiglia di falsi invalidi. E non due o tre persone: venti. Il marito, la moglie, i tre figli, le due nuore, il genero, due zie, la nonna, la cognata, i consuoceri, quattro cugini, altre tre cognate e persino i nipoti. Tutti invalidi e qualcuno addirittura al 100 per cento, anche tra i più giovani.
È questo il caso più eclatante che viene fuori da un'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli e della squadra mobile sulla concessione di pensioni di invalidità a persone che non ne avevano alcun diritto. Secondo quanto emerso dalle indagini, la truffa ammonterebbe a circa 3 milioni e 770 mila euro. Una truffa in grande stile, dunque. Che è stata portata avanti, secondo gli investigatori, anche con la compiacenza, se non la complicità, di componenti delle commissioni mediche che sancivano la falsa invalidità. Al momento ci sono decine di persone sotto inchiesta, anche perché le indagini, affidate dal procuratore Gian Domenico Lepore ai sostituti D'Avino e Fragliasso, sono cominciate nel 2000, e si sono concluse soltanto poche settimane fa.
Per gli indagati sono ipotizzati i reati di associazione per delinquere, truffa, falso e corruzione.
Il caso dei 20 componenti di un unico nucleo familiare che ricevevano tutti la pensione di invalidità è avvenuto ad Arzano, un paese in provincia di Napoli.
Il capofamiglia, ritenuto dai magistrati e dalla polizia anche il promotore della truffa, era riuscito a percepire anche gli arretrati, incassando in un colpo solo circa 100 milioni delle vecchie lire. Ma non solo lui. Pure la moglie, anch'essa invalida al 100 per cento, ma in realtà in perfette condizioni di salute, ha ricevuto, oltre alla pensione mensile, anche gli arretrati, circa 240 milioni di lire.
…
Il procuratore Gian Domenico Lepore, a conclusione delle indagini, ha emesso una nota in cui fornisce un po' di cifre: 102 gli indagati, 318 i reati contestati, 82 le pensioni di invalidità concesse illecitamente.
A Seul nasce Snuppy il primo cane clonato
È un levriero, unico sopravvissuto di mille embrioni
Michele Serra su la Repubblica del 4 agosto
CLONARE il proprio cane: questa sì che una tentazione forte (altro che pecora Dolly), in grado di scardinare parecchie griglie etiche... Perché si possono avere molti cani, nella vita. Ma esiste, per tutti, un cane eletto (in genere il primo) che non è rimpiazzabile, e a volte torna nei sogni come altri archetipi (la casa dell'infanzia, l'esame di maturità, la prima motocicletta).
Lo stesso Omero dovette imbrogliare non poco le carte della biologia per far tornare Ulisse, vent'anni dopo, dal suo Argo, per giunta ancora munito di naso quanto bastava per riconoscere l'odore del padrone. Un caso, se vogliamo, di clonazione poetica, un post-Argo ricreato per una scena madre alla quale nessun cane, ahimé lui, potrebbe mai arrivare. Un gatto magari sì, ci sono gatti che arrivano a sfiorare i vent'anni: ma è perché il gatto è egocentrico e pigro, il gatto è zen, il cane invece è un emotivo, si spende, si espone, si consuma, fa cagnara: scrisse Tommasi di Lampedusa del cane Bendicò che era dotato di una "adorabile balordaggine". Appunto.
È l'unico parente, il cane, che ci lascia così presto, neanche il tempo di arrivare a festeggiare il diploma dei figli, se è nato, come spesso accade, proprio insieme ai figli. Lui già decrepito, i suoi ex compagni di giochi, che furono cuccioli insieme a lui, appena adolescenti, per un disguido di calendario davvero deplorevole, che ad ogni anno solare fa corrispondere, dicono, sette anni canini. Non so se la clonazione davvero riesca a ripetere, insieme al patrimonio genetico di un individuo, anche la personalità, che nei cani è spiccata, e influenzata (come negli uomini) dall'ambiente e dalle esperienze. Ma certo l'idea di ritrovare identica, negli anni, almeno la silhouette, la sagoma frenetica, la coda che ha fatto da metronomo alle giornate, attira.
La clonazione non mette in discussione il tabù della morte, ma il tabù della vita. La scienza ormai ci insuffla il (diabolico?) dubbio che si possa essere anche noi gli artefici, e non solo gli oggetti, della creazione, ed è logico che questo turbi nel profondo le coscienze religiose, e non solo religiose. Ma in attesa che ci si metta d'accordo sul destino degli umani, troppo complicato per farne un "qui e ora", anche la più occhiuta delle inquisizioni potrebbe concedere una deroga per i cani, no?
Io che non sono animalista, perché le bestie mi piacciono troppo per volerle sottrarre alla loro bestiale diversità, quando è morto il mio cane, due mesi fa, mi sono sentito come Brigitte Bardot quando è morto Vadim. Gli scrisse un necrologio di irripetibile semplicità e bellezza: "Ti aspetto a Saint Tropez". Io quel mio cane (che era una cagna) lo aspetto dove so io, in un tal bosco, sotto un tale cielo. Sbucasse dalla macchia un suo clone, nero e farneticante come era lei, con tre o quattro zecche appese al collo, non credo che sarei così scemo da sentirmi eterno. Ma contento sì, contento di ripetere quel nome che nessuno più chiama, ed era così contento, a sua volta, di sentirsi chiamato.
Così Pratt diventò Corto
A dieci anni dalla morte la città di Siena gli dedica una mostra di acquarelli, realizzati tra il 1965 e il 1995, intitolata "Periplo immaginario": una riflessione sull´opera di questo grande artista della narrazione a fumetti, ma anche un´occasione per ammirare i suoi straordinari nudi femminili. Figure che ricordano i quadri di Schiele e sospingono il creatore del marinaio-zingaro nell´universo dell´alta pittura.
Umberto Eco su la Repubblica del 7 agosto
"Periplo immaginario" è il titolo del sontuoso catalogo della mostra dedicata a Siena agli acquarelli di Hugo Pratt, dal 1965 al 1995 (Lizard Edizioni, 60 euro). Anche se Pratt fosse stato, in vita sua, soltanto l´autore di questi acquarelli, essi basterebbero a fargli consacrare almeno un paragrafo in una storia dell´arte. Ma il rischio è che qualcuno, affascinato dalle immagini prodigiose di questo volume, ammetta che Pratt è stato grande artista perché si è dimostrato anche buon pittore, malgrado la sua lunga militanza «artigianale» nell´universo del fumetto.
Siccome invece Pratt è stato grande artista soprattutto in quanto narratore a fumetti (e se a qualcuno l´espressione può parere ancora riduttiva, «narratore verbo-visivo»), non è casuale che la mostra di Siena lo onori a dieci anni dalla sua morte, e che il saggio introduttivo del volume, di Thierry Thomas, se pure è intitolato agli acquarelli, sia in realtà una riflessione sull´arte di Pratt in generale, e in particolare su quel suo genio verbo-visivo per cui si è incapaci di distinguere il disegno dalla scrittura (nelle storie di Pratt «c´è una sola linea»)
Chi scrive la recensione di un romanzo non deve esordire con una legittimazione della letteratura, mentre ancora oggi chi parla al pubblico generico di fumetti deve mettere ancora, in qualche modo, le mani avanti.
…
Nell´universo del fumetto la critica dovrebbe poter operare distinzioni tra bello e brutto, originalità e manierismo, invenzione e plagio, così come avviene nei vari settori della letteratura e delle arti. Si può essere cinefili e saper distinguere tra Antonioni ed Ed Wood. È sociologicamente interessante studiare l´impatto che sia Flash Gordon che Dick Fulmine hanno avuto sulla generazione italiana degli anni Trenta e Quaranta - e magari ammettere di sentirsi nostalgicamente più legati a Fulmine che a Gordon, e parimenti pochi italiani nati in quell´epoca si sentono nostalgicamente legati a Little Nemo (che aveva fatto fugaci apparizioni solo sul Corriere dei Piccoli dei loro genitori e su Topolino nel 1935), e ricordano con più tenerezza Mandrake. Ma è criticamente innegabile che Alex Raymond e Winsor McCay sono stati artisti incomparabilmente più ricchi e complessi di Carlo Cossio e Phil Davis.
…
Talora il fumetto ha determinato alcune tendenze delle arti figurative (la pop art ne è l´esempio più ovvio) e talora delle arti figurative ripercorre vicende anche secolari. Ora non mi pare che si analizzino ancora con la dovuta severità i casi in cui il fumetto manifesta sindromi di dipendenza da altre arti. Non tutte le analisi mettono in luce quando e come una data tecnica verbo-visiva imita una precedente tecnica cinematografica e quando invece addirittura la precede (come è stato il caso di Crepax). A parte serie anche ben fatte che riciclano senza pudore trame letterarie o cinematografiche famose, e su questo richiamo al già noto si sostengono, vorrei citare un fumetto interessante e spiritoso come Julia, che potrebbe vivere benissimo in base alle proprie forze (e ad alcune trovate originali come l´inserzione di commenti «musicali» nel corso del racconto) e che tuttavia, come sentendosi insicuro, ha deciso di dare alle sue due protagoniste femminili i volti di Audrey Hepburn e di Woopy Goldberg. Facile richiamo, che forse contribuisce al successo della serie, ma perché non parlare criticamente di parassitismo?
Cosa accade invece con Pratt? Tante volte i suoi lettori sono stati tentati di identificare Corto Maltese con Lord Jim, o almeno di intravedere nella saga di Corto influenze conradiane. Mi pare di ricordare che Pratt abbia ammesso i suoi debiti con Conrad (ma ha anche scritto che il suo interesse per i mari del sud nasce da La laguna blu di de Vere Stackpoole). Però sono del pari evidenti, e spesso espliciti nella scelta dei temi da illustrare, i suoi riferimenti a Stevenson, Kipling o Fenimore Cooper. Però non troviamo in Pratt alcuna traccia di parassitismo. Egli riconosce le sue fonti ispiratrici ma combatte bravamente la sua lotta con l´angelo, elabora e risolve, come direbbe Bloom, la sua angoscia dell´influenza, e crea delle storie che sono soltanto e inequivocabilmente Pratt.
Lo fa persino con una strizzata d´occhio post-moderna, come si vede ad esempio quando, anziché subire un´influenza, la ostenta con vezzo citazionistico: ed ecco che nella Ballata a un certo punto Pandora appare dolcemente appoggiata all´opera omnia di Melville, Cain - che verso la fine citerà Euripide - legge Coleridge, autore di un´altra ballata, quella del vecchio marinaio (che ha trovato in traduzione italiana a bordo di un sottomarino tedesco nella bibliotechina di Slütter, il quale lascerà a Escondida anche un Rilke e uno Shelley) e persino un avanzo di galera come Rasputin (anche qui una citazione, ma così scoperta e così fuori contesto, da denunciare tutta la sua dotta ironia) legge in cabina il Voyage autour du monde par la frégate du rois La Boudeuse et la flûte L´Etoile di Bougainville.
…
Ma Corto Maltese è anche l´esempio di una continua ridefinizione di Pratt. Mi scuso se torno a un aneddoto che ho già raccontato almeno due volte, ma lo trovo denso di insegnamenti. Quasi sempre i disegnatori di fumetto si sono ritratti nei loro protagonisti, o nei deuteragonisti al massimo, e chi ha incontrato Al Capp, Feiffer, Schulz o Jacovitti, lo sa (solo Phil Davis ha disegnato in Mandrake il volto di Lee Falk, l´autore delle storie - ma forse era Lee Falk che a poco a poco aveva deciso di diventare Mandrake). Di Pratt non lo sospettavo. Ma un giorno, alla presentazione di non so più quale libro o evento, l´ho incontrato alla Terrazza Martini di Milano e l´ho presentato a mia figlia, che credo facesse ancora le elementari ma era già lettrice delle sue storie, e lei mi ha sussurrato all´orecchio che Pratt era Corto Maltese. Che il re sia nudo lo può dire solo un bambino. Pratt non aveva la statura, l´astata longilineità di Corto, ma guardandolo meglio, di profilo, ho dovuto convenire che in qualche modo era Corto: la linea del naso, il taglio della bocca, non so, certamente Pratt non era il Corto della Ballata, ma quello più magico delle ultime storie, quelle che Pratt non aveva ancora disegnato... Pratt si stava cercando (fantasticava con la matita chiedendosi come avrebbe voluto essere), e cercandosi inseguiva alcuni sogni errabondi.
…
Ora questa ricerca appare ancora più evidente negli acquarelli, che sfilano sotto i nostri occhi come un diario colorato e in cui, come si diceva, l´abbozzo è talmente definitivo da diventare talora una definizione.
Siccome un acquarello è un´opera a sé, Pratt dovrebbe essere un pittore. Ma, in quanto frequentissimamente gli acquarelli riproducono o anticipano personaggi delle sue storie, Pratt sarebbe un illustratore. Qual è la differenza tra un pittore e un illustratore anche quando l´illustratore è grandissimo, come Doré, Rackham, o Gustavino? Direi che nella pittura il soggetto del quadro si affranca dalle circostanze che lo hanno ispirato, così che non ci chiediamo (se non giochiamo alla Dan Brown) chi sia la Gioconda o che cosa accada nel Concerto campestre. Invece davanti a una illustrazione di solito non possiamo goderla appieno se non comprendiamo che cosa illustri, ovvero se la si separa dal testo scritto da cui dipende. Naturalmente la distinzione è trasversale rispetto alle tecniche. Molti pittori ottocenteschi che ci rappresentano, che so, i Lombardi alla prima crociata o il doge Tal dei Tali che riceve i messaggeri del sultano (direi in genere la pittura alla Hayez) sono in effetti illustratori, e se il quadro non avesse la targa col titolo ci chiederemmo che ci stanno a fare quei signori in costume in quel salone. Al contrario può accadere che alcuni schizzi nati per illustrare un libro (per esempio i don Chisciotte di Picasso), vivano poi per conto proprio, tanto quanto i personaggi del periodo blu.
…
Ecco, negli acquarelli di Pratt ci sono spesso delle illustrazioni, che rinviano alle sue storie, vi sono molti splendidi arabeschi e c´è pittura allo stato puro, e in particolare citerei certi nudi femminili, per cui Thomas azzarda il riferimento a uno Schiele meno incattivito (ma sono prodigiosi anche senza pensare a Schiele). E per invogliare qualcuno ad andarsi a sfogliare il catalogo, direi che il ritratto ambiguo di Venexiana Stevenson, del 1994, raggiunge quel rapporto con l´universale che è proprio della grande pittura (con qualsiasi tecnica sia eseguita).

 7 agosto 2005
7 agosto 2005



![]() 7 agosto 2005
7 agosto 2005