



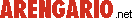
sulla stampa
a cura di G.C. - 15 marzo 2008
Il richiamo della foresta
Curzio Maltese su la Repubblica
Sarà la convinzione d´avere il sole della vittoria in tasca. Saranno l´età e i chilometri: alla quinta campagna elettorale il repertorio fatalmente si avvizzisce. Sarà che Berlusconi è sempre stato così, ma insomma il livello di gaffes ciniche e volgari assemblato dal Cavaliere in due settimane di campagna elettorale sembra eccessivo perfino agli amanti del genere.
Persi i grandi alibi del sogno e dell´anticomunismo, a Berlusconi sono rimaste soltanto le barzellette. L´intera sua campagna assomiglia a una barzelletta, del genere greve. L´altra sera al Tg2, a una ragazza precaria che gli poneva un problema serio ("Come si può metter su una famiglia con 600 euro al mese?") il candidato premier del centrodestra ha consigliato di sposare Berlusconi junior o "un tipo del genere", un figlio di miliardario. Di fronte al gelo dello studio, il grande comunicatore ha poi improvvisato una risposta seria delle sue, cioè lievemente meno cialtrona.
Non si era ancora spenta l´eco della candidatura di Ciarrapico, giustificata da Berlusconi più o meno così: d´accordo, è un fascista ma possiede giornali "che servono". Il verbo è da intendersi in senso largo. Il passaggio logico in cui il primo editore d´Italia dava per scontato che i giornalisti siano servi dei loro padroni è sfuggito alla già rinomata categoria. Ma in molti pagheremmo una cifra, come si dice a Milano, per vedere Berlusconi ripetere il concetto ai leader del partito popolare europeo, che ieri hanno chiarito di non essere disposti ad accogliere nostalgici di Mussolini.
Poco prima il Cavaliere, per tener fede ai propositi di fair play elettorale, s´era messo a stracciare in pubblico il programma del Pd. La campagna era cominciata peraltro con una solenne presa per i fondelli dei suoi elettori, intorno alla vicenda della candidatura di Clemente Mastella. Berlusconi aveva ammesso di aver offerto la candidatura a Mastella, ai tempi in cui questi era ancora nel centrosinistra, ma d´aver poi deciso di non onorare la promessa, "perché secondo i sondaggi, ci farebbe perdere dall´otto al dieci per cento". Anche qui è passato inosservato il passaggio logico per cui un quarto degli elettori del Pdl sarebbero tanto imbecilli da non distinguere fra un gesto politico convinto, magari dettato da scrupoli etici, e una trovata opportunistica.
Nella democrazia americana, che Berlusconi cita da una vita a modello, una qualsiasi di queste gaffes, per usare un eufemismo, avrebbe comportato l´immediata fine della carriera politica. In Italia, per fortuna sua ma non nostra, offendere le donne, i media, gli avversari e perfino l´intelligenza dei propri elettori, non è considerato grave. Neppure o soprattutto dagli interessati. E´ possibile, anzi probabile, che Berlusconi non abbia perso un solo voto dei suoi, né di donne, né di giornalisti, né fra i molti antipatizzanti dell´ex Guardasigilli. Ci sono ben altri problemi, come ripete il Cavaliere. Per esempio la questione della spazzatura a Napoli, per la quale lui stesso non ha fatto nulla nei sette anni di governo.
Il tratto più sorprendente è come Berlusconi, ormai il più anziano leader in attività d´Italia e fra i più anziani del mondo, in tanti anni non abbia raggiunto un grado minimo di dimestichezza con il linguaggio democratico.
…
Il richiamo della foresta in lui è sempre più forte di tutto, perfino in una campagna elettorale nata all´insegna della moderazione e, in teoria almeno, vinta in partenza dal centrodestra. Al cinismo berlusconiano il Paese è mitridatizzato da anni. Non manca chi lo considera, fra seguaci e avversari, con divertimento. Si accettano già scommesse sulle barzellette e le battute che il capo potrà sfornare quando incontrerà da premier il primo presidente donna o il primo presidente nero degli Stati Uniti. Tanto, ci saranno sempre "ben altri problemi". Ma se non si riesce a cambiare nemmeno la forma, figurarsi la sostanza.
Con le peggiori intenzioni
Antonio Padellaro su l'Unità
Con la preventiva dichiarazione dello stato di guerra nazionale, e con il preventivato numero di vite dei nostri soldati da sacrificare in Iraq, Afghanistan e Libano (per ora) il candidato premier della destra ha illustrato il suo programma di politica estera. Che viene di seguito al programma sul precariato femminile (cercatevi un buon partito o arrangiatevi) e al programma di riconciliazione nazionale: più fascismo per tutti.
Una cosa bisogna riconoscere a Berlusconi: che non sa nascondere le sue peggiori intenzioni. E quindi rispetto al più umiliante governo che si ricordi (da lui guidato dal 2001 al 2006) quello che ci sta anticipando nelle sue linee fondamentali è un incubo.
Che l'uomo si sia ulteriormente incattivito si era capito dal modo con cui ha stracciato pubblicamente il Programma del Pd. Un gesto violento da cui traspare come una volontà di rancorosa vendetta nei confronti degli avversari politici. La pagherete cara, la pagherete tutti sembra preannunciarci il piccolo duce.
La compagnia non lo aiuta certo.
Prima, almeno, era costretto ad ascoltare le pretese dei presunti alleati. Adesso Casini non c'è più. È rimasto Fini che giustamente si offende quando il camerata Ciarrapico lo definisce sguattero. Ma che faccia parte del personale di servizio (politico) è incontestabile.
Se questi qua ritorneranno per la terza volta al potere cosa altro ci aspetta già ce lo fanno capire. Fine dello Statuto dei Lavoratori. Uso della polizia stile Bolzaneto. Asservimento della giustizia all'esecutivo e vasta epurazione delle toghe considerate “rosse”.
Stop all'uso delle intercettazioni se non per indagini di terrorismo, e chi è terrorista lo decideranno loro. Omologazione dell'informazione Rai alle veline di Palazzo Chigi con trasformazione dell'azienda pubblica nella succursale di Mediaset. Bossi avrà la Padania tutta per sé mentre il presidente-padrone avrà mano libera su tutto il resto.
E non è detto che sia la parte peggiore del programma.
Confindustria: il nuovo e il vecchio
Alfredo Recanatesi su l'Unità
Il fattore di maggior rilevanza emerso finora nell'avvicendamento al vertice della Confindustria è che per la prima volta il presidente sarà di genere femminile. È una innovazione, questa, che gratifica i paladini delle quote rosa e che, perciò, promette rilevanti risultati mediatici, ma interessa poco chi, per contro, inclina a scrutare il futuro della associazione rappresentativa dell'industria italiana nella speranza di scorgervi qualche più sostanziale novità. Non sono molti gli argomenti da poter portare a sostegno di questa speranza; tutt'altro. Al di là delle capacità e del valore della persona, dimostrate anche nel ruolo rivestito nell'azienda di famiglia, la Marcegaglia emerge da una lunga storia di appartenenza agli apparati confindustriali.
Interrotta soltanto - e questo, dal nostro punto di vista, è un merito - negli anni della presidenza D'Amato, della guerra (persa) all'art. 18, del Patto per l'Italia, del fiancheggiamento militante sia di Berlusconi che, soprattutto, del berlusconismo.
Ma, se le va riconosciuta la presa di distanze da quegli estremismi, non si può non tener conto anche della sua integrale e fattiva adesione alla concezione di un ruolo della Confindustria che viene dagli anni passati, che si definì più compiutamente negli anni di Fossa, ed è stato confermato negli anni di Montezemolo.
Peculiarità di questo ruolo, che non si riscontra nelle analoghe organizzazioni imprenditoriali degli altri maggiori Paesi europei, è la circostanza che si tratta, com'è ovvio, di una associazione corporativa o, almeno rappresentante specifici interessi economici, ma, ciò nondimeno, accreditata di una funzione istituzionale, nel senso che le sue posizioni vengono spesso assunte, presentate e pubblicizzate, come oggettive, come se il loro riferimento fosse l'interesse generale del Paese e non quello di una parte, pur rilevante, di esso. Giocano in questo senso due specifici fattori: gioca il grande peso (per non dire condizionamento) che la Confindustria, la grande imprenditoria, la finanza detengono sui mezzi di informazione; e gioca la struttura stessa del sistema produttivo italiano che, parcellizzato in una miriade di micro imprese, costituisce una forza elettorale assai rilevante corteggiata, in quanto tale, da ogni schieramento politico che ambisca conseguire una quota di consensi a due cifre.
Il risultato di questa distorsione è sotto gli occhi di tutti: è l'incapacità del sistema economico di crescere, è la progressiva sperequazione nella distribuzione del reddito, è la stagnazione del potere d'acquisto di salari e stipendi, è la diffusione di una precarietà usata molto più per perseverare nella compressione dei costi (del lavoro in particolare) che per la flessibilità necessaria al sistema produttivo per essere più efficiente, è l'indirizzo impresso al dibattito, attualissimo, sulla produttività come se questa dipendesse esclusivamente dalla normativa sul lavoro. Per dire del ruolo svolto in questi anni dalla Confindustria, a questo risultato, che è sotto gli occhi di tutti, va aggiunto un elemento che, guarda caso, sotto gli occhi di tutti non è: ossia la circostanza che questa desolazione non ha toccato i profitti i quali, invece, risultano essere stati difesi, secondo dati Banca d'Italia e Mediobanca, quanto e più che negli altri Paesi.
Per questo motivo la Confindustria, questa Confindustria, agli associati va benissimo. Ed è nelle cose che, di conseguenza, la scelta del successore di Montezemolo sia caduta sulla Marcegaglia indipendentemente dal suo essere donna. La distorsione non sta tanto nel ruolo che svolge l'organizzazione, quanto nella oggettività che viene attribuita alle sue posizioni, alle sue analisi, alle sue richieste.
Lo dimostra il fatto che nella pur vasta produzione di analisi che esce dai suoi uffici, per non dire dell'informazione che direttamente o indirettamente controlla o ispira, mai figura una ombra di valutazione critica sul ruolo svolto dal sistema produttivo. Mai. L'industria è sempre presentata in credito verso il Paese, esente da ogni macchia, immune da errori di strategia o di assetto. Prendiamo, pescando nella più viva attualità, il tema della produttività il cui ristagno determina l'impossibilità di remunerare più decentemente il lavoro. Norme sul lavoro, inefficienza delle amministrazioni pubbliche, carenza di infrastrutture, peso fiscale sono le cause che la Confindustria ci espone quasi ogni giorno a motivazione di quel ristagno. Non dice mai che la produttività nelle aziende straniere che operano in Italia è maggiore mediamente del 50%, e che quella delle grandi aziende è addirittura doppia di quella delle piccole. Si parla di aziende che operano in Italia, con dipendenti italiani, con le norme italiane, il fisco italiano, le strade e le ferrovie italiane, insomma i costi italiani. Possiamo concluderne che il problema non è solo quello che denuncia la Confindustria, ma è soprattutto nel nanismo delle imprese, nella loro governance familiare, nella conseguente ritrosia ad investire, nel deficit di imprenditorialità che impedisce loro di aggregarsi, di fare massa critica, di raggiungere dimensioni che consentano innovazione, ricerca, confronto con una concorrenza globale su mercati globali? L'industria italiana ha perso la grande occasione della stabilizzazione monetaria, della nascita dell'euro, degli anni di bassissimo costo del denaro per passare dal XX al XXI secolo (si legga il libro di P.L. Ciocca "Ricchi per sempre?"). Il sistema bancario quella occasione l'ha colta (ci si consenta di dire: sotto la regia di Antonio Fazio); è stata colta da molte imprese che ora godono di un più che meritato successo di mercato e di profitti; ma la maggior parte del sistema quella occasione l'ha persa, la politica gli ha dato una mano nel perderla seguendo (per quanto ha potuto) i suoi suggerimenti di politica economica, ed ora siamo qui ha parlare di emergenze sociali, di impoverimento, di declino.
È improbabile che una Confindustria guidata dalla Marcegaglia sia diversa da quella conosciuta in questi anni.
…
La politica estera nel dimenticatoio
Franco Venturini sul Corriere della Sera
Anche un vertice sottotono come quello in corso a Bruxelles dovrebbe stimolare il tardivo avvento della politica estera nella campagna elettorale italiana. Non ingannino i sorrisi distribuiti ieri da Nicolas Sarkozy e da Angela Merkel nel presentare insieme l'Unione per il Mediterraneo.
Il progetto, per molti aspetti ancora controverso, ha portato al calor bianco nelle scorse settimane i dissidi sempre più frequenti tra Parigi e Berlino. Complici il troppo rapido allargamento dell'Unione e l'arrivo all'Eliseo dell'iperattivo e poco collegiale Sarko, quello che un tempo era l'"asse" motore dell'Europa è diventato lo specchio di un solido reciproco sospetto.
Certo, l'Unione è cambiata ed è oggi più vicina al modello britannico che a quello carolingio. Da est a ovest e da nord a sud assistiamo alla divaricazione degli interessi e delle politiche nazionali, proprio quando gli europei dovrebbero invece prepararsi ad affrontare insieme le sfide di un mondo globalizzato e nel contempo multipolare. Ma piaccia o non piaccia è con questa realtà che l'Italia deve fare i conti. Dal 2009, da quando cioè il Trattato di Lisbona sarà stato ratificato, dovremo puntare a un nocciolo duro a sei (con Spagna, Polonia e Italia) per scongiurare un "direttorio " a tre anglo-francese-tedesco. Con quali alleanze? Il governo Prodi ha scelto la Germania come partner d'elezione. Farebbe lo stesso, un governo Berlusconi? E soprattutto, saremo in grado di avere quella voce stabile e credibile che è funzione degli equilibri politici e istituzionali interni, magari a cominciare dalle schermaglie già in atto per rinnovare i tre più alti incarichi della Ue nuova versione? La politica europea dell'Italia sarà cruciale, ma non sarà l'unica a richiedere scelte difficili.
I rischi crescenti che la Nato corre in Afghanistan si sono tradotti, e si tradurranno anche dopo il cambio della guardia alla Casa Bianca, in richieste di maggior impegno militare. Siamo sotto pressione come la Germania, che promette di pensarci su dopo la scadenza in ottobre dell'attuale mandato parlamentare. E come la Francia, che al vertice di Bucarest dei primi di aprile annuncerà l'invio di un migliaio di soldati in più. Inoltre, chiunque vinca le elezioni, non ci sarà più da noi il veto condizionante dell'estrema sinistra. Gianfranco Fini si è mostrato in questi giorni possibilista, e ha ragione per due motivi: perché un rafforzamento a Herat è comunque previsto dopo la scadenza in agosto del nostro turno di comando a Kabul, e perché una attenuazione dei caveat sulla dislocazione dei nostri reparti appare possibile (come per la Germania, la Francia e la Spagna) nell'ambito di una più precisa intesa politico-militare tra alleati atlantici. Ma la questione-chiave rimane: andranno o non andranno i nostri soldati a presidiare quel fronte sud dove le perdite sono altissime? E ancora. Ridurre le forze italiane nel sud del Libano (anche a questo ha accennato Fini) può lanciare un segnale sbagliato e comportare problemi con gli altri Paesi che contribuiscono a Unifil II, a cominciare dalla Francia. Lo farebbe egualmente, un governo Berlusconi? Il confronto israelo-palestinese è tanto complesso da sfidare ogni previsione e ogni politica, ma il ministro francese Kouchner, secondo l'International Herald Tribune di ieri, è parso "diplomaticamente" favorevole a un qualche contatto con Hamas. Tutto tranquillo. In Italia invece D'Alema si spinge oltre e solleva una tempesta: questione di strategia o di imprudenza dialettica, e quale sarà l'orientamento di domani? Tutto l'Occidente segue con il fiato sospeso le vicende balcaniche, e dopo l'indipendenza del Kosovo teme che l'11 maggio siano i nazional-nostalgici a vincere le elezioni serbe: l'Italia, con i suoi particolari interessi geostrategici, dovrà provare a esercitare una influenza costruttiva tanto sulla mano semi-tesa della Ue quanto sugli umori di Belgrado. L'Iran che vota oggi non ha intenzione di rinunciare ai suoi programmi nucleari: l'Italia sosterrà con maggior impegno le sanzioni anti-Teheran, e come reagirebbe all'ipotesi di un intervento militare tuttora sul tavolo a Washington e a Gerusalemme?
L'elenco delle scelte da compiere potrebbe continuare …
La pulizia religiosa
Renzo Guolo su la Repubblica
La morte di monsignor Rahho, vescovo caldeo di Mossul, riporta al centro dell´attenzione la drammatica situazione dei cristiani in Iraq. Pochi mesi fa una catena di attentati ha colpito le chiese di quella provincia. L´estate scorsa un prete e alcuni diaconi erano stati uccisi. Nel 2005 anche il vescovo siriaco della città, Casmoussa, era stato rapito e poi rilasciato.
Il tasso di violenza che regna nell´area è molto alto. Mosul è città contesa tra curdi, arabi sunniti e turcomanni, un conflitto sul quale si è innescata anche la "pulizia religiosa" condotta da gruppi islamisti che hanno approfittato delle tensioni etniche locali per colpire i cristiani. Geograficamente nel Kurdistan iracheno, Mosul è sotto controllo dei peshmerga: le forze speciali americane non effettuano operazioni antiterrorismo nell´area. Una concessione politica, prima ancora che militare, che gli Usa hanno fatto a uno storico alleato come i curdi. Una scelta che ha favorito l´arrivo nel Nord degli islamisti in fuga dalle province centrali, scacciati dagli americani e, soprattutto, dagli shawas, i membri delle milizie armate sunnite un tempo loro alleati.
Senza alcuna tutela, in un clima in cui la polarizzazione tra sunniti e curdi per il controllo della città non lascia spazio a identità terze, i cristiani sono divenuti oggetto di crescente violenza. Molti hanno lasciato il Paese, alimentando l´imponente esodo iniziato dopo il 2003; altri, in una situazione in cui a tutti viene chiesto di schierarsi da una parte o dall´altra, hanno preferito convertirsi all´islam.
Una situazione che è anche il prodotto oggettivo della nuova politica americana in Iraq. Identificati cinque anni fa come il nemico, i sunniti sono ora tornati nelle grazie di Washington. Il timore per la crescente influenza iraniana sul paese, a larga maggioranza sciita, e la necessità di togliere agli jihadisti l´acqua in cui nuotano, hanno spinto Washington a rimescolare le carte. Il successo del generale Petraeus non è comprensibile senza mettere a fuoco il fenomeno della shawa, il risveglio sunnita. Ma se la politica di "riconciliazione nazionale" mette fine all´inconsulta epurazione di massa voluta dall´allora governatore Bremer, innesca anche un effetto domino che manda in fibrillazione i gruppi etnici e religiosi usciti vincitori dalla guerra. Il risveglio sunnita assume, infatti, anche il volto di ottantamila miliziani pagati dagli Stati Uniti. Si tratta degli stessi uomini che sino a un anno fa sparavano addosso ai marines e venivano chiamati terroristi, ribelli, insorti. In guerra, si sa, il fine giustifica i mezzi: e il nemico di ieri non è detto sia quello di oggi. Gli shawas sono inquadrati da leader radicati nel territorio e capaci di controllare parte rilevante della popolazione sunnita che, nel vuoto di potere lasciato dalla scomparsa del partito-stato, è tornata a guardare alle lealtà religiose, tribali, claniche. Entrati in conflitto aperto con gli jihadisti "stranieri", privi ormai di santuari in cui rifugiarsi, gli shawas stanno contribuendo in maniera determinante alla loro sconfitta: nonostante gli inevitabili colpi di coda del qaedismo.
Il risveglio sunnita non è, però, privo di incognite. Genera tensioni a Mosul, città divenuta a maggioranza sunnita dopo la politica demografica voluta da Saddam ma rivendicata dai curdi; e inquieta gli sciiti. L´emblematica visita di Ahmadinejad a Baghdad è anche un messaggio rivolto dagli sciiti iracheni agli americani: tanto più punteranno sui sunniti, tanto più sarà necessario bilanciare il loro crescente peso volgendo lo sguardo verso i confratelli iraniani.
A sua volta Teheran guarda alla svolta sunnita come all´ennesimo tassello di una politica che mette in discussione quel ruolo di potenza regionale che l´Iran ha assunto dopo la fine dei regimi ostili delle potenze laterali, l´Afghanistan e lo stesso Iraq. Ruolo destinato a crescere in futuro per effetto del ritiro americano e della corsa al nucleare. Gli iraniani, così come gli sciiti iracheni, sanno che il risveglio sunnita è ancora fragile; ma se questa fragilità venisse superata con la nascita di un "partito della shawa", incoraggiato da un sostegno politico, religioso e finanziario esterno, scatterebbero le contromisure. Tanto che non è esclusa la messa in campo di gruppi capaci di svolgere, con ben altra efficacia, il ruolo politico e militare esercitato in passato dall´Esercito del Mahdi. Formazione oggi in disarmo non certo a causa del soggiorno del suo leader a Qom, destinato formalmente a far acquisire a Moqtada al Sadr quel sapere teologico capace di conferirgli una legittimità religiosa sempre mancata; ma perché Teheran ha sin qui preferito mantenere il conflitto con gli americani allo stato di latenza.
…
Tutti i gruppi etnici e religiosi iracheni sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nel puzzle creato dalla svolta sunnita di Washington. A loro spese lo hanno capito anche i cristiani.
L'ultima sfida dei rivoluzionari con la tonaca
Filippo Di Giacomo su La Stampa
Quando l'ultimo poeta", dicevano i fratelli Goncourt, "avrà scritto il suo ultimo verso, solo allora Dio dirà: signori, si chiude". Un monaco, per definizione, è una persona capace di disarmare persino la sua anima, un inerme che la cultura moderna, quella meglio intenzionata, confina nel mondo dell'innocua utopia. Eppure, come stanno dimostrando anche nel Sud-Est asiatico, proprio come i poeti, i monaci continuano ad essere coloro che le culture religiose e civili del mondo fanno nascere affinchè a nessuna di esse venga a mancare la voce che ricorda la radice essenziale delle cose. Dopo quelli del Myanmar, anche i monaci buddisti del Tibet stanno tentando di far comprendere quanto sia forte il desiderio di libertà coltivato dalle loro e dalle altrui culture. In fondo, sia i primi sia i secondi sono scesi nelle strade solo per chiedere, in Myanmar a prepotenti di destra, in Tibet a prepotenti di sinistra, con le parole del Dalai Lama, "di rispondere con il dialogo al risentimento del popolo".
Una richiesta, che anche per le repressioni di questa settimana ha le sue radici nel cinquantennale soffocamento dei diritti del popolo tibetano. Solo che la novità di questi nostri ultimi anni, a differenza di quanto avveniva per le contestazioni indipendentiste degli anni Sessanta, consiste nel fatto che la voce incarnata dai monaci birmani e tibetani non riesce a rompere il muro di silenzio e di disinteresse che il mondo manifesta verso coloro che chiedono libertà senza voler ricorrere alla violenza. Con la sola arma del dialogo, il mondo delle religioni, di tutte le religioni, sta spesso tentando, in nome di popoli interi, di farsi carico del grido soffocato di moltitudini di oppressi, di interpretare la sofferenza e la dignità di intere nazioni, senza farsi trascinare nell'avventura insensata delle guerre di religione così care ai teocons di ogni ispirazione.
Ai monaci buddisti di Myanmar e del Tibet succede ciò che religiosi di altre fedi stanno subendo, in circostanze analoghe, in tutte le aree calde del pianeta. E come a loro, anche ai monaci buddisti i nostri media tendono ad ammannire la solita zuppa di realpolitik in salsa occidentale. Del Tibet, cioè di un Paese invaso e privato della sua sovranità dagli anni Cinquanta, ci si limita ad osservare che, pur dopo anni di umiliazioni e di privazioni, è un Paese che si sta rinnovando. E che in questo passaggio da Stato indipendente a provincia cinese, dato che il popolo tibetano ha visto le sue condizioni di vita migliorate sul piano economico, diventa irrilevante il fatto che il buddismo abbia dovuto pagare con la perdita di una sua patria secolare.
Anche le violenze contro i monaci di Myanmar sono state presto liquidate come un episodio marginale di un sistema politico con problemi di economia. Invece la Birmania deve la sua indipendenza dal colonialismo britannico, ottenuta nel 1948, proprio grazie all'azione determinante e non violenta dei suoi monasteri.
…
Quando si tratta di ricordare quanto hanno potuto gli uomini della religione nella storia più o meno recente di questo nostro pianeta, gli esempi sono facili e infiniti. Dal Tibet, dal Myanmar, dai cimiteri dell'Iraq ci stanno giungendo in questi giorni voci che ci dicono perché sia così necessario rilanciare la difesa dei diritti umani all'interno di un mondo globalizzato. Il quale proprio perché interconnesso su infiniti e complicati aspetti del vivere individuale e sociale, ha bisogno di stimoli che indichino a tutti vie percorribili, vite accettabili ed esistenze riconosciute.
…
E adesso l'America ha veramente paura
Massimo Gaggi sul Corriere della Sera
Ora la paura è quella di una reazione a catena. Un crollo paragonabile a quello del 1929 verrà probabilmente evitato, ma non è più un fantasma lontano. Il dramma di Bear Stearns si è consumato in poche ore. Ancora mercoledì il suo capo, Adam Schwartz, assicurava che la banca aveva capitali in abbondanza.
Ma giovedì sera è iniziata la fuga dei risparmiatori e in una notte Bear Stearns è rimasta senza liquidità. "Non fosse arrivata la Federal Reserve a salvarla" dice l'analista di Credit Suisse, Carl Lantz, "ieri mattina non avrebbe avuto nemmeno i soldi per accendere la luce". La caduta di schianto della banca d'affari ha lasciato senza fiato gli operatori per il fatto in sé — le parole più usate per la sua possibile scomparsa sono "impensabile" e "surreale " — ma, soprattutto, per i modi e i tempi della crisi. Trovatosi all'improvviso in piena emergenza, Schwartz non ha avuto scelta: ha chiesto aiuto alla Banca centrale Usa. E la Federal Reserve, che da settimane non fa altro che lanciare ciambelle di salvataggio, ha deciso di assumersi direttamente l'onere dell'intervento d'emergenza.
Nessuno sa con certezza cosa accadrà ora: alcuni sostengono che Bear Stearns — che ieri ha perso quasi metà del suo valore, ma ha ancora un patrimonio importante — riuscirà a restare sul mercato, sia pure "sotto tutela". Altri sono convinti che sparirà o verrà incorporata in un'altra banca già nei prossimi giorni. Ma una cosa è certa: quello eseguito ieri attraverso JPMorgan Chase non è un intervento di mercato. La banca che storicamente ha sempre assistito il Tesoro e il governo americano nei momenti difficili, ha accettato di funzionare da "pipeline", da collettore di un salvataggio nel quale non rischierà nemmeno un dollaro: l'operazione è stata ideata dalla Fed d'intesa col Tesoro e la Sec (la Consob americana). E le perdite che ne deriveranno saranno a carico della Banca centrale.
Un mese dopo la decisione del governo laburista-liberista britannico di Gordon Brown di "nazionalizzare" la banca Northern Rock, anche negli Usa il capo della Fed, Ben Bernanke, compie una scelta dirompente come quella di soccorrere una banca privata con un intervento pubblico. Lo fa per evitare che il contagio si espanda e sfoci nel temuto "meltdown" del sistema finanziario americano. Ma a pagare saranno i cittadini: se non con le tasse, con l'inflazione e l'ulteriore perdita di valore della loro moneta.
…
Bear Stearns, la più piccola delle cinque grandi banche d'investimento di Wall Street, è di certo quella con i maggiori problemi. Ma non è l'unica malata. I governatori della Fed non hanno nemmeno preso in considerazione la possibilità di farla fallire — come sarebbe normale, in base al mercato, per un istituto che ha sbagliato molto — proprio per il timore di un "effetto domino". Quando, nell'estate scorsa, fu costretta ad ammettere di aver fatto indigestione di titoli basati su mutui subprime, Bear Stearns rimase da sola dietro la lavagna solo per pochi giorni: ben presto fu raggiunta da "sorelle maggiori" come Lehman Brothers e Morgan Stanley. Poi fu la volta di Citigroup, il più grosso gruppo bancario del mondo: denunciò perdite gigantesche, causate dalle scelte avventate della sua divisione che investiva nel mercato dei derivati. Da allora per Citi è iniziato un cammino doloroso fatto di avvicendamento dei capi, licenziamenti di massa, perdite e svalutazioni del patrimonio.
Per colmare i buchi, la grande banca Usa è stata costretta a imbarcare nuovi soci stranieri (soprattutto fondi di governi asiatici e di Paesi arabi del Golfo) che hanno pompato 30 miliardi di dollari di risorse fresche nelle sue casse. Ma qualche giorno fa un grande investitore di Dubai si è detto convinto che gli interventi eseguiti finora sono insufficienti: ci sono in giro altri 15 miliardi di crediti non recuperabili. Quanto durerà, ancora, l'inverno per l'economia americana? Mark Zandi di Economy.com invita a non farsi illusioni: la crisi immobiliare farà sentire i suoi pesanti effetti fino al 2010. Ma Bush continua a dirsi ottimista e annuncia che la ripresa arriverà nel terzo trimestre del 2008, anche grazie agli assegni da un migliaio di dollari che il governo paracaduterà a maggio nelle case di decine di milioni di americani. Quasi divertito dal fatto che un calendario beffardo l'abbia costretto a comparire davanti all'Economic Club di New York nel giorno più nero di Wall Street, il presidente ieri ha tirato fuori il cow boy sfrontato che è in lui: ha celebrato la gloria di un centro finanziario — quello di Manhattan — "che tutto il mondo ci invidia" e ha chiuso col consueto atto di fede: "Credo in un dollaro forte perché l'economia è forte".

 15 marzo 2008
15 marzo 2008
![]() 15 marzo 2008
15 marzo 2008