



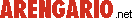
sulla stampa
a cura di G.C. - 13 marzo 2008
Il fascismo non va messo in lavatrice
Gadi Luzzatto Voghera su La Stampa
Cos'è stato il fascismo per l'Italia? Quale valutazione dà del fascismo la classe politica che oggi si candida a governare il Paese fondato sulla Costituzione repubblicana nei prossimi cinque anni? Stando alle reazioni registrate dalle agenzie di stampa alle inusitate dichiarazioni nostalgiche del candidato Giuseppe Ciarrapico, il fascismo è, nella sostanza, "il passato con cui abbiamo fatto i conti" e il promotore delle "ignominiose leggi razziali". Colto con le mani nel vasetto della marmellata, lo stesso Ciarrapico ha evocato dal cappello di prestigiatore il coniglio buono per tutti gli spettacoli: "Mi sento onorato del fatto che la mia famiglia abbia protetto negli anni bui del '44 una delle più importanti famiglie israelite in Roma". E anche Fiamma Nirenstein, candidata nella stessa lista di Ciarrapico, ribadendo la fermezza inequivocabile del proprio antifascismo, ricorda di aver "visto Fini con la kippah chiedere scusa a Gerusalemme per quanto è accaduto" e di averne in tal modo potuto valutare il "coraggio".
Sembra di capire che per l'Italia del 2008 il fascismo sia iniziato nell'autunno del 1938 e che un'accorta e sollecita condanna per la "degenerazione" delle leggi antiebraiche, magari accompagnata da un salutare lavacro nelle acque del Museo della Shoah di Gerusalemme, possa mettere definitivamente la parola fine a questo fastidioso residuo di un passato che non passa. Su questa linea sembra si ritrovi la maggioranza di coloro che si sono espressi durante questa imbarazzante vicenda, formando una sorta di schieramento trasversale. Così, nell'Italia del 2008, definita la natura del fascismo, per distanziarsene basterà procurarsi lo sguardo benevolo della sparuta minoranza ebraica italiana, o attuare politiche di visibile "amicizia" con Israele, per potersi dire immuni da sospetti nostalgici.
…
L'antifascismo, che è ancora oggi radice imprescindibile della nostra repubblica, si fonda sulla memoria negativa di quel che Mussolini e il fascismo hanno determinato con le loro azioni politiche e militari: annullamento delle libertà democratiche, istituzione di una giustizia di regime, persecuzione degli oppositori, violenza di Stato diffusa, annullamento della libertà di movimento, di riunione, di stampa, aggressivo imperialismo militarista, massacri indiscriminati di civili. E poi un'alleanza politica, economica e militare con il nazismo hitleriano, un'alleanza che ha condotto l'Italia e gli italiani a farsi compartecipi e corresponsabili di massacri e deportazioni indicibili. Questo - fra le altre cose - è stato il fascismo cui c'è ancora qualcuno che pensa di potersi ispirare. Poi, è indiscutibile, il fascismo ha anche ideato le leggi razziali, e gli italiani le hanno sostanzialmente attuate (e non "subite", come vorrebbe Ciarrapico). Ma in esse il fascismo non si esaurisce né si compendia. Se la nostra aspirante leadership politica la pensa diversamente, dovrebbe ricominciare a studiare un po' di storia.
E ora si parli di economia
Dario Di Vico sul Corriere della Sera
Dopo una sbornia di due settimane ricche solo di candidature a porte girevoli, con gente uscita e gente entrata per un soffio, è bene che i partiti cambino passo. Che prendano a parlare di economia partendo magari dallo spunto più interessante di questo scorcio di stagione politica: il libro di Giulio Tremonti. Prima della provocazione dell'ex ministro sembrava che le ricette dei due principali partiti avessero un po' lo stesso sapore. E tutto sommato non si trattava di una brutta novità. Che addirittura uno dei contendenti accusasse l'avversario di aver copiato i compiti, anche questa era un'assoluta primizia. Ma soprattutto l'indizio che le tendenze centripete all'interno dei due schieramenti stavano finalmente prendendo il sopravvento, scacciando la maledizione centrifuga che aveva visto in due legislature il primato delle forze estreme (la Lega prima e la sinistra radicale dopo) su quelle moderate e di stampo europeista.
Gli ottimisti ne avevano tratto la conseguenza che il nostro bipolarismo si stesse normalizzando, stesse seguendo la rotta degli altri sistemi basati sull'alternativa al potere tra due schieramenti guidati dalle mezzeali centriste. Poi è arrivato il pamphlet di Tremonti. Il più brillante degli intellettuali del centrodestra, l'uomo già designato per occupare la poltrona chiave di Via XX Settembre ha costruito con maestria un prodotto editoriale per proporsi come l'unico capace di dare un'anima a un partito come il Popolo della Libertà, che sembra trovare il suo collante più sull'imminenza del ritorno al potere che su una piattaforma politico- culturale innovativa. Con il libro che già qualcuno ha etichettato come "l'elogio della paura globale ", Tremonti stoppa la conversione centripeta del nostro bipolarismo e sceglie per sé, per il governo nel quale lavorerà un posizionamento centrifugo. Indica al centrodestra italiano una strada diversa da quella percorsa dai grandi leader europei come Nicolas Sarkozy e Angela Merkel.
Ma indicata anche da un no partisan come Jacques Attali.
…
Il Popolo della Libertà resterebbe così l'unica consistente destra populista d'Europa e ridarebbe fiato al vecchio contenzioso italiano con la filosofia e le scelte della Ue. Tra i liberali che militano nell'area di centrodestra si è aperta un'ampia e sincera discussione sulla svolta tremontiana ma forse non è ragionando solo di scuole liberiste che si può trovare la chiave di questa novità. Non bisogna dimenticare che per il nostro Paese resta quasi intatto un deficit di affidabilità internazionale, testimoniato dallo spread tra i nostri Btp e i bund tedeschi tornato ai livelli degli anni 90 quando Hans Tietmeyer non ci voleva dentro l'euro. E non bisogna sottovalutare come nella business community anglosassone—e nei giornali tipo l'Economist che ne interpretano gli umori — rimanga forte il pregiudizio nei confronti di Silvio Berlusconi.
Questi elementi, se sommati, gettano un'ipoteca sulla campagna elettorale, come se il programma del Pdl fosse un mero esercizio di stile e i pamphlet dessero invece la vera misura di come si muoverà il nuovo governo del Cavaliere. Anche sul fronte opposto, quello del Pd, gli elementi di indeterminatezza sono ampi. Il programma presentato è sicuramente orientato in chiave modernista, rompe con la cultura del "tassa e spendi" che ha dominato negli ultimi due anni e fa propri i suggerimenti di intellettuali come lo storico Gianni Toniolo che chiedono al Pd di assumere un orientamento pro global e a favore della società aperta. Restano, è vero, ambiguità come quella che ha portato alla creazione nelle liste di strane coppie (il cigiellino Paolo Nerozzi usato come stopper su Pietro Ichino) ma l'incognita è un'altra. Veltroni non ha ancora indicato il suo Mr. Economia e non si tratta certo di un'amnesia. E' un limite intrinseco di un programma che serve più a riposizionare il partito che a governare, un manifesto che segnala l'abbandono della cultura "irista" ma non riesce a indicare una piattaforma incisiva per l'azione di un ipotetico governo di un nuovo centrosinistra.
Non c'è una vera indicazione contro i rischi di recessione, ci si limita ad assemblare istanze anche giuste ma poi si glissa sulle coperture finanziarie, ovvero sulla praticabilità hic et nunc di quelle stesse scelte. E' anch'esso un esercizio di stile. L'indicazione di un Mr. Economia probabilmente coprirebbe questo vuoto, non servirebbe solo a riempire una casella dell'organigramma ma indicherebbe a Bruxelles e ai mercati un volto e una politica.
…
Frattini, il tecnico per tutte le poltrone
Fabrizio Rondolino su La Stampa
BRUXELLES. E' durata poco più di tre anni l'avventura europea di Franco Frattini, commissario alla Giustizia, libertà e sicurezza nonché vicepresidente della Commissione. Le sirene di un seggio a Montecitorio e, in caso di vittoria del Popolo della Libertà, della poltrona di ministro degli Interni o degli Esteri, sono state più forti di ogni altra considerazione, compresa l'opinione che a Bruxelles hanno di noi italiani. Lassù, in Europa, qualcuno ricorda ancora la figuraccia di Franco Maria Malfatti, democristiano di gran razza e primo presidente italiano della Commissione europea (il secondo è stato Prodi). Malfatti rimase in carica meno di due anni, e si dimise nel marzo del '72 per candidarsi alle elezioni. Fu eletto, e un anno dopo rientrò al governo come ministro della Pubblica istruzione nel Rumor IV. Alla scelta di Malfatti seguì un forte ridimensionamento del peso europeo dell'Italia, e da allora si parla di una "sindrome Malfatti " che regolarmente colpisce i nostri politici, incapaci di cogliere l'importanza della dimensione europea e attratti ogni volta dal richiamo del ballatoio di casa.
Le conseguenze delle dimissioni di Frattini non saranno altrettanto gravi, non foss' altro perché gli europei ci sono abituati. D'altro canto, con gli europarlamentari non va meglio: proprio ieri Il Sole- 24Ore ha documentato come siano finora 37 (su un totale di 78) gli eurodeputati italiani che negli ultimi due anni hanno lasciato Strasburgo per candidarsi a varie tornate elettorali nostrane.
,,,
Come Gianni Morandi, Frattini non invecchia mai, e la sua aria da bravo ragazzo, o, come ha scritto un giornale inglese, da low-profile technocrat, gli è sempre stata di aiuto nel teatrino impazzito della politica italiana, e lo ha aiutato a conquistarsi la stima del Cavaliere, sensibile da sempre, oltreché alle buone maniere, anche e soprattutto al profumo di establishment. Enfant prodige negli studi (una laurea in Giurisprudenza a ventuno anni) e nella carriera, Frattini incontra la politica con Giuliano Amato - che, ironia della sorte, è da più parti indicato come il suo più probabile successore bipartisan alla Commissione - e da lui certamente apprende l'arte della tecnocrazia all'italiana. Diventa dunque segretario generale a Palazzo Chigi col governo Ciampi (1993) e qui rimane, con lo stesso incarico, quando arriva Berlusconi (1994). Il ribaltone vede il suo primo, significativo scatto di carriera: ministro della Funzione pubblica e degli Affari regionali nel governo Dini (1995).
Poi, la scelta di campo, esemplarmente riassunta nella biografia in inglese pubblicata nel 2001 sul sito ufficiale del governo che lo vede ministro della Funzione pubblica e poi, dopo le clamorose dimissioni di Renato Ruggiero e un lungo interim di Berlusconi, ministro degli Esteri: "In 1996 he discharges himself from the assignment of Minister for candidarsi to the political elections with the Pole for the Freedoms, List of Italy Force. He comes elect to the Parliament in the uninominale College of Bolzano Laives. In september 1996 it is elect to the unanimità President of the Committee Parliamentarian for the Intelligencies agency and emergency and for the secret of State".
L'inglese di Frattini è senz'altro migliore di quello della sua biografia; e tuttavia permane una generale impressione di opacità. Dei tre anni passati a Bruxelles con Barroso non si segnala praticamente nulla, se non un'intervista al Messaggero poi censurata dal Parlamento di Strasburgo. Era stata appena assassinata Giovanna Reggiani, a Roma, e montava una violenta polemica politica dal sapore sgradevolmente xenofobo. Frattini spiegò che per rispondere al problema sicurezza quello che "si deve fare è semplice: si va in un campo nomadi a Roma, ad esempio sulla Cristoforo Colombo, e a chi sta lì si chiede “tu di che vivi?”. Se quello risponde “non lo so”, lo si prende e lo si rimanda in Romania. Così funziona la direttiva europea. Semplice e senza scampo". L'Europarlamento votò a maggioranza una mozione in cui si dichiarava che le affermazioni di Frattini "sono contrarie allo spirito della direttiva europea" sulla libera circolazione dei cittadini.
Memorabile la dichiarazione di accettazione della candidatura, il 7 marzo: "È una grande occasione per dire agli elettori che l'Europa è una grande opportunità, che noi la trascuriamo troppo". Appunto.
Il falò delle vanità
Massimo Giannini su la Repubblica
La relazione unificata del Tesoro rotola come un macigno sulla campagna elettorale. Di fronte alle previsioni sull'andamento dell'economia nei prossimi anni, le generose promesse programmatiche di Berlusconi e Veltroni sono buone giusto per un romanzo di Tom Wolfe: il falò delle vanità. Purtroppo ci aspettano tempi durissimi. Persino più duri di quelli che avevamo immaginato. L'ultimo documento economico redatto dal governo Prodi prende atto di quello che in troppi, soprattutto nel ceto politico, non hanno voluto vedere.
Non basta dire che l'Italia crescerà meno del previsto. Un aumento del Pil che scende dall'1,5 allo 0,6 per cento è molto più di una flessione, e poco meno di una recessione. Un dato che non registra solo il peggioramento del ciclo, ormai già in atto da qualche mese nella percezione e nelle tasche dei cittadini. Si riflette negativamente anche su tutte le voci del bilancio pubblico come di quello familiare.
Visto che decresce il denominatore (cioè il Pil) sono destinati a risalire automaticamente i numeratori (cioè il deficit e il debito pubblico). Questo vuol dire che non ci saranno risorse per finanziare lo sviluppo. Con un Paese che viaggia a crescita zero, è persino ridicolo continuare a litigare su un "tesoretto" dal quale attingere per sostenere i salari e i redditi medio-bassi.
Come si temeva quel "tesoretto", se mai è esistito, è destinato a svanire in fretta. E ha fatto bene Padoa-Schioppa a non considerarlo, nella sua Relazione unificata, per non alimentare, insieme a vecchie polemiche, anche nuove illusioni. Per le élite politiche è davvero il momento dell'assunzione di responsabilità: chiunque vinca le elezioni, non ha di fronte a sé l'avvincente cavalcata nelle verdi vallate che sognava il mai troppo compianto Beniamino Andreatta, ma una lunga traversata nel deserto della quasi stagflazione che ci regalerà il non rimpianto George Bush.
Tanta parte di queste difficoltà nasce dai costi di una crisi che nasce in America, e che l'America scarica sul resto del mondo. L'Europa ne soffre. L'Italia, in ragione dei suoi ritardi strutturali sulla finanza pubblica, sulla competitività delle imprese e sulla produttività del lavoro, ne paga conseguenze anche più pesanti. Di tutto questo bisognerebbe parlare, in questa campagna elettorale che era partita bene ma che sta lentamente e pericolosamente scivolando verso i soliti cliché: ideologismi contrapposti, attacchi personali e vaghezze progettuali. Invece di rinfacciarsi il passato e il presente di Prodi, Berlusconi e Veltroni ripartano da quel tanto di buono che il suo governo ci lascia in eredità: un risanamento ben avviato. E cerchino di costruire su questo, ciascuno nel proprio ruolo, un progetto per il Paese.
Il suicidio dell'obiettore che faceva aborti
Anna Tarquini su l'Unità
Obiettore per il Gaslini, cucchiaio d'oro con studi privati a Rapallo e nel centro di Genova. Quando Ermanno Rossi ha capito che Sabrina Monteverde, magistrato di Genova, non aveva nessuna intenzione di mollare l'osso, cioè l'inchiesta sugli aborti clandestini nella città dove è più alto il numero di obiettori e dove le liste d'attesa costringono le donne a cambiare città per poter interrompere la gravidanza nei limiti di legge. Quando lo stimatissimo dottor Rossi ha capito, è salito all'ultimo piano del "grattacielo" di Rapallo, ha inviato l'ultimo sms alla moglie chiedendo scusa, ed è volato giù.
Erano circa le 22 e nella giornata, a partire dalle sei del mattino, i Nas avevano fatto visita tre volte al dottore: al Gaslini stesso, nello studio di Genova e in quello di Rapallo. Cercavano le prove, ulteriori prove che negli studi medici extralusso si praticavano aborti in violazione della 194. Non si può infatti, per legge, abortire in uno studio privato; non si può farlo se non entro i 90 giorni; non si può se si è minorenni. E tutte e tre le fattispecie di reato - sembra - ricorrevano.
Una decina di indagati, il riserbo è massimo e non si è certi se insieme a Ermanno Rossi siano coinvolti altri medici o comunque altro personale sanitario. Le indagini sono partite da una donna che aveva chiesto di abortire al Gaslini dove si effettuano solo interventi terapeutici. Sembra fosse stata dirottata allo studio. E dopo si era confidata con una esponente del Movimento per la vita che a sua volta aveva presentato la denuncia. Certo è un boomerang per quanti in questi giorni di campagna elettorale hanno cavalcato la tigre della legge da rivedere, della 194 male applicata perché favorisce gli aborti. Si sa che gli aborti clandestini in Italia sono 20.000, e a violare la legge sono gli extracomunitari, ma ora Genova ha rivelato un altro sommerso che sfugge alle statistiche. Quello degli aborti dei ricchi, aborti illegali pagati a peso d'oro. Eppure nella stessa città è impossibile abortire. A Genova c'è un solo medico che si è assunto responsabilità e fatica, il dottor Mario Ramondini, e lo chiamano Erode. Nel maggio scorso hanno sospeso gli aborti anche al Galliera, l'ospedale che fa capo al presidente della Cei Angelo Bagnasco: ufficialmente per ragioni di opportunità. Tutti i medici ginecologi del Galliera sono obiettori di coscienza, tutti gli aborti richiesti all'ospedale venivano praticati da medici del vicino ospedale Evangelico. L'ultimo allarme era stato lanciato dalla presidente dell'Aied Mercedes Bo: "Liste di mesi, dobbiamo dirottare le pazienti a Savona".
Ecco, in questo senso, il dottor Ermanno Rossi, 54 anni, non faceva eccezione. Amatissimo dalle sue pazienti, sempre disponibilissimo, ma obiettore, come tutti gli altri. Solo che nel suo studio in via XX settembre, la via Veneto della città ligure, gli aborti si facevano. E come se si facevano. Ma erano aborti per clienti abbienti. Erano mesi che i Nas dei carabinieri gli stavano alle calcagna. Sua moglie gli aveva più volte raccomandato di rivolgersi a un avvocato, ma lui faceva spallucce: "Sono tranquillo". Lunedì mattina i carabinieri si sono presentati al Gaslini alle sei del mattino. Dovevano prelevare il medico che aveva appena finito il turno di notte e portarlo nei suoi due studi per le perquisizioni. Ermanno Rossi sembrava sereno. Nel pomeriggio è tornato a casa per cenare con la famiglia, poi è uscito con la scusa di dover rimettere in ordine lo studio. Alle 22 l'sms con la parola "scusatemi" e poche indicazioni su come regolarsi dopo di lui. La donna ha chiamato il 118 e i vigili del fuoco, poi con il cognato Pietro Tuo anche lui medico è corsa verso lo studio. "Deve aver sentito le sirene. Ha sentito le sirene e si è buttato di sotto prima che riuscissero a salire nell'appartamento". È andata così.
…
Protezionismo e riforme
Mario Monti sul Corriere della Sera
La globalizzazione in corso sta apportando grandi benefici e grandi problemi, a livello mondiale e all'interno di ogni Paese. Essa non è un fenomeno irreversibile. Nel 1914 la globalizzazione era, in molti aspetti, ancora più avanzata di oggi. Ma la guerra la infranse. È chiaro da anni che la globalizzazione attuale richiede, per non cozzare contro ritorni protezionistici, di essere molto più governata dai pubblici poteri, attraverso un ben più efficace coordinamento internazionale. Progressi sono in corso, ma lenti e insufficienti.
In tutti i Paesi coesistono gli sforzi rivolti a rendere le rispettive economie più competitive, per vivere con successo la globalizzazione, e gli appelli rivolti a proteggerle, per frenare l'impatto della globalizzazione. Questa tensione ideale e politica tende a ravvivarsi nelle fasi elettorali. Ciò è naturale e opportuno, trattandosi di definire l'agenda politica per i prossimi anni.
Per i Paesi membri dell'Unione europea, va tenuta ben presente un'importante asimmetria. Ciò che un Paese può fare per diventare più competitivo, è in larga misura nelle proprie mani. Per tradurre in atto intenti protezionistici, invece, un Paese che non voglia uscire dall'Unione europea può solo battersi per far prevalere la linea protezionistica in sede comunitaria. Lì è possibile impegnarsi per una politica di totale apertura, per una politica di chiusura protezionistica o — linea difficile ma a lungo andare promettente — per una politica che usi il peso europeo per affermare maggiormente sul piano globale regole di funzionamento corretto dei mercati.
Il futuro economico e civile di un Paese dipende molto da due aspetti della strategia che il Paese sceglie in materia.
In primo luogo, l'impegno per profonde e rapide riforme strutturali, rivolte a una maggiore competitività, dovrebbe essere considerato essenziale anche da chi propenda per un indirizzo protezionistico. In un'Europa che, come mostrano recenti ricerche, nel complesso ha saputo trarre dalla globalizzazione benefici importanti, la battaglia per il protezionismo non sarebbe né facile né rapida. Intanto, sarebbe davvero imprudente non attrezzare il Paese per una sfida competitiva che sta perdendo. E che, anche nello scenario protezionistico, si protrarrebbe almeno per qualche tempo ancora. Inoltre, con quale credibilità invocherebbe il protezionismo in sede europea il governo di uno dei pochi Paesi che non si sono ancora messi in grado di affermarsi con le proprie forze nel mercato globale ?
In secondo luogo, nel formarsi un'opinione sull'opportunità di un orientamento protezionistico, occorre anche considerare la mappa degli interessi interni che se ne avvantaggerebbero.
…
È probabile che da un'opzione di protezione possano trarre beneficio tutti coloro che, all'interno del sistema economico-sociale di un Paese, godono di rendite di posizione. Sarebbe infatti attenuato l'impulso ad abbattere tali rendite con riforme per creare più libertà di entrata. Certamente, tra i principali beneficiari sarebbero i soggetti della politica. Nel corso dei decenni, la possibilità per la politica di occupare spazi impropri nella vita economica e finanziaria, e di accrescere senza fine la propria discrezionalità e i propri privilegi, ha trovato un serio limite solo nell'apertura internazionale, in particolare nell'integrazione europea.
La maledizione degli operai
Bruno Ugolini su l'Unità
Sembra una maledizione. Quella che nelle ultime ore ha segnato la morte di altri due operai a Torino. Sono storie emblematiche dell'Italia di oggi, intrecciate alle statistiche indecenti sui salari italiani. Parlano di un lavoratore in appalto, massacrato da un cuscinetto d'acciaio infilato nello stomaco.
E di un altro, lavoratore in affitto, auto-appesosi a una corda: non sopportava il mancato rinnovo del contratto temporaneo, non ce la faceva più e non ha retto.
La tragedia della ThyssenKrupp non rallenta i suoi effetti visto che il secondo lavorava per un'azienda fornitrice proprio della Thyssen. E così si parla di maledizione. Ma non è colpa del destino cinico e baro.
Leggiamo il tremendo biglietto lasciato alla moglie e ai due figli dal trentanovenne suicida Luigi Roca: "Ho perso il lavoro e con quello la dignità. Scusami". Quella parola dignità fa rabbrividire. Perché parla a tutti noi. Racconta di un uomo e come lui sono tanti, uomini e donne, giovani e meno giovani che da tre anni passava da un contratto all'altro e ora si era convinto di essere arrivato, ormai quasi a 40 anni, a una meta più solida. Era convinto di aver finalmente conquistato l'attesa sicurezza. Invece no.
Che cosa pretendeva Luigi Roca? Forse pretendeva di essere considerato anche lui, certo, davvero, un “produttore”, uno che vede riconosciuto il proprio ruolo di fornitore non solo di “manodopera” ma anche d'intelligenza, di sapere acquisito. Ecco perché la sua morte parla anche a questa campagna elettorale. A certe polemiche che bollano il Pd come un partito che avrebbe voltato le spalle al mondo del lavoro. Magari perché ripropone, appunto, un “patto tra i produttori” capaci di risollevare le sorti del Paese.
Quella formula, non estranea alle riflessioni della sinistra, dovrebbe però essere interpretata meglio. Intanto bisognerebbe che davvero operai come l'interinale Luigi Roca, ma anche come Antonio Stramandinoli, lavoratore in appalto, fossero riconosciuti davvero fino in fondo come “produttori”. E quindi in possesso di diritti e tutele adeguati, di un ruolo non secondario, non da interrompere quando si vuole, o da sottoporre a rischi vitali. Stramandinoli lavorava per un'azienda dove era in corso una trattativa sull'uso degli straordinari. E forse la richiesta insistente di allungare gli orari di lavoro non è del tutto estranea all'intensificarsi d'incidenti.
Fatto sta che l'aspirazione a passare da sfruttati a produttori (come recitava il titolo di un grande libro di Bruno Trentin) è ancora tutta da realizzare. E per questa via sarà necessario l'esercizio di un conflitto organizzato, vitale per le stesse sorti qualitative di un'impresa moderna. Una volta si diceva “conflitto fisiologico”. Certo che non siamo più di fronte ad una “classe” come quella conosciuta nel '900 con connotati di forte omogeneità. La frammentazione, il decentramento, il progresso tecnologico hanno mutato il mondo del lavoro. E in esso si aggirano spesso donne e uomini soli. Come Luigi Roca. Che col suo gesto disperato racconta una solitudine anche ideale. Una solitudine che forze sindacali e forze politiche sono chiamate a riempire con un progetto che davvero sappia organizzare, parlare, destare coscienze, ridare fiducia. Anche proponendo tappe ravvicinate, inserite in un orizzonte riconoscibile. Senza limitarsi a predicare un mondo migliore.
Perché la maledizione può essere combattuta e vinta. Magari anche contrastando coloro che nella Confindustria mettono in discussione, oggi, le agevolazioni del centrosinistra per chi è addetto a lavori usuranti. Oppure coloro che osteggiano sanzioni per imprenditori inadempienti in materia di sicurezza. Temi anche questi di conflitto civile, ma necessario. Lo stesso conflitto che ha portato nel passato a mutamenti sostanziali.
…
Hamas, Israele attacca D´Alema
Vincenzo Nigro su la Repubblica
ROMA - Aveva promesso: non polemizzerò mai in pubblico con il Governo italiano, con i suoi ministri, proveremo sempre a dirci le cose in faccia, ma in maniera riservata. Era la politica scelta da Gideon Meir, nuovo ambasciatore israeliano a Roma, inviato alla fine del 2006 in Italia per sostituire Ehud Gol, il "carro armato" che aveva diretto l´ambasciata di via Mercati negli anni di Berlusconi. Evitare gli attacchi in pubblico: una scelta concordata col ministro Tzipi Livni, per facilitare la vita al governo di centrosinistra di Romano Prodi. Ma ieri sera Gideon Meir, la colomba, il super-diplomatico, ha fatto un bel passo in avanti: "Chi ci invita a negoziare con Hamas ci invita semplicemente a negoziare sulla misura della bara e sul numero dei fiori da mettere sulla corona: Hamas vuole soltanto la distruzione di Israele".
Ma chi, ieri mattina, aveva invitato per l´ennesima volta Israele a trattare con Hamas? Era stato proprio Massimo D´Alema: con una battuta al tg di Sky, il ministro degli Esteri tornava a suggerire il negoziato, "perché Hamas controlla un pezzo importantissimo del territorio palestinese e se si vuole la pace bisogna coinvolgere chi rappresenta una parte importante del popolo palestinese. E poi, non dimentichiamoci mai che Hamas vinse le elezioni...".
Parole diverse da quelle degli altri leader Ue, che ancora una volta non erano sfuggite al primo ministro di Hamas, Ismail Haniyeh, che proprio ieri ha ringraziato il governo italiano per la sua posizione.
Queste parole di Haniyeh, assieme a un retroscena, spiegano perché l´ambasciatore Meir abbia deciso di varcare il suo Rubicone: quando la settimana scorsa D´Alema, a poche ore dall´attacco terroristico alla scuola rabbinica di Gerusalemme, aveva ripetuto lo stesso concetto, Meir aveva chiesto un appuntamento all´ambasciatore Cesare Ragaglini, direttore generale per il Medio Oriente. La sostanza della conversazione era stata questa: noi non capiamo più perché D´Alema, con tutti i problemi del governo Prodi, anche in campagna elettorale continui a insistere pubblicamente su Hamas, danneggiando le scelte politiche di Israele ma anche lo stesso Abu Mazen. Per Israele ogni dichiarazione a favore di Hamas rafforza una dirigenza "che per noi è estremista e non vuole nessun vero negoziato con Israele. Non capiamo perché D´Alema lo faccia, ma adesso inizia a crearci problemi e saremo costretti a reagire".
Ieri, dopo il ringraziamento di Haniyeh, l´ambasciatore Meir non si è consultato neppure con il suo ministero, ma ha alzato il telefono per parlare con una redattrice dell´Ansa. Dice Meir che "il fatto che il leader di quest´organizzazione terroristica (Haniyeh, ndr) si congratuli per queste posizioni (di D´Alema, ndr) non depone a favore di chi le sostiene. La pace si fa sì con il nemico, ma con un nemico che desidera la pace e la convivenza dell´uno accanto all´altro. La posizione di Hamas è nota e non è cambiata. Non sono disposti a riconoscere il diritto di Israele ad esistere e non sono neanche disposti a parlarci. I loro leader continuano ad invocare la distruzione dello Stato di Israele".
Alle parole di Meir ieri sera la Farnesina ha scelto di non reagire: l´ambasciatore Ragaglini è in missione in Marocco, D´Alema si è consultato con il suo staff e ha scelto di mantenere un basso profilo.
…

 13 marzo 2008
13 marzo 2008
![]() 13 marzo 2008
13 marzo 2008