



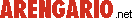
sulla stampa
a cura di G.C. - 8 marzo 2008
L'8 marzo è anche un po' mio
Vladimir Luxuria su La Stampa
C'è un filo rosso sangue che unisce la nascita della Giornata Internazionale della Donna al tragico bollettino di 4 morti al giorno sul lavoro: lo sfruttamento e la morte di tante donne nelle fabbriche. Non è importante accertare se la morte di 129 operaie dell'industria tessile "Cotton" a New York fu causata dal doloso incendio appiccato dal datore di lavoro per punirle di aver scioperato, quello che è certo è che con la rivoluzione industriale la donna fu scandalosamente sfruttata con turni di lavoro in fabbrica dalle 12 alle 17 ore e paghe dimezzate rispetto a quelle maschili. E qui c'è un primo paradosso: la "NATURA"! Una trappola per precludere per genere molte cose alle donne. Secondo il potere maschilista la donna era troppo fragile per affrontare le gravi responsabilità di comando, però poteva essere lo stesso massacrata dal lavoro con tanti casi di morti bianche femminili neanche degne di essere riportate dalle cronache.
Le condizioni del lavoro femminile sono cambiate ma non è cambiata la disparità rispetto agli uomini: il gap per le retribuzioni nette annue tra uomo e donna è meno 3.800 euro per i dipendenti a tempo indeterminato a oltre meno 10.000 euro per gli autonomi. Il 54% del lavoro precario è donna, un rullo compressore sui diritti sindacali, un arretramento rispetto alle conquiste degli Anni 50 sul divieto di licenziare o svolgere lavori pesanti durante la gravidanza e l'allattamento. La legge 30 non prevedeva neanche tali ammortizzatori sociali con un passo indietro rispetto addirittura alle intenzioni dello stesso Biagi disattese da Maroni. Molte lavoratrici precarie desiderano essere mamme. Però rimandano l'attuazione di questo desiderio perché temono di non veder rinnovato il proprio contratto di lavoro ed è incredibile pensare che coloro che vorrebbero "santificare" i promotori del precariato siano poi quelli che blaterano al vento la difesa della famiglia e della natalità. Mi colpì molto il caso di una donna siciliana, Ivana Maugeri, sospesa dal call center Incoming perché incinta, nonostante avesse tentato di nascondere il pancione con una maglia più larga, quasi che il diventare madre rappresenti un handicap nella logica dello short-termism, il più alto profitto nel più breve tempo, dove l'assenza retribuita per maternità e allattamento rappresenta solo un costo per l'azienda e non una risorsa per la società. Mi colpì anche il caso di Raffaella, una donna licenziata dall'azienda Icp Faip a Vaiano Cremasco perché a causa della riduzione della pausa mensa di mezz'ora aveva accumulato dei ritardi per andare a prendere la figlia a scuola e dunque il "ritardo ingiustificato protratto" diventa giusta causa.
…
Se è difficile essere donna, madre e lavoratrice è altrettanto difficile trovare donne nei posti "di potere": tante donne lavorano nella scuola ma poche sono le presidi, tante donne lavorano in ospedale ma poche sono primarie, fino alla discrepanza tra elettorato attivo e passivo femminile con uno scarso 16% di elette in Parlamento e mosche bianche come ministri, al punto di esserci meritati il 63° posto nella classifica mondiale della rappresentanza femminile nei parlamenti nazionali.
Da noi l'idea di primarie tra una donna e un uomo di origine africana sembra fantascienza, come il fatto che ci sia una donna di colore, Michaëlle Jean, a ricoprire il ruolo di governatrice del Canada. L'8 marzo ripropone il tema della violenza sulle donne, soprattutto entro le mura domestiche, e la mancata approvazione di una legge sullo stalking per la prematura caduta di questo governo, il tema di una infausta legge 40 che obbligando l'impianto di tutti gli embrioni fecondati che non possono essere congelati ha provocato un vertiginoso aumento di parti gemellari e trigemini, casi di gestosi e di aborto, l'offesa di essere paragonate a un boia che inietta veleno in un carcere in Texas se si vive il dramma dell'aborto… insomma il grande tema che devono essere gli altri a decidere per te e farti sentire sottomessa perché per "natura" è così.
…
Il tema della "natura" è stato usato per negare alle donne storicamente il diritto al lavoro, allo studio, alle pari opportunità così come "contro-natura" viene bollato un rapporto affettivo omosessuale e quindi senza diritti pubblici. Dalla critica al potere maschilista, misogino e omo/transfobo è nato il movimento lesbo-gay-trans parallelamente e in simbiosi con il movimento femminista. Io sarò sempre dalla parte di chi è discriminato per genere, orientamento sessuale o identità di genere e mi auguro che questa alta battaglia non venga inquinata da più bassi argomenti di ripicche per scelte (non mie) di candidature. L'8 marzo è anche mio.
Rose
Alina Marazzi su l'Unità
L'8 marzo 1972 il cineasta Alberto Grifi, inesausto sperimentatore, stava filmando, per il film Anna, in Campo de' Fiori, a Roma, un gruppo di donne che aveva organizzato un sit-in per rivendicare l'autodeterminazione della donna, il diritto alla contraccezione, l'aborto, il divorzio, i consultori , gli asili nido e per combattere la violenza sessuale. Tra quelle donne c'era l'attrice americana Jane Fonda, allora attivista per i diritti civili. Lei e le altre fanno quadrato per fronteggiare, a parole e slogan, i poliziotti in assetto antisommossa, una testuggine tutta chiusa di scudi, caschi e manganelli. Jane Fonda se ne va, i poliziotti chiedono alle donne di sgombrare, ma loro rimangono e continuano a manifestare, a dar voce con un megafono alle loro ragioni. A un certo punto il megafono passa nelle mani di una bambina che quasi urla con voce strozzata: "noi non abbiamo paura di voi, perché siamo venute disarmate!". Il poliziotto ribatte, indispettito: "ragazze, andate sul marciapiede", una frase che suona ambigua e offensiva. Ma la bambina insiste e il commissario, assicuratosi che la star hollywoodiana abbia abbandonato la piazza, ordina la carica. I poliziotti si scagliano contro le donne e la bambina, colpendole con i manganelli sulla schiena e sulla testa. Si sente la voce di Grifi che dice al cameraman "zoomma zoomma zoomma", inquadrando una donna colpita ai fianchi.
La bambina sparisce nel vortice; noi speriamo che almeno a lei siano state risparmiate le botte. Questa sequenza è presente nel mio Vogliamo anche le rose, film che ripercorre il decennio caldo degli anni 70 proponendo la visione di filmati d'archivio, fotografie, fotoromanzi, diari, animazioni, composti in una narrazione che intreccia il personale con il collettivo, i diari di tre donne con i repertori, seguendo la felice intuizione del femminismo, quel passaggio dal personale al politico attraverso la condivisione dei bisogni, dei desideri e dell'esperienza. Oggi la condivisione delle esperienze non è più, come allora, una pratica politica. Eppure, forse, il cinema, in quanto esperienza collettiva della visione, può essere ancora un valido strumento di condivisione di umori, valori, istanze e desideri. Durante la preparazione del film, andare a scoprire le immagini negli archivi, privati e non, leggere le parole dei diari di ragazze di allora, mi ha coinvolto in maniera emotiva prima di tutto, e mi ha messo in sintonia e in relazione con quelle vite e quelle esperienze. Per me, che quell'8 marzo 1972 avevo 7 anni, andare a conoscere la storia che le donne più grandi di me avevano vissuto, quella storia collettiva di liberazione che mia madre, scomparsa proprio nel 1972, aveva mancato per un soffio, è stato un processo di riconoscimento, rispecchiamento e pacificazione con le mie origini. Un volgere lo sguardo al passato per riflettere sul nostro presente per poter immaginare un futuro. Vedendo le immagini di quella bambina in Campo de' Fiori oggi mi sono ricordata della bambina che ero io proprio in quegli anni. Degli anni 70 ricordo certe atmosfere, certi discorsi e certi tipi di donne, che allora mi colpivano perché vestite in modo diverso, magari con gli zoccoli, le gonne a fiori e i lunghi capelli sciolti. Mi ricordo che sembravano belle e allegre. Durante gli anni della scuola superiore ho sfilato anche io nei cortei dell'8 marzo, poi via via ho maturato una sorta di antipatia per questa festa, fagocitata dal mercato a trasformata in una sorta di San Valentino. Ma oggi, che ricorre il centenario dell'8 marzo, sento di dover ricambiare tutto quello che mi è arrivato, che mi ha fatto la donna che sono oggi, io che sono cresciuta beneficiando inconsapevolmente degli effetti positivi del movimento delle donne e delle lotte delle femministe.
…
La coscienza dell'odio
Lucio Caracciolo su la Repubblica
In Medio Oriente i pessimisti hanno quasi sempre ragione. L´orrendo attentato di ieri sera a Gerusalemme conferma lo scetticismo di quanti hanno sempre pensato che il "processo di Annapolis" fosse fumo. L´ennesimo esercizio diplomatico-mediatico totalmente estraneo alla realtà del terreno. E la realtà è che Israele si appresta a celebrare il sessantesimo anniversario della fondazione sotto il fuoco degli attentati nel cuore della sua capitale, dei razzi lanciati da Gaza verso Ashkelon e dintorni, delle incursioni terrestri contro la Striscia appena abbandonata e subito conquistata da Hamas. Se non è guerra aperta, poco ci manca.
Il Muro non basta a fermare il terrorismo palestinese. Non vi sono misure di sicurezza che possano garantire l´impenetrabilità di Israele. Né d´altra parte si può immaginare che Gerusalemme accetti di convivere con l´Hamastan alle sue porte. I leader israeliani sono alle prese con l´incompatibilità dei loro due obiettivi strategici: consolidare Israele come Stato degli ebrei e mantenere il controllo dei Territori palestinesi.
Il primo precetto nasce dal vincolo demografico: nel giro di pochi anni la somma dei palestinesi abitanti a Gaza e in Cisgiordania, più gli arabi israeliani, sarà nettamente superiore al totale degli ebrei. Se manterrà la presa su Giudea e Samaria, Israele rischierà di scivolare verso lo Stato binazionale. Un´improbabile macedonia arabo-ebraica che annienterebbe l´opera di generazioni di sionisti. Il Grande Israele è la morte di Israele. Lo sanno bene anche gli ultranazionalisti, per i quali occorre costringere i palestinesi ad arrendersi all´idea che il loro Stato si farà, semmai, oltre il Giordano. Ipotesi piuttosto avventurosa, quanto meno perché prevede un biblico trasferimento di popolazioni, oltre al crollo del regime di Amman.
La seconda necessità deriva dalla coscienza dell´odio accumulato nei palestinesi, non importa di quale colore politico o religioso, dopo le umiliazioni e le vessazioni subìte dal 1948 a oggi. Una rabbiosa disperazione che induce i propositi più efferati, e sta radicando l´antiebraismo in modo indelebile nella popolazione araba della regione. Ma nessun esercito – tanto meno lo Tsahal attuale, assai meno motivato e ardimentoso di quello dei pionieri – può tenere in eterno sotto il proprio assoluto dominio una popolazione nemica. Più passano gli anni, più traspare la demoralizzazione di ufficiali e soldati costretti a fare i secondini di un popolo che non li tollera, anche se li teme.
Sicché i leader israeliani inclinano periodicamente verso l´una o l´altra priorità, senza potersi o volersi decidere. In più, oggi tutti sentono odore di elezioni e si profilano di conseguenza. A cominciare da Barak, che tiene molto a conquistarsi sul terreno di Gaza la fama di neo-falco. Per finire con Olmert, il più impopolare premier della storia dello Stato ebraico, che non vorrebbe essere ricordato dai posteri per tale primato, dopo aver già perso l´ultima campagna di Libano.
Sul fronte palestinese il quadro è ancora più sconfortante. Un popolo senza capo. Allo sbando. Abu Mazen è figura patetica, incapace di affermare una parvenza di autorità oltre il perimetro del suo quartier generale (anzi nemmeno in quello). I leader di Hamas – un´organizzazione sempre meno coesa, attraversata da lotte di clan e segnata dalle influenze esterne – sono asserragliati nella gabbia di Gaza e non riescono a uscirne. L´unico leader carismatico che potrebbe forse riunificare il campo palestinese, Marwan Barghuti, è ristretto nelle carceri israeliane, dove peraltro riceve un trattamento di riguardo: gli israeliani si riservano di giocare la carta Barghuti all´ultimo momento, se mai decideranno di aprire un serio negoziato di pace con il nemico. Per ora, non pare. Comunque, senza un interlocutore non si può trattare.
…
In un altro momento, gli Stati Uniti avrebbero potuto esercitare una certa pressione su entrambi i contendenti, soprattutto sui loro amici israeliani. Ma oggi Bush non ha l´autorità per dirimere la disputa. E l´opinione pubblica americana è concentrata sulle elezioni di novembre. Bisognerà probabilmente attendere il verdetto di quel voto per sperare che da Washington un nuovo, autorevole e coraggioso presidente si decida a smentire i pessimisti, imponendo quella pace che i belligeranti, oggi, non riescono nemmeno a immaginare.
Zapatero e la sfida terrorista
Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera
Ha dovuto cambiarsi d'abito e rinunciare al comizio finale, proprio come l'altra volta. Nel marzo 2004 il terrore islamista diede a Zapatero una vittoria inattesa. Domani il terrore basco può rendere ancora più netto un successo annunciato da tutti i sondaggi, o capovolgere il verdetto. Soltanto la notte prima, al palazzo olimpico di Barcellona gremito di 40 mila militanti, Zapatero sorrideva in maniche di camicia mentre Felipe Gonzalez comiziava sull'Eta "che non è mai stata debole come ora, ma grazie alla destra non è mai stata tanto citata come ora". Ieri Zapatero è dovuto rientrare a Madrid in elicottero dall'Andalusia dove si era portato nel frattempo, ha preso il lutto – giacca nera, camicia bianca, cravatta scura –, raggiunto la Moncloa, sede del governo, e annunciato la morte politica dell'Eta. Per la seconda elezione consecutiva, la Spagna vede la campagna elettorale interrotta dal terrorismo. Stavolta però non è sull'azzardo iracheno di Aznar che giudicheranno gli elettori, ma sul "socialismo amabile " di Zapatero.
Il dialogo con l'Eta, l'apertura al nazionalismo basco non sono aspetti marginali della sua politica. Sono anzi conseguenze inevitabili. Bisognava sentirlo il premier, nell'ultimo comizio — in quella Catalogna che si è data uno Statuto in cui si definisce "nazione" —, ripetere le parole chiave di quattro anni di governo: convivenza, integrazione, riconoscimento delle diversità e delle identità che compongono la Spagna. Lo stesso principio che gli ha ispirato scelte discusse più all'estero che in patria — come il matrimonio omosessuale —, la stessa attenzione alle minoranze, il medesimo spirito irenico, pacificatore, tollerante, in una parola "amabile", l'ha indotto a infrangere il mito castigliano del centralismo, a teorizzare la "Spagna plurale", a cercare la pace con i separatisti.
Zapatero si è illuso di potersi avvicinare agli estremisti baschi con lo stesso animo insieme scaltro e generoso con cui ha nominato 9 ministri donna su 18, ha stabilito che i transessuali possano cambiare sesso all'anagrafe anche senza passare per la clinica, e ha portato con sé per tutta la campagna elettorale un gruppo entusiasta di sostenitori sordi, che hanno inventato un segno (l'indice ad arco sopra l'occhio, a mimare un sopracciglio arcuato proprio come il suo) divenuto simbolo universale di Zapatero e della forza amabile fattasi ieri — forse al momento giusto, forse troppo tardi — brusca, decisa, ferma.
Era stata l'Eta a proporre la tregua. Dieci giorni dopo la strage islamica dell'11 marzo, una settimana dopo la vittoria del Psoe, i baschi si fanno vivi con un comunicato al quotidiano Gara,
offrendo al nuovo premier una trattativa. Zapatero risponde ufficialmente di no, ma in cuor suo decide di andare a vedere le carte, pensa di potersi fidare, e un anno dopo ottiene dalle Cortes il via libera al negoziato. Offre parecchio: legalizzazione del braccio politico dell'Eta, che non si chiama più Batasuna ma Anv, Azione nazionale basca; liberazione graduale dei prigionieri; riconoscimento del principio di autodeterminazione, che consentirà ai baschi di scegliere il proprio destino.
Il 29 dicembre 2006, Zapatero si lascia andare a una delle ingenuità che gli vengono rimproverate: annuncia che le cose si mettono bene, e "tra un anno staremo meglio". Il giorno dopo l'Eta alza la posta, fa esplodere una bomba che sventra il terminal 4 dell'aeroporto di Madrid, da poco inaugurato, uccide due ecuadoregni e decreta il fallimento del premier. La tregua è infranta. I terroristi fanno saltare l'auto di un dirigente socialista ferendo la sua guardia del corpo, poi nascondono una bomba sul percorso di re Juan Carlos, quindi uccidono due agenti in Francia. Ieri, per la prima volta in quarant'anni, colpiscono alla vigilia delle elezioni. Zapatero e Rajoy rinunciano al comizio finale, partono per Mondragon, il paese dell'agguato — dove l'Anv legalizzato da Zapatero è al governo — e chiedono agli spagnoli di decidere senza farsi condizionare. Né hanno elementi per capire quale influenza avrà stavolta il terrorismo.
…
E' possibile che il sangue sparso dall'Eta (Euskadi Ta Askatasuna, Terra basca e Libertà) induca gli spagnoli a stringersi attorno al governo in carica; dopotutto, la vittima è un socialista. Ma è possibile anche che gli elettori vedano nel Partido Popular la forza più intransigente verso separatisti e terroristi. Deve pensarla così la mano sconosciuta che la scorsa notte ha deposto, nei cinquantuno angoli di Madrid in cui l'Eta ha colpito dal '68 a oggi, un mazzo di fiori e una scritta: "Ricordatevene, quando andrete a votare". E' stato commemorato anche l'ammiraglio Carrero Blanco, il primo ministro di Franco che nel '73 il tritolo basco scaraventò in cima a un palazzo. Felipe Gonzalez, che allora si chiamava Isidoro e viveva in clandestinità, confessò di non aver pianto, quella volta. Zapatero aveva appena tredici anni. Il suo non è stato un tempo di guerra ma, per usare le sue parole, di "rispetto", "integrazione ", "convivenza", "tolleranza ". "Siamo il Paese al mondo più avanzato sulla strada dei diritti civili", è stata l'ultima frase della campagna che ha potuto pronunciare. Se la Spagna è davvero soddisfatta di lui, o anche solo di se stessa, il tempo di Zapatero continuerà.
Sul pullman di Walter sognando il pareggio
Fabio Martini su La Stampa
Anche alla Fiera di Forlì la sequenza si ripete secondo una sceneggiatura studiata e collaudata in 27 repliche: Veltroni scende dal pullman verde, dal marciapiede si levano urla belluine "Wal-ter, Wal-ter", lui fa l'occhietto, stringe mani e intanto, dentro la sala, parte il "Mi fido di te" di Jovanotti. E quando Veltroni entra nel catino, gli applausi scattano in serie. Quando il leader sale sul palco. Quando il leader saluta la gente. Quando dalla folla parte il grido "Sei bravo Walter!". A fine comizio, dalla regia fanno partire l'Inno di Mameli ad un volume assordante. E dopo lo sconcerto delle prime tappe (a Pescara, a Campobasso, a Isernia la gente sussurrava o taceva), da una decina di giorni più di metà del pubblico canta "Fratelli d'Italia" e qualcuno lo fa a squarciagola. Veltroni trascina e lui ci crede ancora. Eppure, da due giorni c'è una novità. E' come se un velo di sincerità avvolgesse le sue parole: "Non so dire quale sarà l'esito delle elezioni, però so che già oggi abbiamo fatto una grande rivoluzione", ha detto ieri a Forlì. E due giorni fa, a Parma, aveva sostenuto: "Questo grande partito sarà, comunque sia, o il primo partito italiano che governerà il Paese, o una delle più grandi forze riformiste di questo continente, ciò che in Italia non c'è mai stato". Proprio così. Come se vincere o perdere sia più o meno equivalente. Tanto è vero che dopo aver scandito nel dettaglio per 18 giorni sondaggi e quote dei bookmakers, ieri Veltroni ha annunciato: "Vi assicuro che non sarò preso dalla sondaggite acuta".
Da due giorni - e la novità non è trascurabile - è come se per Veltroni la vittoria sia ridimensionata a possibilità, esattamente come una sconfitta molto onorevole. Certo, soprattutto a Bologna, il leader del Pd ha ripetuto che la vittoria è vicina, eppure un certo eclettismo degli ultimi dieci giorni (radicali-teodem, Tyssen-Calearo, Umberto Veronesi e i portaborse) sembra aver interrotto la rimonta, così almeno dicono quasi tutti - non tutti - i sondaggi. Ma nella campagna di Veltroni resta un effetto-pullman, non misurabile in voti ma palpabile. Ogni volta lui gigioneggia: "Mancano ancora 82 tappe e spero di arrivare vivo!", ma il tour de force in 110 province lo ha voluto lui. Quattordici anni fa, anche se allora non si seppe, fu proprio il giovane Walter a consigliare al professor Prodi: "Sarebbe bello poter girare l'Italia con un pullman, come ha fatto Clinton due anni fa". Era il 1994 e un anno dopo proprio il pullman dell'Ulivo sarebbe diventato uno dei pochi simboli, capaci di comunicare da sinistra qualcosa all'opinione pubblica. Veltroni lo sa: negli Stati Uniti alcuni studi hanno dimostrato che se la televisione resta importante, in una stagione di virtualità il contatto personale può irradiare e moltiplicare i consensi.
I pullman in realtà sono due, perfettamente uguali. Una "omonimia" che talora produce effetti comici. C'è quello di Veltroni guidato da Vittorio, un romano "ovviamente romanista", che a 42 ha già venti anni sulle spalle "da autista, soprattutto di turisti". In ogni piazza però approda per primo il pullman dei giornalisti. Col risultato che telecamere e tifosi assediano puntualmente la porta girevole del bus sbagliato. Ieri sera, in piazza Maggiore a Bologna, una ragazza bolognese giurava al suo ragazzo: "Dietro i vetri, ho visto Walter, sta scendendo, ora lo vedrai anche tu". Ma dalla porta del pullman è sceso un silenzioso giornalista del "Sunday Times".
…
Certo, da qualche giorno Veltroni ha tirato fuori il D'Alema che è in lui, sferzando quei grandi giornali che a suo avviso deformano le notizie, guidati come sono da "cinquantacinque-sessantennni che sono arrivati ad un età nella quale cominciano a pensare che potevano fare qualcos'altro e appena vedono uno di 25 anni che diventa deputato, vorrebbero strangolarlo!".
Comitati elettorali itineranti, i pullman sono alimentati da una piccola comunità. C'è il "produttore", Lino Paganelli, che è il capo delle Feste dell'Unità; c'è Roberto Cocco, l'ex autista dei tempi del Pci e che dopo 20 anni di vicinanza è diventato l'uomo-ombra del capo, il factotum che dice la sua anche sulle questioni politiche; c'è Giovanni Lattanzi, detto "la lepre", colui che va in avanscoperta nella tappa successiva. L'altro giorno Veltroni lo ha pubblicamente elogiato ("Pensate, fa questo lavoro, nonostante si sia infortunato alla gamba"), lui dalla platea ha salutato alzando la stampella, la gente ha applaudito, ma subito dopo il palchetto davanti al leader è precipitato: "Ecco che succede a parlar bene delle persone!", ci ha scherzato su Veltroni. Che, gasato come è, da qualche giorno ha inaugurato la serie dei "comizi brillanti", all'americana, infarciti di battute sdrammatizzanti. A Parma, mentre parlava, Veltroni si è fermato con pausa da attore e si è rivolto ai fotografi che scattavano dal basso: "Fanno foto da posizioni inquietanti".
Lo strappo di Calearo
Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera
Dice il ministro rifondarolo Paolo Ferrero che l'idea di Veltroni della comunità del lavoro "è una classica idea di destra organicista, la traduzione del "siamo tutti sulla stessa barca" con i lavoratori che remano e Agnelli al timone". "Una stupidaggine", sentenzia: "La società è divisa tra chi sfrutta e chi è sfruttato". Quindi, come ha sancito Fausto Bertinotti, tra l'operaio scampato all'incendio della Thyssen e l'ormai ex presidente di Federmeccanica Massimo Calearo candidati insieme nel Pd, o è di troppo l'uno o è di troppo l'altro.
Per carità: potrebbero esserlo tutti e due. Nella prospettiva di un partito attento ai processi più nuovi della società, Antonio Boccuzzi ha oggi un altissimo valore simbolico dopo la catena di omicidi bianchi ma porterà in Parlamento la prospettiva di un lavoratore di un settore esausto e assai poco innovativo. Ed è fuori discussione che l'ex rappresentante degli industriali vicentini, che sono tra i pacchetti di mischia combattivi del Paese, è del tutto estraneo alla storia del centrosinistra. Non bastasse, ha sottolineato subito questa sua estraneità confidando di non aver "mai" votato da quella parte e infilando una serie di battute, a partire da "San Clemente" che hanno incendiato il dibattito come una torcia in un pagliaio.
Veltroni poteva trovare di meglio per aprire a quel Nord Est da decenni avaro di soddisfazioni per la sinistra? Può darsi. I mal di pancia dell'elettorato che si riconosce nel Pd sono forti. E nel rivangare un'infelice battuta del neo-capolista democratico sullo sciopero fiscale ("a mali estremi...") crescono i sospiri di dissenso di quanti avrebbero preferito che Walter puntasse (ammesso e non concesso che accettassero) su altri cavalli, forse meno ruspanti e meno in sintonia con gli umori dei piccoli e medi imprenditori veneti, ma mai vissuti come "avversari", e tanto meno come "falchi": Pietro Marzotto, Mario Carraro, Luciano Benetton.
Ma Veltroni voleva lo strappo. Netto. Carta vincente o carta perdente? Si vedrà. Al di là dei turbamenti democratici e dei veleni della destra che urla al "tradimento", le polemiche su Calearo dimostrano però ancora una volta tutti i limiti d'una certa sinistra nel capire il Nord Est. Basti leggere Liberazione.
Dove i settentrionali sono "prigionieri del benessere blindati nelle villette-bunker" contrapposti a "meridionali costretti a una nuova ondata migratoria verso i paesi di quelle villette". Uno stereotipo che fa il paio col modo in cui Alfonso Pecoraro Scanio sbertucciò le paure dei veneti dopo il massacro di Gorgo al Monticano: "Il tono del dibattito sulla sicurezza è ormai da barzelletta".
…
Sia chiaro: il mondo è pieno di sfruttati e sfruttatori. E gli uni e gli altri vanno chiamati col loro nome: sfruttati e sfruttatori. Ma questa sinistra è convinta di conoscerli davvero, i "suoi" operai del Nord Est? Dicono le tabelle delle ultime politiche che i risultati ottenuti da Rifondazione in alcuni paesi ad altissima densità operaia della provincia iper-industrializzata di Vicenza sono i seguenti: 2,7% ad Arzignano, 2,7 a Carrè, 2,0 a Rosà, 1,8 a Rossano Veneto, 1,6 a Zermeghedo... Come mai? Forse le cose sono un po' più complesse...
L'apartheid televisivo
Giovanni Valentini su la Repubblica
Abbiamo difeso con troppa convinzione in passato la famigerata "par condicio" dalla voracità mediatica di Silvio Berlusconi, per non difenderla oggi dall´avidità del duopolio politico che si appresta a dominare le prossime elezioni.
Né più né meno come il duopolio televisivo, pubblico e privato, che domina il mercato degli ascolti e della pubblicità. E forse non è azzardato ipotizzare che in realtà l´uno si sovrappone all´altro, se non addirittura che quello politico rappresentato da Pd e Pdl si fondi in qualche misura su quello etereo costituito da Rai e Mediaset.
Per quanto si possa condividere la logica del bipolarismo, e magari anche del bipartitismo, bisogna riconoscere le ragioni dei vari Boselli, Bertinotti, Casini e Di Pietro, ancor più apprezzabile quest´ultimo dall´interno del Partito democratico, quando lamentano una disparità di trattamento, una sorta di "apartheid" televisivo, che privilegia i grandi e penalizza i piccoli in questa campagna elettorale. Tanto più che la tv, sia quella di Stato sia quella privata, funziona in regime di concessione pubblica, svolge o dovrebbe svolgere un servizio pubblico, utilizzando un bene pubblico come le frequenze. Almeno fino a quando non si cambierà la legge elettorale, a colpi di referendum o a colpi di mano parlamentari, la televisione ha il dovere di rispettare e rappresentare l´articolazione dello schieramento politico, in tutte le sue declinazioni più rappresentative: non condivido quello che dici, si potrebbe ripetere con Voltaire, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo perfino in tv.
A che cosa serve la "par condicio"? A garantire la parità di accesso in televisione e quindi di visibilità a tutte le forze politiche, indipendentemente dalla rispettiva consistenza. È una legge illiberale o addirittura liberticida? Tutt´altro: è una regola elementare di democrazia, per assicurare condizioni uguali di partenza a tutti i contendenti e metterli così alla pari. Per riprendere un´efficace metafora di Eugenio Scalfari, è come la "pole position" in Formula Uno che si rinnova di circuito in circuito. Ovvero, come lo start nelle gare di velocità.
È servita, finora, la "par condicio" nelle precedenti competizioni elettorali? Certamente sì. Anche se Silvio Berlusconi è convinto che nell´ultima campagna del 2006 abbia determinato la sua sconfitta, in realtà non ha impedito la sua straordinaria rimonta. E comunque, al di là dell´esito finale, ha garantito un equilibrio nei confronti televisivi.
Ma, oggi, serve ancora la "par condicio" in questa insolita campagna elettorale, all´insegna del "fair play" reciproco, con due grandi competitors che si contendono la conquista della maggioranza e del governo e con una galassia di partiti minori destinati a restare in minoranza o magari a non superare neppure la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento? Dipende, evidentemente, dai punti di vista. E merita rispetto anche quello di Enrico Boselli, leader dei socialisti superstiti, che ha abbandonato il salotto di Porta a porta per protestare contro la discriminazione ai danni del suo piccolo partito, come pure Pier Ferdinando Casini che ha lasciato Otto e mezzo.
Nell´ottica per così dire egoistica o egemonica del Pd e del Pdl, la "par condicio" può apparire una penalizzazione, una "deminutio" o magari un´inutile perdita di tempo. Nella prospettiva di tutti gli altri partiti, invece, rappresenta appunto una garanzia minima di parità e regolarità della competizione. Altrimenti, si rischierebbe di cristallizzare i rapporti di forza in base ai risultati delle elezioni precedenti e al limite si potrebbe anche fare a meno di andare a votare di nuovo.
La "par condicio" è opportuna e necessaria per impedire che la televisione possa condizionare, direttamente o indirettamente, il responso elettorale: soprattutto in quel campo degli "indecisi" che scelgono all´ultimo momento proprio sotto l´influenza della tv. A maggior ragione lo è in un Paese come il nostro, l´unico del mondo occidentale, dove vige il duopolio televisivo e uno dei due poli fa capo ancora al leader di un partito, candidato premier di una coalizione. Anche se le sue reti e i suoi telegiornali fossero i più corretti in assoluto, questo sarebbe comunque un rischio potenziale, costituirebbe indubbiamente una posizione di vantaggio.
Non è un caso che contro la "par condicio" si siano schierati all´unisono i dioscuri della telepolitica italiana, Bruno Vespa ed Enrico Mentana, invitati recentemente a discuterne su La 7 che nel suo piccolo, per paradosso, è la vittima designata di questo sistema, un aborto di terzo polo, un convitato di pietra come nel Don Giovanni di Mozart. In funzione della politica-spettacolo, i conduttori dei due principali talk-show contestano la camicia di forza imposta alla tv dalla Commissione parlamentare di Vigilanza e condivisa dall´Autorità sulle Comunicazioni. E confondendo la regola della "par condicio" con l´abolizione – o meglio, bisognerebbe dire l´impraticabilità – dei faccia a faccia in questa congerie elettorale, tendono a tutelare il duopolio politico proprio in nome del duopolio televisivo.
Certo, chi non vorrebbe assistere a un duello virtuale fra Veltroni e Berlusconi o almeno a una simulazione di duello? Oppure a un confronto diretto Veltroni-Bertinotti o Berlusconi-Casini? E chissà che fino alla fine non si riesca a organizzarne qualcuno. Dal loro punto di vista, non hanno torto i dioscuri. Per fare audience, bisogna fare spettacolo e magari anche un po´ di casino. Tant´è che il direttore generale della Rai prende carta e penna per avvertire la Commissione di Vigilanza che le dieci conferenze-stampa previste per i vari candidati premier minacciano di costare all´azienda 40-50 milioni di euro per minori introiti pubblicitari.
Ma si può subordinare anche la politica all´audience e alla pubblicità? È consentito assoggettare la campagna elettorale alla dittatura degli ascolti? E soprattutto, è lecita una tale pretesa da parte di un servizio pubblico che incassa il canone d´abbonamento attraverso l´Agenzia delle Entrate?
…
La storia (televisiva) purtroppo si ripete. Forse è una pena del contrappasso per i partiti minori che, dopo aver osteggiato il referendum sulla legge elettorale per difendere la propria sopravvivenza, adesso la vedono compromessa dalla peggiore applicazione del "porcellum". Ma è soprattutto una pena per noi, cittadini ed elettori, sudditi di un regime tv che impone la dura legge della "par condicio", mette al bando i faccia a faccia elettorali e condanna i telespettatori al supplizio mediatico delle vecchie tribune politiche.
Se l'imprenditore è intoccabile
Bruno Ugolini su l'Unità
Il decreto legislativo per la sicurezza su lavoro è un atto doveroso, di fronte a un'opinione pubblica sbigottita, davanti alla quale scorrono ogni giorno immagini desolanti di corpi stritolati, asfissiati, maciullati. Lo sbigottimento cresce, però, quando si ascoltano i duri commenti di Luca di Montezemolo, presidente dell'Associazione degli industriali: "Inasprendo le pene non si salva nemmeno una vita umana". Una frase cinica, davvero inopportuna, immotivata.
Non voleva introdurre le sanzioni destinate a colpire quegli imprenditori che si rendono colpevoli di non aver adottato le necessarie misure atte a impedire fatti sanguinosi come quelli che hanno riempito le cronache anche degli ultimi giorni. Un rifiuto che ha dell'incredibile. Vorrebbe significare forse che non si dovrebbero perseguire e punire i responsabili della strage verificatasi alla TyssenKrupp di Torino? E perché dovrebbero crearsi queste zone d'impunità mentre per altri reati non esiste tanta benevolenza? E magari coloro che invocano queste depenalizzazioni sono gli stessi che invocano l'accanimento repressivo nei confronti di piccoli reati comuni. Scaturisce da quello sfogo una concezione dell'impresa come luogo sacro e inviolabile, non soggetto alle normali leggi di convivenza.
Nella realtà governo e sindacati hanno tentato fino all'ultimo di ridurre le tensioni con Confindustria, passando ore e ore a riscrivere e limare le varie norme. È stato tutto inutile. Il disprezzato decreto in realtà contiene anche incentivi per gli imprenditori che si danno da fare nel fornire nei processi lavorativi strumenti atti a prevenire gli "incidenti", nonché a consegnare ai lavoratori una formazione in questo campo e ponendo i loro rappresentanti al corrente di rischi e pericoli. Una rete di sicurezza che non eliminerà di colpo la piaga delle morti bianche ma potrà servire alla prevenzione, sarà un ulteriore deterrente.
…
La sortita di Montezemolo assume a questo punto anche un tono politico aspro nei confronti non della "sinistra" che chiama in causa, ma dell'intero centrosinistra. Nonché di quella prospettiva che il Partito Democratico aveva delineato col cosiddetto "Patto dei produttori". Ovverosia della volontà di lavorare per la formazione di una possibile alleanza tra forze sociali diverse, pur nella distinzione dei ruoli autonomi. Per avviare davvero una fase di riforme, di giustizia fiscale, di crescita equilibrata. Con la violenta repulsa del decreto sulla sicurezza il presidente di Confindustria si chiama fuori, gioca allo sbando. Sembra voler entrare a gamba tesa nell'agone elettorale. E finisce con l'alimentare i tanti dubbi, già abbondantemente affiorati nel popolo di centrosinistra nell'ascoltare le stupefacenti esternazioni di un altro industriale, Massimo Calearo, chiamato a un ruolo di grande responsabilità che mostra di non saper esercitare.

 8 marzo 2008
8 marzo 2008
![]() 8 marzo 2008
8 marzo 2008