





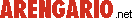
La settimana sulla stampa
a cura di G.C.
1908 – 2008 Cento di queste donne
Stefania Scateni su l'Unità
Nel centenario dell'8 marzo - qualsiasi sia l'evento che lo abbia generato; la morte delle operaie nella fabbrica di New York o uno sciopero di sole donne - e nel trentennale della legge 194, oggi cioè, ci sarebbe ben poco da festeggiare per le donne italiane. La sensazione, sgradevole, è quella di essere dentro un film in modalità fast rewind: un secolo dopo, trent'anni dopo, le conquiste delle donne, la loro libertà, la loro dignità, la loro autonomia, diritti peraltro di tutti gli esseri umani, sono oggetto di attacchi furibondi. Di questi, le violente isterie sulla fecondazione assistita, assecondate purtroppo dal centrosinistra, e l'attacco alla legge 194, sono i casi più eclatanti. Aumentano le molestie sul lavoro, aumentano gli stupri, aumentano gli "omicidi affettivi", donne uccise da mariti, fidanzati, parenti, aumentano le minorenni che vengono messe in schiavitù e costrette a prostituirsi, aumentano le ragazze che muoiono di disturbi alimentari, aumentano le bambine che guardano alle veline come modelli di vita e di stile. Dietro, o sopra, tutto questo c'è il ritorno del "padre-padrone", della sua protervia, delle sue leggi e del suo sguardo. Che diventa l'unico ammesso.
Vogliamo invece festeggiarlo questo otto marzo vecchio di un secolo, e lo facciamo all'insegna della trasmissione matrilineare, della capacità femminile di comunicare generazione dopo generazione la propria sapienza (come si diceva un tempo): ci sono molte giovani che hanno raccolto l'eredità del femminismo declinandola al presente. Collettivi di donne e singole donne. Come Alina Marazzi, che ha sentito il bisogno di ricostruire in uno splendido film, Vogliamo anche le rose, la storia delle lotte femministe. A questo filo ritessuto che corre tra il passato e il presente dedichiamo questo giorno.
Gli schiavi italiani negli archivi segreti di Hitler
Marco Ansaldo su la Repubblica
 |
Sul placido viale prussiano ancora aggredito dal gelo invernale, il numero 5 della Grosse Allee ospita l´International Tracing Service, organismo della Croce rossa internazionale, e colossale centro di raccolta dei crimini del Terzo Reich. Qui, e negli edifici intorno alla lunga via alberata, si snodano 26 chilometri di schedari e 50 milioni di documenti. Riguardano 17,5 milioni di persone perseguitate sotto il nazismo.
Un materiale vastissimo, e in qualche caso ancora informe, recuperato dagli Alleati setacciando 7 mila sedi fra Lager, posti di polizia, industrie di guerra, e per decenni oggetto di una forte polemica internazionale a causa della "sensibilità" delle informazioni contenute. Alcuni paesi si sono a lungo opposti all´apertura in nome del diritto alla privacy delle persone coinvolte. L´"archivio dell´orrore" permette infatti per lo più una ricerca nominativa sugli uomini, le donne, i bambini inghiottiti dalla tragedia nazista, e non quindi per tema o per argomento, benché dalla copiosa documentazione ricostruibile nelle carte personali di ognuno risultino evidenti i piani di sterminio, le strategie dei gerarchi, le persecuzioni sui deportati, gli esperimenti medici condotti.
Gli uomini di Hitler tenevano infatti nota in modo scrupoloso e quasi maniacale dei loro atti. E il recente accordo raggiunto a Berlino fra le 11 nazioni tecnicamente proprietarie dell´archivio (Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Israele, Italia, Germania, Francia, Olanda, Polonia, Grecia e Lussemburgo) ha permesso infine l´avvio delle ricerche, dopo decenni in cui questi fascicoli erano rimasti chiusi a chiave, consultabili solo dai congiunti più stretti dei perseguitati.
Le silenziose stanze dell´istituto, dove impiegate gentilissime scorrono trasportando faldoni voluminosi, è un tesoro di informazioni in cui ogni studioso vorrebbe tuffarsi, e pescare perle altrove difficilmente reperibili. Cartelle nominative, effetti personali, mappe, disegni, grafici, fotografie, microfilm, schede, libri, quaderni, bozze, annotazioni, oggetti vari. Un mare di documenti in grado di poter aggiungere nuovi elementi a pagine di Storia note ma ancora fresche, con protagonisti e vittime in alcuni casi tuttora in vita.
Gli interminabili elenchi di Zwangsarbeiter conservati nei dossier - adesso di diretta provenienza tedesca - potrebbero ad esempio riaprire l´annosa questione dei risarcimenti per coloro che in Germania furono costretti alla condizione di lavoro schiavile. Alfred Krupp, erede della dinastia di famiglia durante l´epoca del Reich, fu condannato dal tribunale di Norimberga nell´apposito "Processo Krupp", a causa degli abusi operati nelle sue fabbriche. La pena fu in seguito annullata. Ma oggi sono appunto i grandi gruppi tedeschi a temere di più quel che emerge dai sotterranei dell´immenso archivio nazista, nonostante la Germania consideri la questione come chiusa.
 |
Un argomento, quello dei lavoratori forzati, discusso per decenni e ancora irrisolto. Dopo la caduta di Mussolini e la rottura da parte dell´Italia del patto stretto con Berlino, nel luglio 1943, le SS disarmarono, in poche settimane, le 18 divisioni che si trovavano nell´Italia del nord e le 38 ripartite fra quella zona e i Balcani. I soldati che si dichiararono non disposti a continuare a combattere con i tedeschi, la maggior parte, più di 600.000 secondo alcune stime, furono deportati in Germania dove vennero classificati prima come prigionieri di guerra (Kriegsgefangener), poi come internati militari italiani (Imi), categoria ignorata dalla Convenzione di Ginevra sui prigionieri, per poterli così dislocare senza controlli "a sostegno delle prestazioni".
Il 28 febbraio 1944 il Comando supremo della Wehrmacht ordinava: "Solo una prestazione soddisfacente dà diritto a razioni giornaliere di cibo. La razione deve essere quindi differenziata secondo la prestazione. Nel caso di una prestazione insoddisfacente, deve essere ridotta a tutta l´unità di lavoro, senza tenere in considerazione il singolo volenteroso. Il capo del Comando supremo della Wehrmacht chiederà ragione a ogni superiore che non agirà con conseguente severità di fronte a una scarsa prestazione lavorativa e disciplina degli Inter. Mil. Ital. ".
Già dopo poche settimane molti dei lavoratori forzati si trovarono in condizioni di vita pessime. In tre mesi, la perdita di peso media era di 9 chilogrammi. Proprio alla Krupp, nella primavera del 1944, circa un quarto degli italiani era morto per inedia, tubercolosi, o violenza. Con gli accordi Hitler-Mussolini del 20 luglio gli internati vennero smilitarizzati d´autorità dalla Repubblica di Salò, dismessi dagli Stalag e gestiti come lavoratori liberi civili. Si trattava in realtà di forzati veri e propri, benché con l´etichetta del lavoro civile volontario/obbligato. Alla fine della guerra gli ex-Imi registrati come "operatori liberi" furono ben 495 mila.
Ma se le liste di Zwangsarbeiter ora riunite a Bad Arolsen narrano una vicenda che riguarda ancora dei sopravvissuti, altri documenti presenti nell´archivio rappresentano invece delle vere e proprie pietre tombali. Come dimostra il logoro, tozzo, sfilacciato Totenbuch, il Libro dei morti di Buchenwald. Un oggetto che fa quasi tremare al solo tenerlo fra le mani. Davanti, la dura copertina di cartone nero. Dentro, un triste, interminabile elenco: nomi compilati in modo preciso, giorno per giorno, con le date, la provenienza, la causa della morte. In fondo, gli orari dei decessi, annotati persino nei minuti, h. 0.55, 1.45, 4.10, 5.20. Nelle baracche si moriva soprattutto la notte, nelle ore più rigide e buie.
La meticolosità dei nazisti toccava punte di efficienza altissima.
…
Dalle cartelle personali saltano fuori schede verdi con le arcate dentarie di ciascun detenuto. In rosso risaltano le carie, i denti mancanti, gli interventi fatti. Altre carte portano l´intestazione Laeusekontrolle, "controllo dei pidocchi": per ogni detenuto veniva segnato il proprio numero e la quantità di insetti trovati dopo l´ispezione. "In tutto 11 pidocchi su 6 internati", è scritto in fondo. Il professor Udo Jost, storico e capo dipartimento degli archivi, profondo conoscitore della storia del nazismo attraverso i documenti diretti che per anni ha studiato qui, inforcando gli occhiali indica una parete della sala. Dentro ci sono gli effetti personali degli internati: anelli, orologi, portafogli, crocifissi, braccialetti, portaciprie. Molte le foto personali rimaste: il giorno delle nozze, i figli, i genitori, la villeggiatura. Immagini in bianco e nero in ottime condizioni. Sembrano le fotografie di un qualsiasi album di famiglia. Ma nessun parente le ha quasi mai ritirate.
Nella grande sala, armadi colossali che fluttuano su binari mobili come quelli di un treno, portano impressi nomi incancellabili: Auschwitz, Bergen-Belsen, Breedonk, Buchenwald. Camminando per la stanza la lista continua, Colditz, Dachau, Esterwegen, Flossenburg…
Dentro l´armadio di Mauthausen, l´altro Totenbuch originale, stessa fattura spettrale, contiene la lista dei 48 ebrei "uccisi - come si legge sulla riga del primo giustiziato (per gli altri basteranno delle semplici virgolette) - su ordine dell´Ufficio di sicurezza del Reich". Era la mattina del 20 aprile 1942, data di nascita di Adolf Hitler. Un regalo di compleanno per il Fuehrer. I minuti esatti della morte, h. 11.00, 11.02, 11.04, 11.06, 11.08, 11.10 e così di seguito, scandiscono perfettamente i tempi di condanna dei giustiziati. Poi uno stacco di qualche ora, e altre esecuzioni fino alle 19.
Attacco a un simbolo
Arrigo Levi su La Stampa
 |
L'attentato alla Yeshivà, o scuola rabbinica di Kiriat Moshè, a Gerusalemme Ovest (la nuova Gerusalemme ebraica sorta al di fuori delle mura della "Città Santa") è un attentato di natura più "militare", per il modo in cui è avvenuto, che terroristica.
Non c'è stato un kamikaze votato al sacrificio, che si sia fatto saltare in aria per raggiungere il suo paradiso, ma una pattuglia armata, che ha scelto però, come bersaglio, non una postazione militare israeliana ma una scuola rabbinica, degli studenti intenti, come vuole l'antica tradizione, a meditare e dialogare sulla loro fede.
Ambedue le caratteristiche accentuano e mettono in maggiore evidenza quello che è stato lo scopo di questa impresa, di cui non conosciamo con certezza, nel momento di scrivere, i diretti responsabili. Ma l'obiettivo che si è voluto raggiungere è più che evidente: mandare a monte le speranze di una ripresa del negoziato di pace che dovrebbe condurre, entro l'anno (ma chi può ancora sperarlo?) alla nascita di uno Stato palestinese accanto allo Stato d'Israele.
Il lancio di missili sempre più potenti e precisi contro città israeliane dalla striscia di Gaza, che Israele aveva evacuato per volontà di Sharon, capace d'imporre con la forza militare l'esodo di migliaia di coloni, ed ora l'attacco militare alla scuola rabbinica, esprimono una linea politica ben precisa: impedire un negoziato capace di condurre alla nascita di uno Stato palestinese che firmi un trattato di pace con lo Stato d'Israele.
 |
Questa è la linea di Hamas, è la linea dei fondamentalisti islamici libanesi, è la linea dell'Iran, è la linea di Al Qaeda: di tutti coloro, insomma, che nel mondo arabo e islamico dichiarano la loro aperta intenzione di cancellare lo Stato ebraico dalla faccia della terra: di cacciare gli Ebrei dalla "terra dell'Islam": come ne furono cacciati, in un spazio di tempo di due secoli, i regni crociati. Che questa non sia la volontà del popolo palestinese non ha, per gli autori di questo attacco, alcuna importanza. Inseguono una loro chimera, una loro visione della storia e del mondo, che può a noi apparire assurda: ma tante tragedie del passato, anche recente, anche nella nostra Europa, sono nate da fatali visioni, altrettanto assurde.
È a tutti ben noto (lo confermano innumerevoli sondaggi, effettuati da istituti di ricerca della Palestina) che una maggioranza dei palestinesi residenti sia nella West Bank che nella striscia di Gaza è, da molto tempo, favorevole alla pace con Israele: che vuol poi dire alla nascita di un loro Stato, come avrebbe voluto la risoluzione dell'Onu che permise, nel maggio del 1948, la nascita di uno Stato d'Israele, che l'aggressione degli Stati arabi confinanti, che annunciavano l'intenzione di compiere una strage senza precedenti nella storia, non riuscì ad impedire. Per Israele, la creazione di uno Stato palestinese è importante, come suprema e definitiva garanzia della sopravvivenza del loro Stato, non meno di quanto lo sia per i Palestinesi: di ciò è convinta una maggioranza degli Israeliani, come dei Palestinesi - che vorrebbero diventare finalmente padroni del loro destino di popolo.
La scelta, come obiettivo dell'azione che ha provocato la strage di Gerusalemme, di una scuola rabbinica, è chiaramente finalizzata ad accrescere la resistenza al negoziato di pace di quella parte della popolazione israeliana (particolarmente forte nell'elettorato "religioso") che teme che il negoziato, e gli accordi a cui esso potrebbe portare, accrescano, e non riducano, la minaccia alla sopravvivenza del loro Stato.
Per impedire la pace, si moltiplicano le aggressioni a Israele. Si vuole mettere così in moto un meccanismo di azione-reazione quasi inevitabile e inarrestabile. E addio speranze di pace. Quale Stato potrebbe accettare, senza dare una qualche risposta anche militare, un continuo lancio di missili contro le proprie città da un territorio confinante? Trovo un po' ipocrita la distinzione fra una reazione "eccessiva", da condannarsi, e una reazione commisurata alla minaccia, che sarebbe giustificata. Ricordate un missile libico lanciato tempo fa contro l'isola di Lampedusa? Che cosa avrebbe fatto l'Italia se a quel lancio ne fossero seguiti molti altri, giorno dopo giorno, raggiungendo obiettivi sempre più vicini al cuore del Paese?
Confesso di non sapere se sia possibile interrompere questo tremendo giuoco di guerra, continuamente rinnovato da chi vuole che non si faccia la pace, da chi ha per solo scopo la distruzione d'Israele, quale che sia il costo per il popolo palestinese. È troppo ingenuo l'auspicio che intervenga sul terreno, che vuol poi dire a Gaza, una forza militare d'interdizione autorizzata dalle Nazioni Unite, capace d'impedire ulteriori aggressioni contro Israele, e la reazione militare israeliana che ne consegue?
C'è, anche grazie all'iniziativa italiana, una forza militare presente, finora con efficacia, nel Sud del Libano. Perché non a Gaza?
…
La sfida della Chiesa nella Spagna che vota
Guido Rampoldi su la Repubblica
 |
Tre anni di scontri intermittenti e sregolati, riesplosi in questa campagna elettorale. Ma a fidarsi dei pronostici, ieri mattina i 78 vescovi spagnoli avrebbero stemperato il lungo conflitto con il governo socialista confermando alla presidenza della Conferenza episcopale Ricardo Blazquez, un sacerdote gradito a Zapatero, o almeno non sgradito quanto quei prelati che, aveva lamentato il premier poche ore prima, "hanno superato limite".
Però alle undici di ieri Blazquez era grigio come la sconfitta e nella poltrona che avrebbe dovuto occupare sedeva, vincitore, un cardinale dai lineamenti pietrosi e dalla mascella volitiva, campione di una curia fortemente avversa a Zapatero. Antonio Maria Rouco Varela, arcivescovo di Madrid e buon amico del papa, cominciò a "superare il limite" due anni fa, quando fu tra i promotori di una grande manifestazione contro il governo socialista e la legge che istituiva i matrimoni omosessuali. Lo ricordo nell´occasione marciare impettito dentro una folla plaudente e cameratesca: un capopopolo, più che uno di quei principi della Chiesa di cui il Museo del Prado, lì vicino, ospita i volti solenni circonfusi di stoffe purpuree. L´ultima volta che si è esibito nel ruolo, in dicembre, partecipava ad una rumorosa dimostrazione contro il governo, accusato di attentare alla democrazia e ai diritti fondamentali degli spagnoli. Zapatero ha preso nota. Se domenica vincerà le elezioni, così come vogliono i sondaggi, metterà "i puntini sulle i e ogni cosa sarà più chiara", ha minacciato. Più esplicito, un alto dignitario del partito socialista, Josè Blanco, ha invitato rudemente la Chiesa "a procedere verso l´autofinanziamento, anche se è difficile perché ogni volta ha meno seguaci".
Considerando gli antefatti, la Spagna ha buone probabilità di diventare il laboratorio di un conflitto che non potrà non riverberarsi sulle convinzioni instabili di altre sinistre moderate, oggi equamente divise tra l´ammirazione per Zapatero e l´orrore per gli attriti tra laici e clero. Per capire come nasca e possa evolvere il duello tra il premier e il cardinale converrà innanzitutto tener presente che anche qui la Chiesa ha molte facce. Perfino i conservatori non si assomigliano.
Il ratzingeriano Rouco Varela è molto diverso dal suo antagonista Ricardo Blazquez, vescovo di Bilbao.
Il primo non avrebbe mai detto quel che disse il secondo nel novembre scorso, poche settimane dopo la beatificazione di 498 religiosi uccisi dai repubblicani. Anche la Chiesa, suggerì quel giorno Blazquez, deve "chiedere perdono" per quel che fece durante la Guerra civile (si schierò dalla parte di Franco, proclamò la "crociata", di fatto incitò allo sterminio del nemico, e terminato in conflitto, assistette serenamente al massacro di almeno 50mila prigionieri).
"Dimenticare le migliaia di maestri, sacerdoti, operai, dirigenti e politici che morirono vittime della repressione franchista - argomentò Blazquez - non solo è un´ingiustizia ma rende impossibile la riconciliazione e la pace". Bisogna invece riconoscere che "martiri" sono sia "coloro che muoiono per Gesù Cristo e in difesa della religione cristiana", sia coloro che "muoiono o patiscono molto in difesa di altri credi, convinzioni o cause".
Queste parole audaci non devono essere piaciute ai porporati che da giovani non furono ostili a Franco, e comunque mai come lo sono oggi a Zapatero.
Furono contigui alla dittatura non tanto o non solo per una simpatia ideologica, quanto per convenienza: in quegli anni la Chiesa godeva di una condizione di assoluto privilegio. Era la religione di Stato, l´unica riconosciuta fino al 1967, quando proprio il Vaticano obbligò un riluttante Franco ad autorizzare il culto protestante. All´epoca i luterani erano quarantamila. Oggi sono 1,4 milioni. I musulmani 1,5. I mormoni, i buddisti, decine di migliaia, E ciascuno di questi culti chiede con ragione di accedere agli stessi diritti tuttora riservati alla Chiesa spagnola. Quest´ultima riceve dallo Stato 4310 milioni (in pagamento di servizi sanitari e sociali, salari per gli insegnanti di religione, custodia del patrimonio artistico e immobiliare) ed è l´unica fede autorizzata a ricevere dal contribuente una quota dell´Irpef, aumentata sensibilmente proprio dal governo Zapatero (adesso il 7 per mille, contro il 5,2 precedente). In altre parole lo Stato riconosce alla Chiesa una centralità che in termini freddamente statistici comincia a non aver più ragion d´essere.
Infatti non solo la presenza degli immigrati, oggi un decimo della popolazione spagnola, comporta richieste di diritti paritari per ciascuna fede, ma il cattolicesimo conosce, come ovunque in Europa, un declino numerico. Dal 2001 al 2005 sono diminuiti i sacerdoti (meno settecento), i seminaristi (da 1797 a 1481), i matrimoni celebrati in chiesa (di un quinto), i contribuenti che devolvono la quota dell´Irpef alla Chiesa cattolica (dal 39,1% al 32,9%), i figli nati da coppie sposate (oggi 71%, e dal 2005 la percentuale di figli nati da madri nubili aumenta ogni anno di un decimo). Se non bastasse, la contiguità tra una parte della curia e il franchismo ha generato un anticlericalismo forte, in genere giustificato dalla storia ma talvolta pretesto per discriminare, con la supponenza di cui siamo capaci anche noi atei, tanto il pensiero quanto gli studiosi cattolici.
Ad una Chiesa già spaventata dalla sindrome dell´assedio e dall´angoscia del declino, Zapatero ha ventilato una serie di riforme su questioni legate alla sessualità e all´etica che gran parte della curia considerava di propria (quasi esclusiva) competenza. In seguito il premier ne ha lasciate cadere alcune e ne ha mitigate altre, sia perché troppo controverse, sia nel tentativo di trovare un compromesso con la Conferenza episcopale.
...
Trent´anni fa, quando un altro governo socialista introdusse il divorzio, la Chiesa proclamò che di lì a poco il matrimonio sarebbe caduto in disuso: non pare che la profezia si sia avverata.
…
Meno controverso è che tra il pensiero laico e il pensiero cattolico esistano, oltre a infinite comunanze, anche differenze non facilmente riducibili. Come gestirle? Il modello spagnolo non offre risposte. Ma con la sua conflittualità, almeno rende quelle differenze riconoscibili. Per stare alla metafora di Navarro Vals ("Tra lo spirituale e il temporale c´è una frontiera delicata. E dove c´è una frontiera capitano incidenti di frontiera"), la Spagna odierna rende visibile quel confine.
In questo la Spagna è molto diversa dall´Italia. Qui il papa non sbuca ogni sera nel tg delle reti pubbliche e non è invitato a inaugurare anni accademici. "Laicista" non è insulto, nessuno spaccia per sopraffazioni le educatissime inquietudini laiche per certe invadenze curiali, e se un Ruini convocasse una manifestazione non accorrerebbero i quattro quinti della politica nazionale. Se però provate a cercare il pensiero cattolico in una libreria italiana è improbabile che troverete molto di più che i Socci e i Biffi, la miracolistica di Medjugorie, l´islamofobia e l´idolatria di Pietralcina. Andate invece al secondo piano della Casa del Libro, la più grande libreria madrilena, e avrete l´impressione di un cattolicesimo vivo, dinamico, interessante.
Troverete anche un libro che in Italia avrebbe vita grama, "La puttana di Babilonia", il nomignolo poco gentile con cui gli albigesi chiamavano Santa Romana Chiesa. Ma in fondo anche questo anticlericalismo spinto evita al cattolicesimo la sorte del cattolicesimo italiano, condannato all´indifferenza e all´indistinto dall´unanimismo ipocrita della politica.
In Spagna la politica parla un linguaggio più schietto, perfino crudo. Lo scontro non è mascherato. Le reazioni sono forti. Non accadeva da quarant´anni che i vescovi spagnoli negassero la rielezione al presidente della Conferenza episcopale, come invece è successo ieri. Lo sconfitto, Ricardo Blazquez, probabilmente ha pagato l´irruenza di quei dignitari socialisti, incluso Zapatero, che nelle ultime ore avevano preso di petto l´ala belligerante dell´episcopato con parole quantomeno intempestive. Peccato, perché Blazquez si era presentato con una frase programmatica che probabilmente indica il metodo per sminare il confine tra lo spirituale e il temporale: "La Chiesa non vuole imporre la fede cristiana né la morale cattolica, la offre con franchezza e con coraggio a tutti".
Scienza, il nuovo tabù
Antonio Carioti sul Corriere della Sera
Lo scientismo nuoce alla cultura scientifica. Lo afferma il matematico Giorgio Israel, firma del Foglio, nel libro Chi sono i nemici della scienza? (Lindau, pp. 346, € 21,50), in cui accusa la sinistra orfana del marxismo di aver abbracciato una fede acritica nel progresso tecnologico, che la porta a scomunicare chiunque voglia fissare dei limiti alla manipolazione della natura e della stessa vita umana. L'attacco è rivolto a studiosi portatori di concezioni molto diverse: alcuni ritengono che la scienza abbia un valore oggettivo, altri la considerano una fonte di conoscenze provvisorie e relative. Ma tutti costoro, secondo Israel, "marciano separati per colpire uniti", perché sono compatti nel contrapporre nettamente scienza e religione, così come nel respingere ogni critica al darwinismo.
Gli interessati non gradiscono. Giulio Giorello, chiamato in causa, respinge le accuse di Israel: "Non ho mai pensato che le verità scientifiche siano fondate sulla roccia o che gli scienziati debbano decidere tutto. Ma l'Italia non è minacciata dallo scientismo. Vedo piuttosto avanzare pregiudizi antiscientifici che si nutrono di spiritualismo e di timore per gli aspetti più emancipativi delle biotecnologie. Un'offensiva cui l'ex comunista Israel si unisce con uno zelo da prete spretato". Analoga la reazione di un altro filosofo della scienza, Telmo Pievani: "Israel dipinge uno scientismo caricaturale. Nessuna persona ragionevole pensa che le tecnoscienze debbano correre a briglia sciolta senza vincoli, specie nel campo più delicato della biogenetica. Tutti concordano, per esempio, sul divieto di far nascere bambini per clonazione".
Vi è tuttavia tra gli studiosi chi condivide i timori di Israel per il predominio delle tecnoscienze. Così Lucio Russo, autore del saggio Flussi e riflussi (Feltrinelli): "C'è una biforcazione crescente tra la ricerca scientifica teorica e quella puramente tecnologica. Le applicazioni concrete hanno sempre svolto una funzione essenziale di stimolo alla scienza, ma non credo sia giusto invocare la libertà di ricerca come giustificazione ideale del lavoro di messa a punto di qualsiasi prodotto o tecnica per fini commerciali. Esistono casi in cui l'opportunità di sviluppare e applicare una determinata tecnologia non dovrebbe sfuggire a un giudizio morale, che andrebbe dato caso per caso".
In difesa della ricerca si schiera Enrico Bellone, direttore della rivista Le Scienze, anch'egli preso di mira da Israel: "Sulle biotecnologie circolano molte sciocchezze. Per esempio le cosiddette chimere, presentate dai media come creature mostruose, sono uno strumento prezioso per capire come funzionano le cellule e trovare una cura a malattie terribili come l'Alzheimer. La polemica di Israel lascia disarmati perché non è argomentata. Basta vedere come stronca il mio libro L'origine delle teorie (Codice edizioni), di chiara matrice evoluzionista: non entra nel merito e si limita a proclamare che il darwinismo è dannoso". Ma davvero non si possono avanzare dubbi sulla teoria dell'evoluzione? "Bisogna distinguere — risponde Pievani — perché un conto è il dibattito scientifico sul programma di ricerca neodarwiniano, al quale si possono muovere obiezioni pienamente legittime, come quelle esposte di recente da Massimo Piattelli Palmarini sul Corriere. Ma diverso è il tentativo di screditare l'evoluzione per dare spazio a teorie di stampo religioso, come il "disegno intelligente", del tutto estranee alla scienza". Non a caso Pievani è autore, con Carla Castellacci, del pamphlet anticlericale Sante ragioni
(Chiarelettere). Ma si dichiara distante dalla "metafisica materialista" denunciata da Israel: "Ci sono studiosi, come Richard Dawkins, secondo i quali il darwinismo porta necessariamente all'ateismo. Se Israel ce l'ha con loro, sono d'accordo con lui. Infatti l'evoluzione non esclude affatto l'esistenza di Dio, ma semplicemente permette di spiegare lo sviluppo della vita sulla terra senza ricorrere a ipotesi sovrannaturali".
Giorello è sulla stessa linea: "È appena uscito, nella collana che dirigo per Raffaello Cortina, il libro Preghiera darwiniana di Michele Luzzatto, uno studioso di fede ebraica che traccia un suggestivo parallelo tra Darwin e alcuni personaggi biblici. Noi liberi pensatori relativisti siamo aperti alla cultura religiosa, ma non ci pieghiamo ad alcuna ortodossia, mentre mi pare che Israel aspiri a fare la mosca cocchiera di Benedetto XVI".
…
Mussolini visionario
Dall'architettura razionalista alla classicità autarchica
Sergio Luzzatto sul Corriere della Sera
Finita, la colossale statua di bronzo avrebbe dovuto essere alta una novantina di metri: circa il doppio della Statua della Libertà. Avrebbe raffigurato Ercole, ma un Ercole con i tratti inconfondibili di Benito Mussolini. Sarebbe stata posta dietro il podio dell'oratore in un nuovo piazzale delle adunate, destinato a sostituire Piazza Venezia nel cuore degli italiani: in tale immenso arengo del Foro Mussolini, il Duce avrebbe colloquiato alla sua maniera con mezzo milione di persone per volta, avendo alle spalle la bronzea magnificazione del suo corpo tanto speciale.
La statua sarebbe stata così grande "da far impallidire il ricordo del leggendario Colosso di Rodi", aveva spiegato a Mussolini stesso Renato Ricci, il gerarca fascista sponsor dell'iniziativa, nel marzo del 1933. Massimo dirigente dell'Opera nazionale Balilla, Ricci non si limitò a baloccarsi con l'idea dell'Ercole, nel '36 passò all'azione. Conferì la responsabilità tecnica del progetto a un giovane architetto fra i più dotati dell'epoca, Luigi Moretti: non ancora trentenne, ma già autore nel Foro Mussolini di quel capolavoro che era l'Accademia di scherma. Quanto alla statua di bronzo, Ricci ne affidò la realizzazione allo scultore Aroldo Bellini, che si mise all'opera partendo dalla testa e da un piede del Colosso.
Il cantiere della statua dovette presto interrompersi. Le ristrettezze finanziarie in cui il regime fascista venne a trovarsi fra il 1936 e il '37, dopo l'aggressione all'Etiopia e le sanzioni economiche della Società delle nazioni, costrinsero Ricci, Moretti, Bellini a rinviare sine die sia il completamento del Colosso, sia la costruzione dell'arengo. Oggi, dell'uno e dell'altro progetto non restano più che ingiallite fotografie, qualche plastico, alcuni disegni autografi di Moretti conservati all'Archivio centrale dello Stato di Roma. Documenti preziosi oltreché curiosi, parzialmente riprodotti da Paolo Nicoloso in Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell'Italia fascista (Einaudi). Frutto di un monumentale scavo archivistico, il libro di Nicoloso rappresenta il tentativo più compiuto e più riuscito di misurare la funzione dell'architettura nell'edificazione dell'"uomo nuovo" fascista. E anche, per molti aspetti, nell'edificazione dell'uomo nuovo repubblicano, se è vero che il paesaggio urbano dell'Italia odierna risulta contrassegnato da centinaia e centinaia di architetture costruite nel Ventennio: case del fascio e palazzi del governo, scuole e ministeri, uffici postali e stazioni ferroviarie, stadi e piscine, palazzi di giustizia e città universitarie, da Roma a Milano, da Bologna a Napoli, da Bolzano a Genova, da Livorno a Trieste, da Torino a Forlì...
Di questo enorme sforzo realizzativo, vera e propria trasformazione dello spazio pubblico italiano, il Duce fu molto più che un gestore distrattamente burocratico, un posatore di prime pietre o un tagliatore di nastri inaugurali: fu il protagonista assoluto e visionario, l'infaticabile artefice e il corteggiatissimo regista. Altro che la macchietta polemica trasmessa da certa vulgata antifascista, quella di un Mussolini "sfondatore" più che fondatore, capace soltanto di sventrare quartieri medievali nei centri delle città storiche o di costruire inutili città nuove nel bonificato Agro pontino. E altro che la rassicurante immaginetta forgiata da certa storiografia accademica, quella di una corporazione degli architetti sostanzialmente autonoma dalla politica del regime. La ricerca di Nicoloso dimostra, al contrario, tutta la vitalità di quella stagione architettonica, e tutta la disponibilità di quegli architetti verso il dittatore.
 |
Fu a partire dalla fine degli anni Venti che Mussolini prese a invadere sistematicamente il campo dell'architettura. Non che la sua fosse già allora una strategia stilisticamente chiara. A lungo il Duce sembrò esitare fra gli antichi e i moderni, fra l'architettura classicista e quella razionalista. Soltanto dopo il 1936, cioè dopo la guerra d'Etiopia e le sanzioni, l'interventismo di Mussolini si fece coerente nel respingere il modernismo come uno stile ignominiosamente internazionale, premiando il classicismo come la cifra definitiva di un'autarchica "romanità " ritrovata. Probabilmente, il Duce venne influenzato in tal senso dalle scelte tradizionaliste del Führer, Adolf Hitler, a sua volta soggiogato dalla personalità di Albert Speer. Certamente, il Duce volle enfatizzare i meriti di un'architettura "imperiale", cioè pugnace, armata, conquistatrice: "combattere e costruire sono per Mussolini due azioni parallele, due pilastri fondanti dell'agire in politica", scrive Nicoloso.
 |
Meglio di ogni altro architetto del Ventennio, Marcello Piacentini comprese che per il Duce l'architettura non era tanto una questione di gusto, ma una questione di potere: il potere dello Stato totalitario nel plasmare una nazione, manipolando il singolo individuo e impastandolo nella duttile creta della massa. Così, unico fra le centinaia di professionisti al lavoro nei cantieri dell'Italia littoria, Piacentini fu capace di mantenersi sempre e comunque sulla cresta dell'onda, a differenza di colleghi che pure veneravano Mussolini con una fede ben più genuina della sua. Giuseppe Terragni, per esempio: che portava al Duce una devozione sconfinata, ma che aveva il difetto di credere anche in qualcos'altro, nelle virtù concettuali del modernismo architettonico. Se il navigato Piacentini garantiva al Duce il patrimonio del suo cinismo, fu in Luigi Moretti che Mussolini riconobbe l'interprete più geniale di un'architettura compiutamente fascista. E l'enfant prodige cercò di ripagarlo da par suo. Nel 1936, mentre ragionava del nuovo piazzale delle adunate, l'arengo in fondo al quale voleva posizionare la statua di bronzo di Bellini, Moretti lavorò alla cosiddetta Palestra del Duce, nel Palazzo delle terme del Foro Mussolini. Magnifico spazio altrettanto fluido che spoglio, inaugurato nel '37, dove il mito mussoliniano veniva declinato con graffiti intorno al tema di Ercole.
Era là, nella nudità di una sala arredata unicamente con attrezzi ginnici, che il Duce avrebbe potuto e dovuto esercitarsi da solo, senz'altra compagnia che quella del suo erculeo
alter ego. Ed era là che il Mussolini in carne e ossa si sarebbe rivelato, ai suoi propri occhi, l'autentico Colosso.
…
Magnani, la prima strega
Goffredo Fofi su il Messaggero
ROMA - Di dove viene la nostra affezione al ricordo della Magnani, di cui si celebra oggi il centenario della nascita? Alla sua risata, ai suoi gesti (al modo, per esempio, con cui portava la mano destra al collo), alle sue esplosioni di gioia o di ira, al suo sbaccaja', al suo modo di sfottere e al suo modo di commuoversi, di trattare i figli e i mariti? Tra le tante ragioni, io ci metto anche, forse soprattutto, quel misto di dedizione e di rivolta nei confronti di un mondo che era (ed è, nonostante le apparenze) in cui il potere è nelle mani dei maschi (e delle loro controfigure femminili), e che è stato forse un comportamento delle donne, o di tante donne, di tutto il mondo. L'immagine della Magnani fu quella, per molti anni, di Roma città aperta ma anche di L'onorevole Angelina, di vittima nel primo film, dove si fa ammazzare dai nazisti per l'amore che porta al suo uomo, e di ribelle nel secondo, che non tollera le condizioni avvilenti in cui è costretta a far vivere i propri figli. Le parolacce che diceva "l'onorevole Angelina" ci sembrano oggi da educande al confronto con l'inarrestabile volgarità nel nostro presente, portata dai nuovi ricchi e dal loro pubblico bordello la televisione. E sì, Abbasso la ricchezza è un titolo magnanesco altrettanto forte e giusto che il precedente Abbasso la miseria, e questo già sessant'anni fa!
Dopo anni di edulcorate figure femminili – con rare eccezioni: la Calamai di Ossessione anzitutto, o la Paola Barbara, che era però un'attrice senza qualità, di La peccatrice nel cinema del ventennio fascista le donne contavano poco, erano trastullo degli uomini, borghesine slavate, maliarde scassafamiglie o orfanelle a rischio di "peccare", che andavano protette e salvate ma vietando loro l'aspirazione a qualsiasi autonomia – ecco che esplose la Magnani, e che liberò altre figure, altre realtà. Al seguito della Magnani vennero film e film dove le figure femminili erano centrali ed erano interpretate da volti e corpi nuovi, pescati magari a Stresa ai concorsi per Miss Italia, ma nuovi davvero: la Mangano di Riso amaro o la Bosè di Cronaca di un amore, la Masina di Le notti di Cabiria o la Maria Fiore di Due soldi di speranza, su su fino alla Vitti di L'avventura, alla Sandrelli di Io la conoscevo bene, alle tante eroine in movimento (emancipazioni lente, con il controcanto della nevrosi) degli anni del boom e del dopo-boom. Avevamo finalmente una galleria di donne vere, di carne e sentimenti reali, proletarie o borghesi ma anzitutto donne.
Il paradosso era quello di un cinema attentissimo alle figure femminili, e che ne creò di bellissime, dentro una società molto maschilista, che aveva concesso il voto alle donne, ma dove ancora si giustificava il delitto d'onore, si puniva l'aborto, si condannavano le "fedigraghe" e si simpatizzava per gli "sciupafemmine" perché l'uomo, si sa, è cacciatore. Ma le donne non volevano più essere gli "angeli del focolare", mamme e mogli, e neanche "peccatrici", amanti e mantenute o erogatrici di sesso dietro le "persiane chiuse", dove su ogni coito un cattolicissimo Stato percepiva la sua "marchetta"...
Il paradosso dei nostri giorni è quello di una società che si dice liberata ma che è zeppa di nuove ipocrisie che il cinema non sa più narrare, teso a consolare i già troppo consolati invece che a guardare oltre il velo delle apparenze e dei luoghi comuni.
…
Le figure femminili del cinema italiano di oggi sembrano un remake fiacco o perverso delle logiche del cinema del ventennio, e non saranno le Buy o la Ferilli a convincerci del contrario. E se dicessimo che il cinema italiano non è mai stato così maschilista come oggi, magari, estremizzando, con Moretti come fiacco remake di Nazzari? Perfino il cinema delle donne è in Italia fiacchissimo, e abbiamo dovuto aspettare Alina Marazzi perché si ragionasse sulla storia delle donne a partire dalla montagna di documenti visivi esistenti (Vogliamo anche le rose, oggi nelle sale).
La Magnani fu la prima immagine e la più forte ad aggredire quelle convenzionali e a sgominarle, cosciente in buona parte l'attrice anche se spesso prigioniera delle difficoltà a "interpretarsi", a scegliere i propri film e registi. E Roma città aperta, L'amore, Bellissima, La carrozza d'oro e Mamma Roma sono i regali che ci ha fatto, e che non ci meritiamo.
Sembra un film l'Ottocento italiano
Lea Mattarella su La Stampa
ROMA. Sdoganare l'Ottocento italiano non è un'impresa facile. Ci si prova da molto tempo a dimostrare che, in fondo, da queste parti nel momento in cui si cede il testimone di culla delle arti figurative alla Francia non si ha nulla da invidiare ai cugini d'Oltralpe. Ma gli italiani quando dipingono sono narrativi, i francesi invece sentono in maniera meno forte la necessità di raccontare e di descrivere ed esprimono una maggiore libertà, come se recitassero a braccio senza bisogno di un copione. Ora, però si può provare a fare di questo elemento caratterizzante la propria forza. È vero, i pittori italiani narrano. Ma siamo poi certi che queste storie dipinte siano diramazioni secondarie di una strada principale tracciata dalla pittura e dalla scultura franco-internazionale? I tre curatori di questa mostra, Maria Vittoria Marini Clarelli, Fernando Mazzocca e Carlo Sisi, ce l'hanno messa tutta per dimostrare che non è così. Centotrenta opere di 72 artisti italiani attivi dall'inizio alla fine del secolo, raccolti con cura tra quelli che senza esitazione possiamo definire i nostri capolavori. Insomma se, nonostante la perfetta selezione, uscendo da qui si continuano a rimpiangere Ingres e Delacroix, Corot e Monet, vuol dire che non c'è battaglia. Bisogna rassegnarsi magari a giocare in serie A, ma senza vincere mai.
Qualità elevatissima fin dall'inizio del percorso dove si incontrano gli esordi e gli esiti dell'Ottocento. Ecco i Lottatori scolpiti da Antonio Canova, Creugante e Damosseno che all'artista di Possagno arrivano dalle narrazioni di Pausania. Dietro di loro Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, dove ci sono altri lottatori, che aspirano alla conquista della dignità della classe lavoratrice. Così l'artista li raggruppa come fossero i filosofi della Scuola di Atene di Raffaello. Il celebre quadro di Pellizza introduce a due elementi ben suggeriti da questa mostra: il rapporto con la grande tradizione pittorica italiana e quello con il cinema. I nostri registi, a differenza della storiografia dell'arte e del mercato, non hanno snobbato i pittori dell'Ottocento: basti pensare a Visconti che in Senso getta la contessa Serpieri, l'indimenticabile Alida Valli, tra le braccia del suo amante austriaco nell'identica posizione dei protagonisti de Il bacio di Francesco Hayez, altro gioiello di questa rassegna.
Hayez si rivela un pittore dal talento sicuro anche nel Ritratto della Contessa Teresa Zumali e in Pensiero malinconico che qui partecipa a una convincente carrellata di fanciulle semi scollate, una specie di sala del ti vedo-non ti vedo, dove la sottile veste di marmo della Donna in preghiera di Vincenzo Vela lascia intravedere il seno, accanto alla mestizia sensuale della Schiava dell'harem di Giuseppe Molteni tutta turbanti, veli e trasparenze. Di solito quando si mette in mostra il nostro XIX secolo si ragiona per scuole regionali. Questa volta non è così. Ciò che accomuna le opere e le fa star vicine non è la geografia, ma la scoperta di piccole e segrete affinità elettive rintracciabili tra loro. Come succede, in ambito romantico, tra il napoletano Giacinto Gigante, esponente della Scuola di Posillipo, e il piemontese Giuseppe Pietro Bagetti.
La seconda parte della mostra racconta le testimonianze pittoriche dopo l'Unità. Non si può perdere La lettrice di Federico Faruffini con il profilo di una donna che ha un libro in una mano e una sigaretta nell'altra. Un vero manifesto della parità tra i sessi, datato 1864. Altro che quote rosa! E poi, come non rimanere incantati dall'orientalismo tutto fantasia e immaginazione di Domenico Morelli, dalla "macchia", dai ritratti di Giovanni Fattori, dai suoi soldati In vedetta, dall'aria di Parigi (confessiamolo) di Giuseppe De Nittis, dal volto di Suzanne Valadon, la madre di Utrillo, qui immortalata da Federico Zandomeneghi, dalla pennellata vibrante e intrisa di luce di Giovanni Segantini e Gaetano Previati? Ed è con lui che si chiude il cerchio.
…
La mostra "Ottocento.Da Canova al QuartoStato"a cura di Vittoria Marini Clarelli, Fernando Mazzocca, Carlo Sisi è aperta fino al 10 giugno alle Scuderie del Quirinale di Roma.

 9 marzo 2008
9 marzo 2008












![]() 9 marzo 2008
9 marzo 2008