





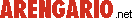
La settimana sulla stampa
a cura di G.C.
Quella profonda ferita tra Italia e Jugoslavia
Guido Crainz su la Repubblica
Pubblichiamo parte della prefazione di a "Il confine degli altri" di Marta Verginella (Donzelli, pagg. 144, euro 14) in uscita in questi giorni.
l confine degli altri apre straordinari squarci su vissuti individuali e collettivi, illumina i contorni ambigui e mobili delle appartenenze nazionali e culturali. Costringe a riflettere, a interrogarsi in modo radicalmente diverso su di una storia che è anche nostra. Anche nostra: questo Marta Verginella ci aiuta a capire. Leggendo il libro ci rendiamo conto dei grandi coni d´ombra che hanno accompagnato da sempre la nostra lettura di una vicenda lunga, che affonda le sue radici sin nelle tensioni che attraversano l´impero asburgico nel suo declino. Essa è scandita poi dalla cesura della "grande guerra " e da un convulso e violento dopoguerra: con l´annessione all´Italia di territori ampiamente popolati da sloveni e croati, e con l´italianizzazione forzata perseguita dal fascismo, accompagnata da persecuzioni e umiliazioni. Vi è poi nel 1941 l´occupazione nazista e fascista della Jugoslavia, e in fine - dopo l '8 settembre - l´instaurarsi della Zona di operazioni Litorale adriatico, alle dirette dipendenze della Germania nazista (Operationszone Adriatisches Küstenland) . È questo lo sfondo incandescente su cui si innesta il trauma del 1945, anticipato nella provvisoria transizione del settembre 1943: le uccisioni di massa di cui le foibe sono diventate il simbolo, e l 'esodo della quasi totalità della popolazione italiana. Una grande, dolorosissima ferita, parte del più vasto scenario del dopoguerra europeo. L 'abbiamo rimossa a lungo, e poco abbiamo ascoltato le voci che tentavano di raccontarla: fossero pur quelle umanamente e letterariamente intense di Fulvio Tomizza, Marisa Madieri, Anna Maria Mori, Nelida Milani, Enzo Bettiza, e tante altre ancora. A fatica ci siamo avvicinati a questa storia, con enorme ritardo abbiamo iniziato ad elaborare un profondissimo lutto. Oggi Marta Verginella ci offre ricchi stimoli per rendere più ampio e completo questo "dovere di memoria". (...)
L´avvio e l´epilogo de Il confine degli altri ci offrono un cortocircuito venato di tristezza e al tempo stesso illuminante, capace di spazzar via schemi consolidati e di aprire nuovi sentieri alla nostra comprensione e alla nostra sensibilità.
Nelle decine di sloveni portati nel 1941 davanti al Tribunale speciale - e nei quasi trecento che erano stati arrestati in quelle indagini - vediamo disegnarsi i contorni di una intera
società, nelle sue diverse componenti e nelle sue differenti opzioni intellettuali e politiche. Una società cui il fascismo ha inutilmente cercato di imporre una umiliante "assimilazione" e che ha trovato in sé - nelle proprie energie, nei propri umori, nei propri sogni, nella propria identità (riscoperta o rielaborata, come sempre alle identità accade) - la forza umanissima di resistere. Non è per nulla scontato, però, il racconto che si snoda attraverso queste pagine. Nella Jugoslavia di Tito troviamo fra i "vinti "del secondo dopoguerra anche alcuni degli imputati del processo del 1941: non hanno offerto al nuovo regime quella sudditanza che avevano già negato a quello di Mussolini e conoscono così nuove discriminazioni e umiliazioni, processi, condanne severe. Il Pubblico ministero fascista li aveva definiti "omuncoli impastati di odio […] rettili umani striscianti nell´ombra e nel fango" che osavano rifiutare obbedienza "all´unico stato e all´unica nazione capaci di portare civiltà in quelle terre". Ad alcuni di loro capiterà di ascoltare parole non molto diverse nel "socialismo reale" jugoslavo, nel momento stesso in cui inizieranno a pensare che neppur esso fosse - appunto - l´unico regime capace "di portare civiltà in quelle terre". Sarà difficile dimenticare la figura di Boris Furlan, l´"allievo di Joyce" di un bellissimo racconto di Drago Jancar. Sarà difficile rimuovere dalla nostra memoria e dalla nostra inquietudine il suo ricco e complesso percorso, sino al tragico epilogo. Di molte altre figure è popolato questo libro, e l 'infanzia di scrittori e intellettuali come Boris Pahor e Ciril Zlobec è segnata dalla stessa violenza che investe la fioraia Sava Rupel, rea come loro di aver pronunciato qualche parola slovena nella città di Trieste. Viene spontaneo affiancare le loro testimonianze a quella di vent´anni dopo di Nelida Milani, che rimane in una Pola assegnata ormai alla Jugoslavia e che ricorda così un 'aggressione subita da un uomo "con occhi cupi e fermi […]: "Se vi sento ancora una volta parlare in italiano mollo il cane che vi divori. Ve la faccio passare io la voglia di parlare questa lingua fascista "". (...)
È un doloroso gioco di specchi, è un reciproco richiamarsi di sofferenze differenti e uguali quello che Il confine degli altri evoca (...). Si veda lo spaesamento, il senso di estraneità vissuto da molti sloveni costretti a lasciare l´Italia fascista e a trasferirsi a Lubiana o altrove. (...) Spaesamenti sloveni degli anni venti e trenta (in cui) troviamo anche alcune chiavi per capire meglio sofferenze e spaesamenti dei profughi istriani nell´Italia del secondo dopoguerra.
…
La prima battaglia dell'Italia unita
Luigi Guarnieri su l'Unità
 |
Il posto sembrava deserto, in giro non si vedeva anima viva, ma c'era fumo di legna nell'aria. Davanti a un uscio sgangherato campeggiava un grosso ceppo con un cuneo inserito in uno spacco aperto da una scure.
Afflittocore fermò il cavallo e disse al maggiore Albertis che il ceppo simboleggiava una domanda di matrimonio. Se quella notte la madre della ragazza avesse tirato il ceppo in casa, il promesso sposo sarebbe stato accettato. Il maggiore Albertis rispose che dei matrimoni di quei bifolchi non gliene importava un accidente e smontò da cavallo. Poi disse a Ranieri di seguirlo e ordinò al tenente Gaetani e al sergente Ronchi di aspettare con Malgara, Conforti e Afflittocore in uno dei casolari abbandonati.
Iniziarono un giro di perlustrazione. Oltrepassarono una scifura, un recinto di truogoli per i maiali. Era intasato di rifiuti, torsoli, bucce, ossa. Videro quasi subito il riverbero di una fiamma dietro le finestre di una baracca. Spinsero il portone scheggiato ed entrarono. Lo stanzone era saturo di fumo. Un tanfo di stalla rendeva l'aria quasi irrespirabile. Al centro c'era un tavolo bisunto. Bicchieri di acquavite, piatti con avanzi di pecora bollita, cilindri arrotolati di tabacco trinciato e un lume a petrolio col vetro annerito. Sul focolare scoppiettava una fascina di sarmenti.
In fondo allo stanzone c'era una porta chiusa. Il maggiore Albertis ricaricò la pistola, la infilò nella cintura, spianò il fucile e buttò giù la porta con un calcio. Nella stanza sul retro c'erano tre bovari armati di moschetto, un paio di vecchi malvestiti, senza scarpe e con le calze bucate, un ragazzo robusto con un mantello scuro, un forcone in mano e un'immagine della Vergine appesa al collo. E poi qualche donna velata di nero e dei ragazzini vestiti con dei cenci rattoppati e con le vecchie giacche dei fratelli maggiori, le maniche troppo lunghe rimboccate sui polsi. Appena vide entrare Albertis e Ranieri uno dei bovari, un uomo basso e atticciato con una camicia verde aperta sul petto villoso, puntò il moschetto e sparò.
L'arma gli scoppiò tra le mani e lo investì con una pioggia di fuoco e di ferraglia. Gli altri due esitarono un attimo e guardarono attoniti il bovaro ferito che si accasciava su un tavolaccio, il volto sfigurato dall'esplosione. L'incertezza risultò fatale, perché Albertis abbatté il primo bifolco con una fucilata in faccia. La pallottola lo centrò in bocca, gli fece saltare in aria buona parte dei denti e poi uscì dalla nuca e si conficcò sulla parete. L'altro bifolco buttò via il moschetto e si girò di scatto tentando di scavalcare una finestra, ma il tenente Ranieri lo falciò con una raffica nella schiena. Si avvicinò a controllare, si accorse che era ancora vivo, impugnò la pistola e gli sparò il colpo di grazia alla tempia, facendogli rimbalzare la testa contro il muro. Poi restò immobile sulla soglia e tenne sotto tiro i due vecchi, le donne e i ragazzini, mentre il maggiore Albertis sorvegliava il ragazzo col forcone. Il bovaro sfigurato giaceva supino sul tavolaccio, il viso inondato di sangue e bucherellato dalle schegge, esalando un fischio inquietante dalle labbra spappolate. La mano destra era volata in aria ed era rimasta appiccicata sul muro, come un trofeo di caccia. Uno dei ragazzini la staccò, si avvicinò al tavolaccio e cercò di restituirla al bovaro sfigurato, poi visto che quello non si muoveva provò a riattaccargliela al polso, ma la mano rimase incollata al moncone solo per un attimo prima di cascare per terra. Il tenente Ranieri continuò a tenere il fucile puntato sui due vecchi e rivolse un'occhiata interrogativa al maggiore Albertis. Poi gettò uno sguardo fuori dalla finestra della baracca. Ormai era buio, ma una fluida opalescenza arancione continuava a tingere di luce i boschi e le montagne.
…
Ranieri si appoggiò al davanzale di legno crepato dalle intemperie, poi passò in rassegna i volti curiosi e lividi di paura dei ragazzini, tutti pallidi e denutriti e rachitici con grandi occhi tristi e la malaria annidata nelle pance gonfie, tese come tamburi sulle gambe storte. Scrutò gli occhi spalancati dal terrore delle donne, curve e rugose e infagottate sotto scialli neri come l'inchiostro. Vide i due vecchi tremare come foglie, calcarsi i cappelli spelacchiati sulla fronte e abbottonarsi le decrepite giacche impolverate.
Per un attimo eterno si domandò con angoscia cosa dovevano fare, cos'era giusto e cos'era sbagliato, cos'era civile e umano e saggio e cosa no, ma non riuscì a trovare una risposta, anche perché non ce n'erano. Non ci sono tenebre, non c'è ombra di morte in cui possa nascondersi colui che fa il male. Poi vide il ragazzo robusto scaraventare il forcone sul pavimento. Scoppiò a piangere a dirotto, facendo sussultare la testa sulle spalle. Chissà se era lui il promesso sposo che aveva piantato il cuneo nel ceppo.
Aveva un bel viso delicato, un'espressione fiera e dolce, folti capelli neri e un naso affilato come la punta di una freccia. Forse credeva che portare l'immaginetta della Vergine sul petto avesse il potere di arrestare le pallottole e deviare le lame delle sciabole. Ranieri si sorprese a mormorare una preghiera a fior di labbra e pensò che fino a qualche mese prima ne sarebbe stato sicuro anche lui, adesso però cominciava a dubitarne. Il tenente aveva già notato che il pesante mantello scuro del ragazzo era lungo fino alle caviglie e aveva un distintivo scolorito sulla manica destra. Doveva essere appartenuto a un bersagliere, prima che qualcuno lo ammazzasse. Ranieri fece un cenno d'intesa al maggiore Albertis per fargli capire che voleva risparmiare le donne e i ragazzini. Albertis annuì. Il tenente Ranieri si segnò la fronte, poi quando lui sparò ai vecchi il maggiore sguainò la sciabola dal fodero e calò un fendente di taglio sul collo del ragazzo.
Fanfani, il democristiano che aprì alla sinistra
Vittorio Emiliani su l'Unità
Per quelli della mia generazione cresciuti sulle pagine di Gaetano Salvemini, su quelle del Mondo di Mario Pannunzio e di riviste come Il Ponte di Calamandrei oppure Tempo Presente di Silone e Chiaromonte, Amintore Fanfani era il personaggio democristiano più controverso, nel senso che ci attraeva e, per certi versi, invece ci respingeva. Nel primo caso perché sentivamo (e constatavamo) che fra tutti i dc era quello che più credeva in un forte, risoluto impegno sociale di partiti e governi, in concrete riforme che rendessero più giusta questa nostra società così ricca di squilibri e di disparità ("comunistello di sagrestia", lo definiva la destra, assieme a Giorgio La Pira, suo sodale). Nel secondo caso perché sentivamo che, più dei degasperiani, dei cattolici liberali, era portato a volte a scivolare, come Dossetti, verso posizioni integraliste. Anche se nel 1957 L'Osservatore Romano aveva ricordato proprio a lui, difensore dell'autonomia della Dc, che "la politica è subordinata alla morale, e la morale è insegnata dalla Chiesa".
Questo chiaroscuro è rimasto per tutta la lunga vita, umana e politica, dell'aretino una sua connotazione e però, alla fine, io credo che i bilanci politici di questo centenario tireranno le somme assai più al positivo che al negativo. Amintore Fanfani rimane nella storia della seconda metà del Novecento come il capo di governo più energico, più fattivo, più concreto, alla guida di un centrosinistra non ancora organico (il Psi dava l'appoggio esterno) che realizzò, nientemeno, la nazionalizzazione dell'industria elettrica, potentato dei potentati dell'epoca. Tutto ciò dopo essere stato un protagonista alla Costituente. Fu lui a proporre e a spiegare la dizione essenziale di "Repubblica fondata sul lavoro" nel senso che il cittadino va messo nella condizione di dare "il massimo contributo alla prosperità comune". Ministro nel durissimo dopoguerra, Fanfani ha lasciato tracce profonde: chi non ricorda, per esempio, le "case Fanfani"? Cioè il più grande piano di edilizia economica e popolare di quei decenni, fondato su di una idea keynesiana dell'occupazione e dello sviluppo. Non a caso era uno specialista di storia dell'economia.
Ammetto qui, da subito, la mia simpatia per il personaggio che conobbi in età già avanzata, ben dopo il tonfo del referendum contro il divorzio (che lo aveva di nuovo ficcato fra gli integralisti), quando aveva stemperato alcune asprezze autoritarie del carattere e fatto emergere umanità e cultura. Il coraggio non gli era mai mancato, sulle piazze come nei congressi. Familiarizzai con lui nel 1983, quando era a capo di un classico "governo di servizio", e, oltre ad essere investito da una corrente di simpatia umana che raramente si prova nel contatto coi politici, ebbi da lui alcuni flash illuminanti sul suo percorso politico. Fu vicinissimo ad accordarmi una intervista-fiume sulla sua lunga esistenza (Maria Pia l'aveva quasi convinto), poi, purtroppo, non se ne fece nulla, ma in alcuni colloqui ebbe modo di far balenare taluni lampi improvvisi.
Su Alcide De Gasperi, per esempio. Si è detto e scritto che Fanfani ne fu, ad un certo punto, l'avversario ambendo a succedergli. E politicamente è vero. Ma il rispetto per la figura di De Gasperi si manifestava in modo ancora ammirato. "De Gasperi - mi disse un giorno - gli era un santo. Non l'ho mai sentito dir male di nessun altro politico, neanche di quelli che più l'attaccavano. Cosa rara in politica". Gli chiesi allora se fosse favorevole alla sua beatificazione. Ebbe uno dei suoi sorrisi lampeggianti e maliziosi. "Per esser santi, bisogna non aver detto mai una bugia e una almeno De Gasperi invece la disse…" Mi raccontò come, nell'imminenza della crisi del governo Parri, si fosse sparsa la notizia che il leader dc era caduto ammalato. "Corremmo a casa De Gasperi io e Giorgio La Pira, ma, in realtà, lo trovammo in buona salute, a letto, in pigiama, tranquillo. Ci accolse con un sorriso. Non se la sentiva di dire lui a Parri che doveva lasciare la carica di presidente del consiglio. Per questo si era dato ammalato".
Sul 18 aprile 1948. Vi rendeste conto durante la campagna elettorale che vi si preparava una vittoria così sonante? "Fino ad un mese circa prima del voto non si capiva molto da Roma. Ministro del Tesoro era Luigi Einaudi che non ci dava un soldo da investire. Finalmente un giorno ci disse che poteva stanziare un milione per opere e finanziamenti immediati. Io ero ministro del Lavoro, si lavorava da mane a sera, la disoccupazione era altissima, con scontri e conflitti in piazza. Coi fondi che ebbi potevo fare ben poco". Cosa rese meno incerto il quadro? "La morte, il finto suicidio a Praga di un uomo amato come il ministro degli esteri Masaryk. Capimmo che in giro per l'Italia la gente aveva paura del comunismo, dello stalinismo, di un colpo di Stato come quello di Praga. Quella fu la svolta decisiva".
…
La successione a De Gasperi, dopo lo scacco, nel '53, sulla "legge truffa", era stata difficile, segnata da lotte intestine. La contrapposizione col Pci si manteneva durissima sul piano sociale, anche se poi Togliatti non tirava la corda sul piano politico-istituzionale dovendo completare la sua transizione, tenendo insieme tutto il partito (dopo aver "disarmato" Secchia e i secchiani). Fanfani aveva subito più di un rovescio a vantaggio di Antonio Segni. Gli era andato male l'affondo decisivo del Congresso di Firenze dal quale era uscito sconfitto. Doppiamente, visto che poi il n.2 del suo gruppo di sinistra, il marchigiano Fernando Tambroni, aveva imboccato nel 1960 la strada dell'avventurismo golpista, con l'appoggio del Msi e grazie al sostegno ambiguo del presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, avendo contro tutta la piazza antifascista. Non pochi qualificati esponenti della Dc si erano dimessi da ministri: Bo, Pastore, Sullo.
Il drammatico luglio 1960 aveva in sostanza aperto la strada all'apertura a sinistra, all'alleanza Dc-Psi. Era stata la rivincita di Amintore Fanfani indicato ora quale capo di una sorta di governo Badoglio dopo i fatti gravissimi di Genova, Reggio Emilia e Palermo e, poco più tardi, nel '62, del primo governo appoggiato dai socialisti nella storia d'Italia (se si esclude la fase temporanea degli esecutivi di unità nazionale dopo il 25 aprile). Moro a piazza del Gesù e Fanfani a palazzo Chigi: era un binomio perfetto. Purtroppo durò poco (al governo Moro doveva risultare quanto mai inadatto, indeciso a tutto). "La si ricordi, direttore - mi ricordò un giorno Fanfani - fra la decisione del consiglio dei ministri di nazionalizzare l'industria elettrica e l'insediamento del primo consiglio di amministrazione dell'Enel passarono soltanto tredici mesi". In effetti un lampo, se si pensa (e io l'avevo seguito) al percorso complesso e difficile degli espropri, degli indennizzi di potentati decisivi come Edison, Sade o Sip, alla polemica furibonda scatenata dalla Confindustria e da tutta la stampa "indipendente" (con la sola eccezione del Giorno di Italo Pietra). Fanfani voleva sottolineare come, allora, lo Stato ancora funzionasse, come il governo fosse in grado di agire con decisione. Pur fra contrasti tutt'altro che lievi, e coi dorotei che tendevano a ritardare, ad annacquare, a devitalizzare il processo riformatore. Col suo governo fu varata anche la scuola dell'obbligo. Era un'Italia che quasi non aveva debito pubblico. Era l'Italia della programmazione nascente, della Nota aggiuntiva di Ugo La Malfa al bilancio preventivo 1962, che prometteva riforme importanti in cambio di una certa moderazione salariale. Presa nel fuoco concentrico di Pci, sindacati e Confindustria. Di quest'ultima soprattutto, a cannonate. Era anche l'Italia di una certa Rai, dove le forbici della censura entravano spesso in azione (magari per le gambe nude delle gemelle Kessler), ma dove però si faceva anche servizio pubblico vero, dove un fanfaniano di ferro come Ettore Bernabei lasciava margini ad esperienze incisive come TV7 e le sue inchieste. "Era un sistema basato su ”patti chiari e amicizia lunga” in quella Rai", ha testimoniato Andrea Camilleri, allora sceneggiatore e regista. Fu proprio Fanfani a volere la prima Tribuna Politica, anche se poi in tv riusciva troppo tagliente, poco accattivante, insomma impopolare. Mentre in privato poteva essere di una simpatia prorompente. Un autentico "gallo in una stia di capponi" come gli uscì detto in quegli anni ad una altro toscanaccio, Indro Montanelli (che anni dopo lo soprannominò "il rieccolo" per i suoi ritorni alla ribalta).
Fra l'altro aveva goduto della simpatia di papa Giovanni XXIII che, durante una visita comune ad un ospedale romano, accennando ad una frase da lui precedentemente pronunciata disse: "Ego pastor et tu nauta", io pastore e tu nocchiero. E dai Palazzi Apostolici non ci furono più veti al centrosinistra, all'alleanza organica coi socialisti, anche per l'apertura di credito del papa a Fanfani. La sua leadership di governo finì presto, col terremoto elettorale del '63 provocato dalle reazioni confindustriali alla nazionalizzazione elettrica e al progetto "Sullo" per quella legge urbanistica che ancora attendiamo, con Giovanni Malagodi in testa ad attaccare con la più incupita aggressività lo stesso diritto di superficie ("Vi toglieranno la casa, italiani!", lo sentii tuonare) che esisteva in tutta l'Europa più civile e sul quale lo stesso Pli si era astenuto, un anno prima, nel voto sulla legge n. 167 per l'edilizia economica e popolare.
…
Era difficile capire perché un uomo politico che sapeva guardare lontano, che aveva una visione mediterranea e internazionale di sicuro respiro, fosse incappato nel '74, da segretario dc, nello scivolone disastroso, con cadute di gusto volgari, del referendum contro il divorzio. Quello che si coglieva in lui era uno spessore culturale autentico, un amore per l'arte - che praticava da pittore tutt'altro che banale - senza limiti, accesosi, mi confidò, durante i tre anni passati a studiare a Urbino.
…
Era legatissimo alle sue radici toscane e, curiosamente, tiberine. Nato a Pieve Santo Stefano, si rammaricò per aver saputo troppo tardi di una mia discesa in gommone del Tevere con altri del giornale. "Avrei partecipato pure io, direttore, io che son tiberino". Gli spiegai che avevamo fatto anche naufragio dalle parti di Montone durante un fortunale e ne ridemmo insieme. Allora mi regalò un delizioso libretto scritto dopo la sconfitta elettorale del '63, Una pieve in Italia. Qualcuno ha detto che stava fra San Francesco (i santi mistici erano una sua passione) e Keynes. Certo ebbe una straordinaria sensibilità per l'ambiente promuovendo all'Onu la prima grande conferenza sull'ambiente del pianeta.
La conversione di Malaparte
Igor Man su La Stampa
Il suo modo d'essere fu l'amore per se stesso. Ma un amore balzano, episodico, irto di dubbi facili, tuttavia, da cancellare. Sto parlando di Curzio Malaparte, grande giornalista, imaginifico scrittore atipico e, proprio per questo, tuttora valido. A cinquant'anni dalla sua morte, Prato, città natale, lo celebra mettendo l'accento sulla sua conversione in articulo mortis. Fu autentica?, anzi: ci fu veramente quella conversione al cattolicesimo preceduta da una infuocata adesione al partito comunista, con tanto di tessera accompagnata da una convinta lettera di Palmiro Togliatti? Chi scrive, il Vecchio Cronista che allora, giovanissimo, cinquant'anni fa, appunto, ebbe in sorte di frequentare Malaparte quand'egli consumava gli ultimi ritagli di vita nella clinica romana Sanatrix, osa scrivere "sì". Vediamo.
Non sappiamo perché un bel giorno Malaparte abbia deciso di "scoprire" la Cina raggiungendola via Urss. Correva il boreale 1956, lo scrittore bussò un po' dappertutto ma sempre invano, finché non ebbe l'illuminazione: chiedere il visto come inviato speciale del settimanale comunista Noi donne, diretto da Maria Antonietta Macciocchi, apprezzata da Togliatti ch'era per sua parte affascinato da Curzio. Galeotto fu il sindaco di Napoli, Valenzi, che portò Togliatti a Capo Masullo, nella splendida villa dello scrittore a Capri: l'incontro ebbe luogo nell'aprile del 1944 ma Malaparte ne scrisse nel 1947: "... lo accompagnai nella mia biblioteca e là ebbi una prima sorpresa. Togliatti si guardò intorno e disse: “Lei ha un Dufy, laggiù”. Un capo comunista che riconosce un Dufy a trenta passi non è certamente uno di quei mostri che spaventano i borghesi".
Fra Malaparte e i cinesi fu amore a prima vista. E quando quei medici diagnosticarono un tumore ai polmoni (già straziati dai gas delle Argonne) Malaparte decise di curarsi a Pechino. Ma gli stessi cinesi diedero una mano agli amici italiani per convincere Malaparte a farsi curare da Valdoni, alla Sanatrix di Roma. Subitanea fu la corsa all'arruolamento dello scrittore: Togliatti (che poi lo visiterà) ordinò a Maria Antonietta Macciocchi e al giovanissimo Alberto Jacoviello di non perdere mai di vista la camera dell'importante malato e quelli si davano il cambio sul pianerottolo ove mai apparisse il gesuita padre Rotondi. Ma Renato Angiolillo, direttore-fondatore de Il Tempo, architettò un marchingegno: Malaparte venne spostato in una camera che aveva un collegamento interno con un'altra che suor Carmelita apriva a padre Rotondi, a padre Cappello mentre tutti gli altri visitatori entravano ed uscivano dall'uscio diremo principale.
La conversione maturerà durante la degenza: tre interminabili mesi marchiati dal dolore fisico, stoicamente sofferto. Negli ultimi suoi giorni terreni Curzio parlava spesso della morte. Quando la morfina quietava il dolore che lo destrutturava ne discorreva pianamente. Con discrezione. Eppure amava la vita. "Sono cristiano, diceva, e la religione mi ha insegnato a non aver paura della morte. Per noi toscani morire non è che un cambiar podere. Il Fattore è sempre lo stesso e la zappa eguale. Anche di là troveremo un po' di terra da zappare". Un giorno, congedatosi Falqui con cui ero venuto a trovare Curzio, rimanemmo soli. Ad un certo momento, con voce piana disse: "Sai come si dice morte in cinese? Si dice con un suono improvviso, un sussurro dolce e immediato. Morte, in cinese ha lo stesso suono del numero 4. Questo: SSSS. Morte, SSSS. E perché è lo stesso che dire quattro? Perché è il segno dei quattro punti estremi, i quattro mari. Un puntino sopra, uno sotto, due ai lati. Gli angoli di un piccolo rombo. La morte: SSSS, il numero 4. Dissi un giorno a un missionario cattolico come fosse lo stesso che fare il segno della croce. Se n'era accorto, ci aveva mai pensato? No, disse il missionario, allora su di un foglio di carta segnai i puntini, poi li unii con un tratto di lapis, uno dall'alto in basso, l'altro da sinistra a destra. Avevo così disegnato la croce. Morte, SSSS in cinese, il segno della croce. Il missionario mi guardava. Mi pregò di farlo ancora, SSSS. Ed io segnai di nuovo i quattro punti. Uno due tre quattro. Tracciai i segni di congiunzione. Piano, come se fossi in chiesa col Cristo che spalanca le braccia per accoglierti. In qualsiasi momento. Cristo non si stanca di spalancare le braccia all'uomo perché, povero Cristo, è il messaggero della pietà, lui. E' Gesù. Il missionario mi guardava…".
Ma chi era veramente Malaparte; uno scrittore-pavone, un byroniano in ritardo, un innamorato di se stesso pronto, per altro, a mettersi in discussione? E la sua conversione? Piena, sincera ovvero dettata dalla inesauribile voglia di stupire? Trovo su quel giornale limpido ch'è Avvenire una convincente risposta: "In fondo la Prato e la Toscana di Malaparte non sono molto lontane da quelle di don Lorenzo Milani. Una terra di poveri dove tutti si è comunisti ma dove tutti vengono battezzati, ci si sposa in chiesa e si va a Messa rispettando il precetto della domenica" (cfr. F. Rizzi).
Un mese prima che Malaparte morisse ("con tutti i conforti religiosi") il giornale mi spedì negli Stati Uniti. Ma sulla sua "morte cattolica" raccolsi, al mio ritorno, la preziosa testimonianza di due laici, suoi amici affezionati: Aldo Borelli, il mitico direttore del Corsera, il critico Enrico Falqui, curatore dell'opera omnia di Curzio. Entrambi confermavano quanto disse il gesuita Rotondi al microfono di Enrico Ameri. Sono gli ultimi momenti terreni di Curzio, e così li sintetizzò il padre gesuita. "Padre, mi sento come Gesù in croce. Tutto un dolore. Faccia presto, mi confessi e mi dia Gesù, padre andiamo". "Dove dobbiamo andare?", e Malaparte: "Lassù".
…
Malaparte fu lucidissimo sino all'ultimo istante. Hanno scritto che gli ho strappato la conversione profittando del suo delirio preagonico. Tutte calunnie, lo ripeto: vorrei morire io in quel modo".
Malaparte aveva legioni di nemici ma gli bastavano pochi amici "per non sentirmi solo". Qualcuno lo vuole, tuttora, egoista, sparagnino mentre, al contrario sapeva esser generoso, soprattutto coi giovani (vero, Nantas?) e sprezzante anche con chi amava: le donne, "usa e getta". Era un grande faticatore, scrivere lo spossava sino alla febbre. I suoi scritti (in primis Kaputt) sono musica sinfonica e molti sfiorano la profezia: si veda Mamma Marcia, attualissima risonanza magnetica dell'Europa di oggi.
Ma "cinquant'anni dopo" ha senso scrivere di Malaparte con la pretesa di finalmente capire chi fosse, chi fu? "Ma non c'è il Nulla. Zero non esiste. Ogni cosa è qualche cosa. Niente non è niente". Lo ha scritto Victor Hugo, uno scrittore caro a Malaparte.
Il dubbio cristiano sul popolo d'Israele
Gad Lerner su la Repubblica
Destreggiandosi invano fra la luce e le tenebre, un infelice artifizio dialettico rivela oggi agli ebrei che la Chiesa cattolica non può smettere di additarli come popolo anomalo, un´imperfezione da sanare.
Avendo elevato la lotta contro il relativismo a priorità del suo magistero, Benedetto XVI deve anzi ribadire con forza quell´imperativo – la conversione degli ebrei - che i suoi predecessori avevano deciso di mettere in sordina.
Da mezzo secolo, ormai, la Chiesa s´interroga su quanto sia lecita teologicamente una svolta relativista a proposito della conversione degli ebrei. Fondamento di dottrina che si richiama a San Paolo e da cui, per oltre diciannove secoli, trassero alimento la diffidenza e il disprezzo nei confronti del popolo della Bibbia, colpevole di negare la divinità di Cristo. Se di nuovo quel proposito di correzione-conversione viene ribadito come elemento decisivo della fede cristiana, sarà difficile farlo coesistere con la ricerca dell´amicizia in uno spirito di riconciliazione.
Lo rivelano le modifiche testuali, solo in apparenza attenuative, disposte dal Vaticano nel messale del rito tridentino per il venerdì santo, quello da cui nel 1959 Giovanni XXIII eliminò l´odioso riferimento alla perfidia ebraica. Al posto della preghiera per il "popolo accecato" perché "sia strappato alle tenebre", oggi il Vaticano formula un eufemistico auspicio: "Preghiamo anche per gli ebrei, affinché Iddio Signore nostro illumini il loro cuore e riconoscano Gesù Cristo come Salvatore di tutti gli uomini" (i corsivi sono miei).
Non è piacevole essere oggetto di una tale speciale attenzione, risparmiata ad altri popoli. Poco cambia, evidentemente, che i riferimenti all´accecamento e alle tenebre vengano sostituiti dall´augurio di illuminazione e dalla speranza di riconoscimento. Questa nuova preghiera che confida in una provvidenziale folgorazione degli ebrei – che finalmente desistano dall´errore - adegua l´argomento con cui numerosi santi e dottori della Chiesa definirono gli erranti come "popolo maledetto". Un insulto rimosso, quest´ultimo. Ma potenzialmente implicito nell´attesa di una resipiscenza ebraica, condizione indispensabile per la Salvezza di tutte le genti alla fine della storia. Prima o poi è necessario che gli ebrei, per quanto rispettabili nella loro ingiustificata ostinazione, riconoscano la Verità che pure duemila anni or sono fu rivelata sotto i loro occhi, nella loro terra.
Per secoli la Chiesa ha preteso di rappresentarsi come "la nuova Israele". Fu Giovanni Paolo II, sulla scia del Concilio, a sconsigliare l´uso di questa espressione tipica di una teologia sostitutiva per cui l´Alleanza del Monte Sinai sarebbe invalidata e soppiantata dalla Nuova Alleanza. Dunque coloro che non vollero riconoscerla sarebbero per questo condannati al disprezzo, fin tanto che non si convertiranno.
Si spiegano così la protesta e la pausa di riflessione annunciate dall´assemblea rabbinica italiana nel dialogo con la Chiesa di Roma. "Vengono meno gli stessi presupposti del dialogo", ha rilevato il suo presidente Giuseppe Laras. Il Vaticano, infatti, non aveva alcuna necessità immediata di introdurre questo nuovo testo, visto che già nel 1970 Paolo VI l´aveva completamente modificato la preghiera del venerdì santo, limitandosi all´augurio, ben diverso, che il popolo ebraico sia fedele alla sua Alleanza.
E´ interessante ricordare che lo stesso Paolo VI –come confermano suoi appunti scritti- nel 1964 restava contrario a una dichiarazione conciliare sul popolo ebraico nella quale mancasse un riferimento all´imperfezione e alla provvisorietà della sua condizione, visto che "tale speranza è esplicitamente espressa nella dottrina di S: Paolo sugli ebrei". Papa Montini preferì allora custodire nell´intimo tale convincimento. Un anno dopo vide la luce la "Nostra Aetate" con cui la Chiesa scagionava gli ebrei dall´accusa di deicidio, senza riferimento alla necessità della loro conversione.
Da allora molto cammino si è compiuto, allietato da storici gesti di riconciliazione e promesse d´amicizia. Ma la Chiesa cattolica fatica a compiere il passo più difficile nei confronti degli ebrei: l´elaborazione di una nuova teologia che archivi definitivamente la teologia sostitutiva.
Non a caso, per motivare la scelta vaticana di riproporre –così infelicemente modificato- il messale in vigore nel 1959, il cardinale Kasper s´è richiamato alla dichiarazione "Dominus Iesus" pubblicata nell´agosto 2000 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede presieduta da Joseph Ratzinger. Riaffermando solennemente che non vi sono altre vie d´accesso alla Verità e alla Salvezza al di fuori di Gesù Cristo, la "Dominus Iesus" giunse come una doccia fredda a ridimensionare, sei mesi dopo, i "mea culpa" del Giubileo. La centralità di fede della conversione degli ebrei tornava così tema prioritario, e pietra d´inciampo, nel dialogo interreligioso.
Venne di conseguenza, nell´ottobre 2005, la designazione del cardinale Lustiger, eminente figura di ebreo convertito, per la commemorazione in Vaticano del quarantesimo anniversario della "Nostra Aetate". La stessa biografia di Lustiger testimoniava un´accezione del dialogo finalizzata alla conversione. Il rabbino capo di Roma decise per questo di disertare la cerimonia.
Il medesimo filo conduttore di una fede che non ammette relativismi, congiunge la lectio magistralis di Ratisbona – dove il papa rivendicava una sorta di dominio sulla ragione - con la proposta agli ebrei di un dialogo somigliante ad un´amicizia sopraffattrice.
…
Bach e la globalizzazione
Yo-Yo Ma sul Corriere della Sera
Ormai quasi vent'anni, dei trenta della mia carriera di violoncellista, li ho trascorsi viaggiando, anni in cui ho suonato e ho conosciuto tradizioni e culture musicali. I viaggi mi hanno convinto che nel nostro mondo globalizzato le tradizioni culturali sono un elemento essenziale a sostegno della nostra identità, della stabilità sociale e della disponibilità allo scambio di esperienze.
Un mondo in continuo cambiamento come il nostro è destinato a rendere incerti i legami culturali e a indurre la gente a mettere in discussione le proprie radici. La globalizzazione sembra spesso minacciare l'identità individuale, costringendoci ad adottare regole altrui. Naturalmente questo ci mette in crisi, perché ci si chiede di cambiare abitudini inveterate. I leader del mondo attuale devono quindi porsi una domanda fondamentale: come possono le abitudini e le culture mutare per convivere in un pianeta allargato senza sacrificare le diverse identità e l'orgoglio di appartenervi?
Nel corso dei miei viaggi musicali ho capito che le interazioni prodotte dalla globalizzazione non conducono solo alla scomparsa di culture, possono anche creare nuove forme culturali e rafforzare e diffondere tradizioni che esistevano da secoli. Avviene qualcosa di simile a quello che gli ecologisti chiamano "edge effect", effetto di bordo, espressione usata per descrivere quel che accade quando due ecosistemi differenti — per esempio la foresta e la savana — si incontrano. Lungo il confine, dove c'è la minor densità e la maggior diversità di forme di vita, ogni essere vivente può avvalersi delle proprietà dei due ecosistemi. A volte le cose più interessanti succedono ai margini. Le intersezioni possono rivelare collegamenti inattesi. La cultura è un tessuto formato da apporti provenienti da ogni angolo del mondo. Un modo di scoprire il mondo è quello di scavare in profondità nelle sue tradizioni. In musica, ad esempio, al centro del repertorio di ogni violoncellista ci sono le Suite per violoncello solo di Bach, e nel mezzo di ogni suite c'è un movimento di danza chiamato sarabanda. La sarabanda ha avuto origine dalla musica dei berberi dell'Africa del Nord, dove era una danza lenta e sensuale. Poi è passata in Spagna, dove è stata proibita perché era considerata indecente, lasciva. Gli spagnoli l'hanno portata nelle Americhe, ma è anche arrivata in Francia, dove è diventata una danza di corte. Intorno al 1720 Bach ha usato la sarabanda come uno dei movimenti delle sue Suite per violoncello. Oggi io, musicista americano nato a Parigi da genitori cinesi, suono Bach. Allora a chi appartiene veramente la sarabanda? È stata adottata da tante culture diverse, ognuna delle quali l'ha investita di significati particolari, ma in realtà è di tutti, la musica appartiene a tutti noi.
Nel 1998 ho fondato il Silk Road Project per indagare sulla corrente di idee che da migliaia di anni attraversa diverse culture tra il Mediterraneo e il Pacifico. Quando suoniamo nel Silk Road Ensemble, cerchiamo di riunire sul palcoscenico una discreta rappresentanza del mondo. I membri del gruppo sono dei virtuosi, maestri di tradizioni ancora vive europee, arabe, azere, armene, persiane, russe, centro-asiatiche, indiane, mongole, cinesi, coreane o giapponesi. Tutti mettono generosamente a disposizione le loro conoscenze e sono curiosi e desiderosi di apprendere altre forme di espressione.
Negli ultimi anni abbiamo visto che tutte le tradizioni sono il risultato di invenzioni riuscite. Uno dei modi migliori per assicurare la sopravvivenza di una tradizione è portarla ad evolversi organicamente, usando tutti i mezzi oggi a nostra disposizione.
…
Abbiamo scoperto che portare all'estero una tradizione musicale stimola i musicisti nel Paese di origine. Soprattutto, abbiamo sviluppato una passione per la musica altrui e stabilito tra noi un legame di mutuo rispetto, amicizia e fiducia che è palpabile ogni volta che saliamo sul palco. L'interazione gioiosa è il nostro scopo principale e siamo sempre riusciti a contemperare le differenze con un dialogo amichevole. Aprendoci gli uni agli altri, gettiamo un ponte verso le tradizioni che non ci sono familiari, scacciando la paura che spesso accompagna il cambiamento e lo spaesamento. In altre parole, quando estendiamo al mondo la nostra visione, capiamo meglio noi stessi, la nostra vita e la nostra cultura. Abbiamo più cose in comune di quel che pensiamo, anche con angoli remoti del nostro piccolo pianeta.
Scoprire questi scambi tra culture è importante, ma non solo per amore dell'arte. Tante nostre città — non solo Londra, New York o Tokyo, ma ora anche città di media dimensione — vedono arrivare ondate di immigrati. Come riusciremo ad assimilare gruppi di persone che hanno tante abitudini diverse? È inevitabile che l'immigrazione porti ad avversioni e conflitti, com'è avvenuto in passato? Cosa fare con la popolazione turca in Germania, gli albanesi in Italia, i nord africani in Spagna e in Francia e ancora in Italia? Una vivace attività culturale può aiutarci a capire come i gruppi possono mescolarsi in modo pacifico, senza sacrificare l'individualità e l'identità. Non si tratta di correttezza politica. Si tratta di riconoscere quel che è prezioso per qualcuno di noi, e i doni che il nostro mondo ha ricevuto da ogni cultura.
Pinturicchio ritorna in serie A
Marco Rosci su La Stampa
PERUGIA. Un giovane aiutante, evidentemente schiavizzato, che accompagnava il perugino Bernardino di Betto, approdato a Roma al seguito di Perugino (che in realtà perugino non era, ma di Città della Pieve), nell'esplorazione delle "grotte" della Domus Aurea per trarne nuovissimi modi di decoro fra pittura e stucco, vi lasciò un graffito fra iroso e beffardo: "Omgni poltro ghuastat/ Pintorichio sodomita". Negli stessi anni, l'umanista perugino Francesco Maturanzio, dopo aver esaltato il Perugino, scrisse: "et eravi ancora un altro maestro nominato da molti el Pentoricchio et da molte appellato Sordicchio perchè era sordo e piccolo de poco aspetto et apparentia come quello maestro Pietro era primo de quilla arte così costui era secondo". Con queste stilettate non stupisce che il Vasari lo confini fra gli artisti di pratica e di gusto decorativo e plebeo, frescante di stucchi e ori "che è cosa goffissima".
L'accademico deprezzamento vasariano dell'opera dello "strano e fantastico uomo" persistette nei secoli, anche nel XX. La possibilità di un riscatto emerse con la lezione di Saxl del 1945 all'Istituto Courtauld di Londra sull'iconologia "egizia" dell'Appartamento Borgia in Vaticano, che aveva suggerito al D'Annunzio del Piacere l'esaltazione della "grande fantasia del Pintoricchio" che "si svolge in un miracoloso tessuto di storie, di favole, di sogni, di capricci, di artifizi e di ardiri".
...
La monografia e la mostra sono ovviamente tesi a riscattare il pittore da questa secolare condanna alla serie B. Mi sembra tuttavia singolare che né la monografia né i saggi in catalogo non traggano la vera conseguenza che emerge dall'intuizione geniale di D'Annunzio quanto dalle opere, sia da quelle mobili che lussureggiano in mostra sia dai cicli monumentali, dalla cappella Bufalini ad Aracoeli a Roma all'Appartamento Borgia e alla Cappella Bella di Spello: il Pintoricchio è fra i più precoci in quella schiera di maestri "eccentrici" che dalla provincia circolano nei grandi centri dal centro al nord al sud e viceversa al di fuori e contro la linea classica rinascimentale che ne suo caso è rappresentata esemplarmente dal Perugino. Una prova palmare è presente in mostra, nel foglio del taccuino di disegni romani del 1496, della Biblioteca Palatina di Parma, di un membro di punta di quella schiera, il bolognese Amico Aspertini. In esso il ventenne Aspertini riproduce a penna le grottesche dipinte due anni prima dal cantiere del Pintoricchio sullo sguincio della finestra della sala dei Santi nell'Appartamento Borgia.
La mostra deve ovviamente sopperire a quello che senza dubbio è il cuore pulsante della vasta, febbrile creatività e genialità inventiva-decorativa fra 1480 e 1513 da Perugia a Roma, da Spello a Siena, le pareti e le volte ad affresco e stucchi, con le proiezioni didattiche e la testimonianza viva dei disegni. Questi, coinvolti nell'altissimo livello di un sottile dibattito critico con quelli del Perugino e del giovane Raffaello, fanno parte di una sezione di estremo fascino ottimamente curata da Claudia La Malfa. Complessa è la questione critica sulle radici locali e miniaturistiche dell'artista, per cui la mostra esordisce con il dorato fulgore tardogotico su forme rinascimentali dei perugini Benedetto Bonfigli, Bartolomeo Caporali, Fiorenzo di Lorenzo. Al grande problema critico degli otto pannelli del 1473 con Miracoli di San Bernardino da Siena, già in San Francesco al Prato a Perugia, in alcuni dei quali viene riconosciuta in scheda la presenza di un giovanissimo Pintoricchio, si aggiunge quello del dibattito fra Pintoricchio esordiente e il giovane Perugino del Crocifisso e i santi Gerolamo e Cristoforo della Galleria Borghese e del San Gerolamo della Walters Art Gallery di Baltimora. Se vi è ancora dibattito per la grande Madonna col bambino con paesaggio della National Gallery di Londra, di tipologia alla Verrocchio, fra Pintoricchio, Fiorenzo di Lorenzo e Caporali, la strada diventa maestra con la sequenza della produzione seriale degli anni 1490 di Madonne a mezza figura con il Bambino in piedi che legge o in grembo che gioca, in vesti di straordinario smalto cromatico su sfondi di natura umbra pervasi da pulviscolo d'oro. Sono affluite da tutto il mondo, da Raleigh North Carolina a Houston, da Philadelphia a Honolulu, da Varsavia a Berlino. Ad esse si aggiunge quella recuperata sul mercato antiquario dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e restaurata, esposta a Palazzo Baldeschi al Corso.

 10 febbraio 2008
10 febbraio 2008










![]() 10 febbraio 2008
10 febbraio 2008