



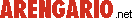
sulla stampa
a cura di G.C. - 7 novembre 2007
Il ragazzo di paese
Nello Ajello su la Repubblica
Per oltre mezzo secolo Enzo Biagi ha alimentato e legittimato la mitologia di questo nostro mestiere. Onnipresente, tempestivo, imperturbabile nella sua apparente discrezione, ha fondato la sua popolarità sull´antica fiaba del provinciale "che si fa strada nella vita", percorrendo l´antico itinerario dall´ago al milione. Caustico e crepuscolare insieme, Biagi, anziché a un solitario artigiano della penna, mi ha sempre fatto pensare a una media azienda editoriale ben avviata, con una gamma delle più ampie, tale da soddisfare ogni possibile domanda "di massa".
Proviamo a scorrere il catalogo dell´industria Biagi. Rubriche di commento per quotidiani e settimanali, generalmente poi assemblate in volume. Prestazioni per tivù pubbliche o private. Libri di divulgazione culturale, a metà fra il giornalismo di costume e il turismo aneddotico: la fortunata Geografia di Biagi (anni Settanta). Volumi di storia, vari per periodo trattato e per argomento. Raccolte d´interviste con personaggi celebri. Monografie su contemporanei, da Enzo Ferrari a Gianni Agnelli. Radiografie di popoli. Opere narrative, d´indole storico-rievocativo o di pura immaginazione. Dai libri ai fumetti: Biagi è stato forse il primo ad usare questo tramite espressivo per raccontare la storia d´Italia collaborando con uno stuolo di disegnatori. Dal teatro - è stato anche autore di commedie - ai dischi: sono rimasti famosi (e sono oggi introvabili) tre longplaying da lui incisi in coppia con Sergio Zavoli, sulle vicende italiane dal fascismo in poi e su "cinquant´anni d´amore".
A questi imponenti risultati produttivi e commerciali corrispondeva una esile struttura organizzativa: un ufficio a Milano, al piano ammezzato della libreria Rizzoli in Galleria; una segretaria, Pierangela Bozzi, che lavorava con Biagi da sempre; uno studio nella sua casa di Sasso Marconi, alle porte di Bologna, pieno di ritagli ammucchiati e forse in attesa di schedatura. Semplicità di strutture, chiarezza di funzioni, duttilità operativa.
…
Che in Biagi si sposassero l´imprenditore e il prestatore d´opera, animati da un´insonne inventiva, è dunque un dato pacifico. Non ne dubitano neppure quegli intellettuali che, al solo sentirne il nome, scuotono il capo e non riescono (ma forse fingono) a spiegarsi il perché di tanto successo.
Biagi un mistero? Non esiste, in verità, figura di contemporaneo più nota della sua. Parlava sempre in prima persona, raccontandosi innumerevoli volte. La sua aneddotica, anche quando spaziava su altra gente e altri paesi, nel fondo non ammetteva che un protagonista: Biagi Enzo, nato a Pianaccio, frazione di Lizzano in Belvedere (Bologna) il 9 agosto 1920, figlio di un operaio dello zuccherificio bolognese. Stato civile: coniugato con Lucia Ghetti (scomparsa qualche anno fa), mai divorziato, padre di tre figlie, Bice, Carla e Anna (morta anche lei di recente), che egli eleggeva, ogni tanto, a destinatarie dei suoi scritti più impegnativi.
Amori e odi di Enzo Biagi: scegliamoli solo due, i più attuali anche se ormai proverbiali. Nel primo scomparto - amori - troviamo Romano Prodi, emiliano come lui, dotato al pari di lui d´una tenacia rocciosa che si nasconde sotto una maschera di bonarietà. Al polo opposto Silvio Berlusconi, cui il giornalista ha dedicato un´avversione senza quartiere, incurante di dovergli un invidiabile prolungamento di carriera. Quella di inserirlo, già ottantenne, nel novero dei giornalisti dal comportamento "criminoso" e quindi da epurare, è stata infatti, da parte dell´ex premier, una mossa controproducente. È stato come insignirlo di una "laurea ad honorem" di cui lo scaltro destinatario ha fatto tesoro.
Questa è storia recente. La personale preistoria di Biagi è assimilabile a un film di Fellini del tipo Amarcord. O a un raccontino di Guareschi. C´è la stessa mitizzazzione dell´infanzia trascorsa nel "mondo piccolo" della provincia emiliana. Il nonno di Biagi vale quello di Fellini. Così lo zio-cugino Domenico, avvocato, fascista, che "abitava a Roma, e Mussolini gli assegnava incarichi importanti". I fossi sui quali il piccolo Enzo si sporgeva a caccia di rane possono confondersi con quelli in cui, anche da adulto, continuò a specchiarsi l´inventore di Don Camillo. Tutto in lui richiamava la vicinanza alla terra d´origine, l´attaccamento ai suoi sapori, la passione per le sue nebbie. Ne derivavano, come una sorta di corollari, l´inclinazione alla nostalgia, l´insofferenza per le ideologie astratte e astruse, la pretesa che la realtà si presentasse in rapide immagini familiari, con qualche goccia di humour.
…
Una specialità, nel ricettario di Biagi, è sempre stata l´autoironia ("Mi guardo, e nella mia faccia da sei pose lire cinquecento non trovo i segni dell´eccezionale"). L´altra era l´odio per le statistiche. Sommerso dagli umori, Biagi resisteva ai numeri. Proclamandosi uno "specialista in niente", dichiarava guerra ai tuttologi: ma non solo. Derideva gli economisti, specie se muniti di tessere di partito. Lo irritava l´esperto in psicologia di massa. L´unica cosa sulla quale non professasse incredulità erano "le facce". Su questo terreno si misuravano le sue capacità di "opinionista" (termine che ovviamente esecrava). I sottotitoli dei suoi libri ruotavano intorno a questa realtà fisiognomica: Figure e figurine, Tanti volti, tante storie. Per sfamare questa inventiva, il vero pane erano gli uomini politici. Non ce n´è uno che gli sia sfuggito. Durante la prima Repubblica, dai democristiani ai socialdemocratici (questi ultimi con assoluta preminenza) hanno invaso la sua galleria biografica. Una collezione che gareggiava a volte con quella di un Fortebraccio.
Quanto alle personali preferenze "di schieramento", Enzo Biagi si è sempre professato "un socialista all´antica". Faceva suo un motto del quasi-conterraneo Pietro Nenni: "Il socialismo, se non è umano, non è niente". Ai socialisti "alla Pierre Cardin", così definiva i craxiani, professò un´avversione precoce e tenace. Prediligeva Sandro Pertini, anche se canzonava il culto retorico che troppi gli riservavano: "Pertini antifascista, Pertini soldato, Pertini resistente. La serie fa venire in mente, col dovuto rispetto, i primi cortometraggi di Charlie Chaplin: Charlot alla guerra, Charlot pompiere, Charlot al circo".
Erano giudizi sensati, al di là dell´effetto parodistico cui miravano? Certo non sempre. Ma che il più delle volte fossero efficaci non c´è dubbio. Egli era infatti un epigrammista di massa. Anche le citazioni di cui nutriva gli articoli (al punto che sul Foglio, alcuni anni fa, usavano concentrare in un´apposita rubrica, dal titolo "Il Biagino", le frasi celebri da lui adottate) venivano rese orecchiabili, ruspanti, si trattasse di Orwell o di Bernanos, di Mauriac o di Camus, di Shakespeare o di Hemingway, di Winston Churchill o di Pietro Verri.
…
Era permaloso, ma dava una complessiva impressione di onestà. Direttore, in successione, d´un settimanale (Epoca, dal 1953 al 1960), del telegiornale (dall´autunno del 1961 all´estate del 1962) e d´un quotidiano (Il Resto del Carlino, fra il '70 e il '71), ne è uscito ogni volta per evitare un compromesso inaccettabile o perché vittima di una prevaricazione "padronale". Spesso si offendeva con un giornale, traslocando fulmineamente in un altro (con sempre la stessa rubrica, "Strettamente personale"): Espresso, Panorama, Stampa, Repubblica, Corriere. Giornalista "multimediale" per eccellenza, si adeguava con prontezza al tramite tecnico che utilizzava. Dal Biagi scritto al Biagi visto e ascoltato in tivù si notava, in particolare, un notevole calo di temperatura satirica.
In video non era aggressivo. Puntava più sulla credibilità che sul brio. Quasi mai sorrideva. Parlava a bassa voce. Si limitava ad esibire, per dirlo con Prezzolini, "quel suo volto benevolmente immobile che non si stupisce né pare commuoversi di nulla". La sua rubrica televisiva intitolata Il fatto, che lo ha visto al lavoro già vecchio e quella intitolata Rotocalco televisivo, in cui è riapparso di recente, avevano questa sua discrezione come principale ingrediente di successo. Brevemente, spremeva dai personaggi l´essenziale. È d´altronde proverbiale la voracità con la quale Biagi ha raccolto, anche per scritto, le confidenze dei protagonisti degli ultimi sessant´anni, dai sopravvissuti dell´era nazista alle maliarde sfiorite di un´Europa che non c´è più. Per lui il mito della femminilità continuava a incarnarsi in Michèle Morgan e Alida Valli. Teneri materiali di cui si serviva per impreziosire il suo perenne Dizionario del Novecento.
Entusiasmi e malinconie restavano confinati in questi orizzonti cari alla sua epopea di vecchio ragazzo di paese. Non se ne vergognava, anzi. "Quante volte ho detto, mentre parlavo con un signore che si chiamava Adenauer o Kennedy, o che era il nipote di Stalin: "in fondo, per essere uno di Pianaccio, me la sono cavata abbastanza bene"". Di quella favola villereccia, Biagi è riuscito a farsi protagonista, sorretto dalla convinzione di essere più italiano degli altri. E chissà quanti suoi connazionali, leggendolo o ascoltandolo, si sono sorpresi a pensare che un po´ era vero.
Verità e realtà
Furio Colombo su l'Unità
Il "non c'è più" che proviamo e diciamo nel momento della scomparsa di Enzo Biagi nasce dal pauroso senso di vuoto per la perdita di un grande amico. Ma in questo caso il vuoto è più vasto e riguarda tutto il giornalismo, tutta la vita pubblica italiana. Non - non solo - nel senso di avere perduto il giornalista, bravo, severo, rapidissimo, esatto, implacabile, innovatore. Non solo perché se ne va il professionista che in tutta la sua lunga vita non ha perso un evento e non ha commesso un errore, di fatto o di giudizio. Nel suo percorso non ci sono, infatti, tortuosità o cancellature, non una. Il suo lavoro è sempre stato un paginone fitto di note, chiare subito. E confermate dopo, dal punto giusto in cui questo reporter si è sempre trovato (e poi ritrovato, ad ogni rivisitazione del suo, del nostro passato).
Ma questa perdita avviene adesso, nel peggior periodo del giornalismo e della vita pubblica italiana. È affettuoso e celebrativo dire, accanto al feretro di una persona amata e ammirata: "come lui ce ne sono più". La nostalgia dolorosa è sempre accanto alla perdita di chi è stato caro specialmente se ha avuto un ruolo e un peso nella nostra vita.
Enzo Biagi era una pianta robusta che si è estesa fino a questi giorni. Ma aveva le sue radici salde e profonde in un terreno diverso, in un tempo finito.
Quel tempo è stato segnato per sempre dalla la tragedia italiana, tra fascismo e antifascismo, e ha dato ragioni, motivazioni, necessità di scegliere. È stato il grande dono che molti hanno ricevuto dalla lotta vittoriosa al fascismo e che qualcuno (non tutti, non tanti, in una generazione) ha custodito come un tesoro per tutta la vita.
Ecco ciò che ci fa apparire Enzo Biagi così grande e importante alla fine del suo percorso. Perché la sua incorruttibile e non negoziabile intransigenza è divenuta cruciale in un'epoca triste e modesta della vita italiana in cui tutto è negoziabile, e una buona, conveniente negoziazione copre e cancella il vecchio argomento che una volta, un po' enfaticamente, si chiamava dovere professionale.
Il lavoro giornalistico, a parte nuovi eroi del nostro tempo che invocano ancora nome e prestigio della professione, ma sono star della società dello spettacolo, con regole, priorità, colpi di scena e performance ambientate nello spettacolo, non nelle regole del giornalismo (che sono severe, strette, imperiose e non violabili a piacere), il lavoro giornalistico è reso nano dal sovrapporsi di un vasto potere economico. È un fatto recente. Infatti il potere economico ha sempre avuto influenza e interessi da far pesare.
…
Ciò è accaduto in Italia - con una sorta di anticipazione profetica - quando un pesante potere economico dotato di tutti gli strumenti di persuasione negoziale, si è improvvisamente spostato dall'editoria (che stava comunque già trasformando in una struttura neo-feudale) alla vita politica e al governo. Sono mosse pesanti e drammatiche, che hanno urtato e tentato di abbattere, uno dopo l'altro, i due riferimenti più alti del giornalismo italiano, Indro Montanelli e Enzo Biagi. La storia esemplare vuole che uno dei due uomini liberi si sia trovato più vicino alla destra e l'altro alla sinistra. Ma, come ormai ci dicono in molti, queste sono definizioni d'altri tempi. Forse è vero, perché in tutti e due i casi è stata la forza intatta delle due persone e la loro inflessibile integrità a svelare il nuovo paesaggio, la nuova condizione di dominio delle informazioni.
…
La vita di Enzo Biagi è stata una vita di buon lavoro, impegnata a dare volto alla realtà, a non negarla mai, quando è benevola, quando è spiacevole, quando è intollerabile. È questa la parola che va messa al centro del ricordo vero e non solo ideale di Biagi: rappresentazione dei fatti come dovere, e non importa se i responsabili di quei fatti se ne dispiacciono e vorrebbero negoziare le loro finte notizie. La parola chiave non è la mitica verità, troppo spesso scritta con la maiuscola. La parola chiave è la semplice realtà, ciò che è realmente accaduto e che non sarà mai censurato.
Il fatto che i venditori di finte notizie (potenti e anche minacciosi fino al punto di toglierti il tuo lavoro benché tu sia stimato, ammirato, famoso) abbiano avuto tanto successo, e siano riusciti ad aprire, accanto a ciò che chiamavano giornalismo, un vivace mercato del falso di immagine, del falso prestigio, di falsi eventi, dando a questo mercato del falso una impetuosa corsia di preferenza anche nella grande stampa (oltre al dominio quasi completo della televisione) tutto ciò ha reso più grande ed eccezionale la figura e il senso del lavoro di Enzo Biagi, che a narrare la realtà non ha mai rinunciato.
I lettori di questo giornale ricorderanno che si è tentato di tutto per zittire chi ha tenacemente seguito “il percorso Biagi”, fino al punto di accusare di contiguità con il terrorismo ogni narrazione scrupolosa di ciò che stava accadendo. Ma, ti dice e ti lascia detto Enzo Biagi, tu continui lo stesso, almeno finché resta un giornale libero per farlo. Il resto sono giochi, come accorrere ad affollare certe trasmissioni tv per farsi vedere, non importa con chi.
Enzo Biagi non partecipava ai giochi, che sono parte del mondo dello spettacolo, e anche questo è un insegnamento da tenere vivo e tenere caro. È il nostro immenso debito di giornalisti e di amici.
La partita a poker di Berlusconi: sarà crisi
Francesco Verderami sul Corriere della sera
ROMA — I duellanti non cambiano copione: Prodi è certo di durare, Berlusconi è convinto di farlo cadere. Entro la prossima settimana si saprà — come dice il democratico Follini — "se andrà in esercizio provvisorio lo Stato o se entrerà in esercizio provvisorio la leadership del Polo". E proprio nell'opposizione si avvertiva ieri un certo pessimismo che accomunava gli alleati del Cavaliere e i dirigenti di Forza Italia. Il timore è che — quando si arriverà al fatidico voto finale del Senato sulla Finanziaria — nessuno si sfilerà dalla maggioranza, e il premier avrà vinto la sfida. Al clima hanno contribuito alcune confidenze dell'ex premier che sono giunte fino in Parlamento, la sua ammissione di aver dovuto depennare molti nomi scritti nella famosa agenda.
Per esempio quello della senatrice sudtirolese Helga Thaler, corteggiata a lungo, e "incontrata di persona " da Berlusconi, che ha raccontato di averla "invitata a pranzo quattro volte" a Palazzo Grazioli, senza che nessuno se ne accorgesse. "Lei sosteneva di esser pronta, però poi aggiungeva "il partito... il partito..." ". Il suo partito ha giurato fedeltà al premier. Il motivo l'ha spiegato l'azzurro La Loggia, che conosce Durnwalder, capo dell'Svp, "bravissima persona, ma per quanto di origini tedesche è un po' siciliano, come me. E infatti applica un detto delle mie parti: "A cu' ti duna pani, chiamalu papà". E se il pane lo dà Prodi, lui resta governativo".
Governativi sono restati anche Bordon e Manzione, "nemmeno loro ci stanno", ha avvisato il Cavaliere: "Eppure tutti mi dicevano che avevo ragione, che di questo governo non ne possono più". E mentre alla Camera i deputati forzisti si incupivano, dal Senato il capogruppo di An Matteoli informava Fini che "qui non c'è aria da ultima spiaggia nell'Unione ". Il leader della destra, parlando con i suoi, aveva avuto modo di criticare la tattica di Berlusconi: "Troppa enfasi. Lo so, è nella sua natura. Ma anche con Casini, non doveva dare l'idea che Pier torna a casa. Altrimenti, giustamente, quello s'incazza. Sono processi politici".
Ma perché tutti i maggiorenti della Cdl — Berlusconi in testa — ieri hanno provveduto a evocare l'imminente disfatta? Secondo il segretario del Pri Nucara, "bisogna capire se davvero il Cavaliere si è disilluso o se il suo è un atteggiamento tattico. Io propendo per la seconda tesi: siccome gli sono falliti alcuni agganci, non vuol dare a Prodi il vantaggio di conoscere anzitempo le altre sue mosse". Pare in effetti che Berlusconi sia sbottato durante una riunione, "perché appena parlo con qualcuno, subito quello viene chiamato a Palazzo Chigi. E Prodi apre i cordoni della borsa, con i soldi pubblici. Poi sarei io a corrompere...".
Insomma, più che una sfida politica sembra una partita di poker. Ieri sera il Cavaliere — dopo aver fatto filtrare tutto il giorno il suo pessimismo — ha confidato a un amico fuori dai giochi: "A nessuno ho svelato i nomi né la data, ho detto che sono scaramantico. Ma il governo cadrà. Dall'altra parte c'è chi attende un segnale, e al momento giusto arriverà ".
…
Intanto a uscire allo scoperto ieri è stato il senatore di Sinistra critica, Turigliatto: con una lettera inviata ai colleghi dell'Unione, ha annunciato che non voterà la Finanziaria, "anche se il governo mettesse la fiducia ". Dal mazzo di Prodi si è sfilata una carta. Berlusconi attende che Dini gli sfili il mazzo.
Ma Prodi è certo: non succede nulla
Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera
ROMA — "Non succederà niente, assolutamente niente": mentre Berlusconi prepara il trappolone, Romano Prodi sembra non avere nessun timore per il futuro. Ha parlato con tutti, da Dini a Pallaro, ai borderline del centrosinistra. In questo martedì in cui al Senato, miracolosamente, non accade quasi nulla (qualche mancanza del numero legale, ma che sarà mai, vista la situazione) il premier appare talmente sicuro di sé che si permette persino il lusso di elogiare con qualche alleato la tempra da combattente dell'avversario: "So quello che si dice: che se entro dicembre Berlusconi non fa cadere il governo è finito, ma non è così. Lui è bravissimo a volgere a suo favore le sconfitte. Alla fine è sempre lì, sempre il leader. Ha delle capacità di recupero e di ripresa che sono incredibili". Insomma, Prodi è convinto di poter continuare a navigare. Ma a modo suo. Lasciando Berlusconi lì nel suo ruolo di leader, perché tutto sommato gli conviene, e senza lisciare troppo il pelo a Pier Ferdinando Casini. Il premier, infatti, è convinto che il leader dell'Udc non tradirà il Cavaliere. Se non altro perché, spiega ai collaboratori, "la riforma della legge elettorale non si riuscirà a fare perché la Casa delle Libertà non ha nessun interesse a varare una riforma". Al massimo — è il ragionamento ad alta voce che l'inquilino di Palazzo Chigi va sviluppando in questi giorni — "per la paura del referendum" si potrà fare qualche aggiustamento. E allora tutta l'insistenza che D'Alema, Rutelli e Fassino stanno mettendo nelle loro dichiarazioni a favore del modello tedesco? O la riunione dell'altra sera all'assemblea del gruppo dell'Ulivo a Palazzo Madama dove l'orientamento prevalente è stato pro-riforma elettorale versione Germania? Tattica, secondo il premier, che è sicuro che non accadrà niente.
E il governo? "Un nuovo governo? — sorride Prodi parlando con un segretario di un partito dell'Unione — è facile a dirsi e difficile a farsi". Al massimo si potrà seguire il suggerimento di Mastella: "Veltroni dovrà prendersi l'onere di togliere qualche ministro del Pd". E Prodi sembra dare per scontate anche le trattative all'interno della maggioranza sul decreto per le espulsioni. Con la sinistra radicale, alla fine, si trova un accomodamento.
Lo stesso accadrà se sui precari, in Senato, vincerà la linea Dini. Per il resto, il premier è convinto che alla fine Dini resterà lì dove sta. E l'eco della direzione del Prc non sembra preoccuparlo. Eppure lì dentro Ramon Mantovani ha definito quello di Prodi un "governo nemico ", Rina Gagliardi lo ha chiamato "un esecutivo di merda" (anche se è disposta a tenerselo così com'è). E il capogruppo alla Camera Gennaro Migliore ha spiegato che il governo "è ostaggio del Pd perché l'azione proditoria di Veltroni ha determinato un condizionamento esorbitante rispetto all'interesse generale dell'Unione e perciò si deve sottrarre il governo da questo appalto e dire al leader del Pd che senza un patto chiaro non c'è la possibilità di realizzare una convergenza per il governo".
Ma Prodi non teme agguati dalla sinistra radicale.
…
Sulla testa della Cosa Rossa
Riccardo Barenghi su La Stampa
L'ultima spiaggia o, vista la materia, l'ultima frontiera della sinistra radicale è il decreto sulla sicurezza. Cioè quello che consente ai prefetti espulsioni lampo contro chiunque venga considerato criminale o solamente "pericoloso". In particolare, nel mirino del governo Prodi (anzi del governo Prodi-Veltroni) sono finiti i cittadini romeni, diventati capri espiatori a causa del mostruoso delitto consumato da uno di loro nella zona romana di Tor di Quinto. Oggi sono i romeni, ieri gli albanesi, l'altro ieri gli africani, domani saranno magari gli iracheni o gli afghani piuttosto che altri disgraziati (e tra loro altri criminali) fuggiti da qualche Paese povero o in guerra. Non è questo il punto, così come non ci piove sul fatto che chi delinque deve pagare, e anche duramente. Le leggi ordinarie esistono e se si vuole colpire chi commette delitti efferati, lo si può fare senza ricorrere a misure speciali (e magari anche incostituzionali) o a violenti sgomberi di campi nomadi all'alba.
Ma ovviamente ogni governo è libero di adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni, anche sfidando la Costituzione del Paese. Magari sarebbe stato meglio evitare di farlo sull'onda emotiva provocata dall'omicidio della signora Giovanna Reggiani (avvenuto a Roma, ché se fosse accaduto in qualsiasi altra zona d'Italia forse la reazione non sarebbe stata questa), magari sarebbe stato meglio che Prodi non avesse ubbidito come un soldatino all'ordine del sindaco della Capitale che aveva bisogno di accreditarsi con un gesto eclatante come leader del Partito democratico appena nato. Magari sarebbe stato meglio che i ministri della sinistra radicale, la cosiddetta Cosa rossa, avessero seguito un minimo di coerenza con le loro posizioni politiche, votando no in Consiglio dei ministri o almeno astenendosi.
Non l'hanno fatto, anche loro hanno scelto di seguire l'onda. E solo adesso cominciano i distinguo: "Non lo votiamo se non viene modificato". Forse qualcosa riusciranno pure ad ottenere in Parlamento, e già ieri il ministro Amato ha concesso qualche modifica al suo collega Ferrero ammorbidendo un po' la norma sulle espulsioni. Ma la sostanza non cambia. E la sostanza politica è che per l'ennesima volta in un anno e mezzo di governo la sinistra dell'Unione si autocostringe a ingoiare un rospo – e che rospo – che mai e poi mai avrebbe nemmeno immaginato di ingoiare.
…
È allora giusta la domanda che si sono posti il direttore del quotidiano di Rifondazione Piero Sansonetti e Valentino Parlato sul manifesto: "Ma che ci stiamo a fare al governo?". Non si tratta di una pura provocazione ma di una questione che agita parecchio i militanti, gli iscritti e gli elettori dei partiti della sinistra. E agita pure i suoi dirigenti. I quali hanno finora scelto una strada saggia, spiegando un giorno sì e l'altro pure che, nonostante tutto, loro restavano al governo perché avevano fatto una scommessa politica primaria: cambiare il Paese e rimediare ai danni provocati dal governo Berlusconi.
Peccato però che il Paese finora non sia stato cambiato, almeno non nella direzione auspicata dalla sinistra radicale. Solo per citare alcuni fatti: le nostre truppe sono ancora in Afghanistan, mentre la Cosa rossa vorrebbe il loro rientro in patria ma continua a votare a favore, diciamo per carità di patria; l'accordo sulle pensioni non è stato gradito; quello sul Welfare ancor meno; la legge sulle coppie di fatto è scomparsa non si sa dove... E adesso l'ultima goccia, anzi l'ultimo macigno. Che sta precipitando sulla testa dei dirigenti di una sinistra che ha sempre avuto tra i suoi valori fondamentali quelli dell'accoglienza, dell'integrazione, della tolleranza, della società multietnica, dello Stato di diritto. E che oggi si trova a dover approvare una legge che smentisce tutto questo. In nome di un'alleanza di governo nella quale è ormai evidente quanto sia scarso, se non inesistente, il suo peso politico. E in nome del pericolo che "sennò torna Berlusconi".
Ma diciamoci la verità, se il governo Berlusconi avesse preso un provvedimento del genere, tutta la sinistra, anche gran parte di quella che oggi sta nel Partito democratico, compreso il suo leader, sarebbe scesa in piazza. Ma Berlusconi non l'ha varato quel decreto, a proposito dei danni provocati dal suo governo...
E Fini disse: "Rumeni, venite"
Umberto De Giovannangeli su l'Unità
Ora Fini grida al lassismo. Ora mette sotto accusa l'"aperturismo" del governo Prodi tirando in ballo anche il sindaco di Roma. Ora chiede maggiore severità, pone condizioni per approvare il pacchetto sicurezza predisposto dal governo.
Ora guarda con preoccupazione allo "sbarco" di romeni in Italia. Ora chiede al presidente del Consiglio, al ministro degli Esteri e a quello dell'Interno di fare la voce grossa nei riguardi di Bucarest. Ora. Perché in un passato non lontano, Gianfranco Fini ben altra attenzione e predisposizione aveva manifestato verso la Romania. Arrivando, come vedremo, ad auspicare la fine delle "perduranti restrizioni dei visti d'ingresso".
Premessa d'obbligo: bene fa Romano Prodi a non dare il minimo avallo ad una campagna di criminalizzazione di "romeni e Rom" imbastita dall'estrema destra. Ma per correttezza storica va dato a Fini ciò che è di Fini. Ed è stata cura dell'allora ministro degli Esteri accelerare l'ingresso di due Paesi dell'ex blocco sovietico nell'Unione Europea: Bulgaria e, per l'appunto, Romania. Vale la pena riprendere i giornali dell'epoca, e mettere in fila le dichiarazioni dell'allora titolare della Farnesina e del suo entourage che ponevano l'accento sulla necessità dell'Europa di guardare con decisione ad Est lasciando perdere ogni pericolosa velleità di puntare verso Sud, magari pensando di allargare la cristiana Europa all'islamica Turchia.
…
Quando si aprì la discussione sull'apertura a Bulgaria e Romania, nella Ue si sviluppò un vivace dibattito. Sul tavolo c'erano i dossier che segnalavano la difficile transizione democratica in atto nei Paesi dell'Est. In discussione non era l'approdo finale - l'ingresso di Sofia e Bucarest - quanto la gradualità, in altri e più concreti termini, diverse cancellerie europee posero il problema di introdurre norme transitorie per l'ingresso della Romania nell'Unione. Norme cautelative. Che inerivano fra l'altro, al rispetto dei diritti umani delle minoranze, in particolare della comunità rom. Riprendiamo i giornali dell'epoca, alla ricerca di dichiarazioni e pronunciamenti ufficiali dell'allora ministro degli Esteri al riguardo. Non ne abbiamo trovato traccia. Anzi. Nelle esternazioni di esponenti dell'allora maggioranza di governo che accompagnarono la parte conclusiva della trattativa per l'ingresso della Romania nella Ue, il tratto comune era quello dell'enfasi nel segnalare un passaggio storico che sanciva la definitiva sepoltura del comunismo nel Vecchio continente.
Leggiamo i resoconti del tempo, e ci imbattiamo nelle preoccupazioni sollevate, ad esempio, da Germania e Francia. A questo punto, una opportuna parentesi storica: la Romania ha fatto domanda d'ingresso nell'Unione Europea il 22 giugno 1995. Nel dicembre 1999, al Consiglio europeo di Helsinki, veniva invitata ad avviare i negoziati di adesione, ultimati alla fine del 2004. Occhio alle date: sono gli anni in cui a Palazzo Chigi alberga Silvio Berlusconi e alla Farnesina risiede Gianfranco Fini. Il 25 aprile 2005, a Lussemburgo, la firma del Trattato di adesione di Romania e Bulgaria all'Ue, concludeva la quinta tappa dell'allargamento. Infine, il rapporto della Commissione Ue del settembre 2005 ha raccomandato l'adesione dei due Paesi all'Unione (entrata ufficialmente in vigore l'1 gennaio 2007). A dare il via libera a quell'ingresso, con il consueto surplus di enfasi mediatica, fu Silvio Berlusconi. E con lui, un passo indietro per non oscurarlo, Fini.
Sfogliando i giornali di quei giorni, colpisce un dato comune ai reportage da Bucarest: dall'uomo della strada ai leader politici, l'entusiasmo della Romania si concentrava su un aspetto: ora, dopo l'ingresso nella Ue, i boccaporti dell'immigrazione erano aperti. E sì che nella fase cruciale della trattativa per l'ingresso in Europa, tra le norme transitorie, vi era anche quella di concordare con il governo di Bucarest una regolamentazione dei flussi migratori negli altri Paesi dell'Unione. Abbiamo cercato traccia di una condivisione di questa necessità da parte dell'allora presidente del Consiglio o del ministro degli Esteri: non ne abbiamo trovato traccia. Mentre traccia è rimasta di una esultante dichiarazione del ministro Fini, a conclusione di un suo articolo (è il 30 aprile 2005) sul Corriere della sera: "Se è vero che il futuro dei Balcani è nell'Europa è altrettanto vero che negli stessi Balcani è anche il futuro di questa nostra Europa… A maggior ragione dopo il recente accesso della confinante Ungheria e nella prospettiva dell'adesione della Romania e della Bulgaria a partire dal 2007…". Ma è nel passaggio finale che la memoria del leader di An mostra oggi un clamoroso buco. Eccolo: "Anche per aspetti solo apparentemente secondari ma da alta sensibilità presso la gente comune, come le perduranti restrizioni dei visti d'ingresso, che effettivamente accentuano il senso di frustrazione di popolazioni che vorrebbero sentirsi parte di un'unica famiglia Europea". Altro che norme transitorie… A quei tempi, i bersagli preferiti dagli alleati leghisti, e non solo, del ministro degli Esteri erano altri: gli extracomunitari di colore, gli albanesi, l'islamico e dunque terrorista… Nessun dubbio nei rapporti con Bucarest, come si evince dalla nota della Farnesina del 12 ottobre 2005, che dà conto del cordiale incontro tra "vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Gianfranco Fini e primo ministro romeno Popescu-Tariceanu", il quale ha "espresso il più vivo ringraziamento per il sostegno dell'Italia in tutto l'arco del processo di integrazione europea della Romania…". Non meno enfatico del suo ministro degli Esteri, e come avrebbe potuto esserlo, è Silvio Berlusconi. Un salto indietro nel tempo. Due luglio 2003, discorso del Cavaliere all'Europarlamento per l'insediamento della presidenza italiana: l'Italia, sottolinea Berlusconi, punta decisamente a far entrare nel 2007 Bulgaria e Romania nell'Unione Europea. E, fuori dall'ufficialità, una fonte al seguito del premier chiosò: i Paesi ex comunisti aiutano a far argine ai comunisti di casa nostra… Questo per buttarla in politica, perché c'è poi un'aggiunta di "colore": le romene sono proprio delle bellezze…Sono passati solo pochi anni da queste edificanti esternazioni. Ma oggi sia Berlusconi che Fini sembrano aver dimenticato. Troppo facile. Troppo comodo.
Ciampi:”Sull'allargamento siamo stati precipitosi”
Paolo Passarini su La Stampa
ROMA. Anche se non lo dice apertamente, Carlo Azeglio Ciampi soffre quando, di volta in volta, sente attribuire all'unificazione europea la responsabilità di questo o quel problema. Europeista antico e senza riserve, riconosciuto ovunque come uno dei padri nobili dell'Unione, il presidente emerito è convinto che, se certamente nel corso del processo sono stati compiuti errori che hanno avuto conseguenze anche serie, parecchie delle colpe che vengono imputate all'unificazione sono in realtà infondate. Adesso, per esempio, si parla molto di flussi migratori incontrollati dall'est Europa.
C'è chi sostiene che sarebbe opportuno rinegoziare l'accordo di Schengen. Cosa ne pensa il predecessore di Giorgio Napolitano?
"Mi pare di no. In queste vicende Schengen non c'entra. L'accordo di Schengen riguarda ancora un gruppo ristretto di paesi che sono tenuti ad applicarlo. Ma tra questi non c'è ancora né la Romania, né alcun altro dei paesi entrati con il recente allargamento".
Dunque c'entra invece l'allargamento, che ha consentito anche ai cittadini di questi paesi di circolare con un passaporto europeo?
"Be', sì. L'allargamento per forza c'entra. Vede, noi, voglio dire noi paesi fondatori dell'Europa unita, abbiamo pagato un doveroso riguardo nei confronti di paesi che volevano sottrarsi a quella che era stata l'egemonia dell'Urss. Siamo stati generosi, doverosamente generosi, ma siamo stati ripagati male. Tanto è vero che proprio alcuni dei più importanti dei paesi nuovi entrati si sono poi battuti contro il Trattato costituzionale. E quella è stata anche la fine del Trattato".
Certo, ormai, tutto questo è passato. Ma si sarebbe potuto fare meglio?
"Sì, certo, ormai è andata così. D'altra parte, non si poteva non dar seguito a un evento storico così importante non rispondendo alle loro richieste. Ma probabilmente occorreva valutare meglio il loro grado di maturazione. Voglio dire - anche se mi dispiace usare questa parola - che l'allargamento è stato fatto precipitosamente, in tempi non ancora maturi. L'Europa non aveva ancora le istituzioni necessarie per governare una situazione così complessa. Occorreva prima chiudere il Trattato. In questo modo i nuovi aderenti avrebbero anche aderito al Trattato. Sennò avrebbero potuto decidere di stare fuori".
Sta di fatto presidente, che, per una ragione o per l'altra, l'Unione Europea è sempre meno popolare. Forse tutto è cominciato con l'euro...
"Ho letto anche di recente l' articolo di un economista, che sosteneva: “Per fortuna è stato fatto l'euro”. Certo, i prezzi di alcuni prodotti avrebbero dovuto essere meglio protetti. Ma cosa saremmo oggi senza l'euro? Un euro così apprezzato sul dollaro abbassa i costi di molte materie prima, a cominciare dal petrolio. E' vero che gli industriali devono competere con un dollaro più basso, ma in compenso risparmiano molto sui costi di produzione. E poi godiamo dei benefici di un forte stabilità monetaria. No, mi creda, l'euro è stato una benedizione".
…
Pillola abortiva, partita la richiesta
Mario Reggio su la Repubblica
ROMA - L´azienda francese Exelgyn ha presentato la domanda per la commercializzazione in Italia della pillola abortiva Ru486. La richiesta è stata inoltrata ieri all´Emea, l´Agenzia europea per i farmaci, che ha sede a Londra. In base al principio del "mutuo riconoscimento", visto che la pillola è stata già sperimentata ed utilizzata in quasi tutti i Paesi della Ue, il via libera sarà automatico passati 90 giorni dalla presentazione della domanda. In Italia non verrà commercializzata nelle farmacie, ma somministrata solo nelle strutture ospedaliere pubbliche.
La notizia, confermata dall´azienda francese, rischia di riaccendere le polemiche che da tre anni contrappongono trasversalmente gli schieramenti politici. L´ultimo episodio risale alla fine di ottobre di quest´anno, quando Benedetto XVI ha invitato all´obiezione di coscienza i farmacisti. Una presa di posizione che ha provocato una decisa presa di posizione da parte del ministro della Salute Livia Turco: "Sulle regole solo il Parlamento è sovrano, la parola del pontefice è autorevole, ma nella sua dimensione pastorale. Chiederò al Consiglio Superiore di Sanità un atto d´indirizzo perché la metodica della Ru486 sia inserita scrupolosamente nell´ambito della legge 194, quindi somministrata solo ed esclusivamente nelle strutture pubbliche".
Le prime polemiche scattano nell´estate del 2005. Il Comitato Etico dell´ospedale Sant´Anna di Torino autorizza la sperimentazione della pillola abortiva. L´allora ministro della Salute, Francesco Storace, da poco insediato non perde tempo. Manda gli ispettori a Torino per bloccare la sperimentazione della Ru486. Gira voce che venga somministrata a domicilio. Il ginecologo Silvio Viale, che coordina la sperimentazione al Sant´Anna, replica: "è falso, tutto avviene in ospedale". Intanto le richieste di usare la pillola abortiva, prodotta in Francia, ma mai commercializzata in Italia perché l´azienda non ritiene il mercato italiano "appetibile", aumentano. Viene usata, in alternativa all´aborto chirurgico nell´ospedale Lotti di Pontedera, con il sostegno dalla Regione Toscana. Il ministro Storace tenta di arginare il fenomeno ma non ci riesce. Minaccia di modificare la legge 194 sull´aborto e di far entrare i volontari del Movimento per la Vita nei consultori pubblici. Dopo il Piemonte e la Toscana l´acquisto in Francia della Ru486 viene annunciato anche da altre strutture ospedaliere in Liguria, Lazio, Campania ed Emilia-Romagna.
Cambia la maggioranza in Parlamento e la Ru486 non è più un tabù.
…

 7 novembre 2007
7 novembre 2007
![]() 7 novembre 2007
7 novembre 2007