



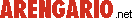
La settimana in rete
a cura di Primo Casalini - 24 giugno 2007
Una scossa alla sinistra dal sindaco d'Italia
Eugenio Scalfari su la Repubblica
L´ultimo episodio politico in ordine di tempo è stato l´affondo della sinistra radicale contro Padoa-Schioppa, contenuto in una lettera a Prodi firmata da quattro ministri: Ferrero, Mussi, Bianchi e Pecoraro Scanio.
Il segretario della Cgil l´ha commentata con queste parole: "A me pare che nel governo ci sia un problema che riguarda proprio lui (Padoa-Schioppa).
L´impressione è che abbia tutti contro, anche l´Associazione dei Comuni protesta contro di lui. Io fin dall´inizio ho avuto la sensazione che lui non volesse l´accordo con noi. La ragione non l´ho capita, ma non credo che sia solo tattica".
In realtà la sensazione che abbiamo avuto in molti fin dall´inizio è esattamente l´opposto: che fosse Epifani a non volere l´accordo sulle pensioni e mirasse – fin dall´inizio – ad un collateralismo inedito tra Cgil e Rifondazione comunista. Assolutamente inedito: la Confederazione del lavoro esiste da un secolo e non è mai stata alleata con la sinistra massimalista. Se collateralismo c´è stato – e c´è stato – la sponda politica si è costituita con i riformisti del Partito socialista e poi con i riformisti del Pci. Il connubio di queste ultime settimane rappresenta dunque un´anomalia nella storia del maggior sindacato italiano e si può spiegare soltanto con il tentativo di Epifani di riassorbire il sinistrismo radicale della Fiom. Con la conseguenza di scaricare sull´intero mondo del lavoro un conflitto interno alla sua organizzazione e di coinvolgervi la stessa sopravvivenza del governo nazionale.
E´ augurabile che la tempesta sia superata nella prossima riunione.
Probabilmente la soluzione "tecnica" sarà quella di sostituire lo "scalone" con un solo scalino e poi con le "quote". Il linguaggio è cifrato ma significa alzare gradualmente l´età pensionabile adottando una cifra che sia la somma tra l´età e il numero delle annualità contributive versate. Se la quota prescelta fosse per esempio 96 e se le annualità contributive versate fossero 35, si andrebbe in pensione a 61 anni ma anche a 56 anni se i contributi versati fossero 40 invece di 35. Questo tipo di approdo ha comunque un costo che il Tesoro stima in 1.2 miliardi da aggiungere a quelli già previsti fin dall´inizio del negoziato con le parti sociali. E questi sono i soldi aggiuntivi che Prodi sta chiedendo a Padoa-Schioppa. Il ministro del Tesoro probabilmente li troverà, almeno per i primi due esercizi, 2008-2009. Oltre quella data il problema traslocherà dalle spalle di Prodi a quelle di Veltroni poiché tutto fa pensare che in quel momento saremo in piena campagna elettorale.
Accetterà la Cgil questa soluzione "tecnica"? Oppure si limiterà a riaffermare che lo "scalone" previsto dalla legge Maroni deve essere abolito, punto e basta, facendosi risucchiare dalla sinistra radicale? Per certi aspetti Epifani ricorda Montezemolo. Il segretario della Cgil vuole riassorbire l´estremismo della Fiom ma rischia d´esser lui riassorbito dal movimentismo dei metallurgici. Simmetricamente Montezemolo vorrebbe riassorbire l´estremismo delle piccole imprese – lo spirito di Vicenza – ma finora è lo spirito di Vicenza che ha riassorbito Montezemolo.
Quanto alla sinistra radicale, essa sta giocando sul terreno dei temi sindacali una partita eminentemente politica: la candidatura di Veltroni alla leadership del Partito democratico ha spiazzato molte posizioni, a destra, al centro, a sinistra. Ha spiazzato Berlusconi, Casini, Rutelli, Fassino e anche tutta l´ala radicale dell´Unione.
Un partito riformista proiettato verso l´obiettivo del 35 per cento dal consenso elettorale, con un bacino potenziale che potrebbe arrivare addirittura al 40 preoccupa molto l´area che va da Mussi a Rifondazione comunista. Di qui la necessità di battere un colpo ed acquistare una visibilità notevolmente offuscata, come hanno dimostrato le recenti elezioni amministrative.
Il tema delle pensioni e delle risorse da destinare al potere d´acquisto dei redditi meno abbienti rappresenta il terreno ideale per un tentativo di riconquista del cosiddetto movimento. Ecco la non recondita ragione per la quale lo scontro tra il ministro del Tesoro e sinistra radicale e sindacale ci conduce ad esaminare la scesa in campo di Walter Veltroni e gli effetti che fin d´ora ne derivano.
* * *
Una volta tanto cominciamo dagli effetti anziché dalle cause. Sono sotto gli occhi di tutti: la sua candidatura ha rincuorato una parte notevole dei "disincantati" del centrosinistra, quella massa di elettori dell´Ulivo che nelle recenti amministrative hanno preferito disertare le urne per mandare un segnale senza con questo passare all´antipolitica o addirittura dall´altra parte dello schieramento politico.
La scossa è stata forte, il segnale è arrivato. Si poteva temere che l´annuncio della candidatura di Veltroni non fosse sufficiente a scuotere l´apatia dei "disincantati". Invece l´atmosfera politica è cambiata di colpo.
Si direbbe che i "disincantati" non aspettassero altro. Gli ultimi sondaggi registrano un salto di dieci punti nelle intenzioni di voto in favore del nascituro Partito democratico, dal 25 al 35 per cento con l´Unione che ha di nuovo superato lo schieramento di centrodestra.
Riemerge con gran forza il problema se, nelle nuove condizioni, sia ancora ripresentabile la candidatura di Berlusconi. La nuvola di tempesta tende ora a spostarsi verso Arcore e questa è un´altra novità.
Gli scettici ad oltranza concentrano le loro critiche sull´eccesso di unanimismo che attornia il sindaco di Roma, propostosi come sindaco d´Italia.
Secondo loro le primarie che si terranno il 14 ottobre per eleggere il leader del Partito democratico e nello stesso tempo i delegati all´Assemblea costituente che dovrà dare forma e struttura al nuovo partito, si trasformeranno in un plebiscito. Sempre secondo loro il plebiscito non serve a costruire una leadership. In teoria hanno ragione ma in pratica hanno torto. Non considerano che un plebiscito non è neppure pensabile se una leadership non esiste già. Il plebiscito non è che la ratifica popolare d´una leadership già esistente, che è appunto il caso di Veltroni. Ancora una volta D´Alema l´ha capito per primo ed è lui che ha fatto la prima mossa per disincagliare il Partito democratico dalle secche in cui si era arenato.
Probabilmente altre candidature ci saranno alle primarie del 14 ottobre, ma serviranno soltanto a posizionare alcune correnti all´interno della Costituente.
Operazione rischiosa, con la testa rivolta all´indietro verso ricordi identitari e ideologie che il nuovo partito dovrebbe invece superare. Del resto il tandem Veltroni-Franceschini è già una risposta al pericolo di perpetuare la distinzione tra Ds e Margherita. E´ un tandem messo in campo proprio per superare quella dicotomia originaria, non certo per perpetuarla. Un tandem operativo e non ideologico.
Qualcuno ha scritto che con Veltroni si passerà dalla politica degli "aut-aut" a quella degli "et-et", cioè dall´ideologia al pragmatismo delle cose da fare. Mi sembra che questa formulazione sia appropriata al tandem Veltroni-Franceschini. Ed è quella di cui il paese ha bisogno.
Dico tuttavia che questa strategia degli "et-et" non è affatto lontana da quella che sempre è stata auspicata e praticata da Prodi. Eppure Prodi è avvolto da una nube di ostilità mentre la popolarità di Veltroni si trova al culmine dei consensi. Come mai? Capacità di comunicazione a parte, come mai? Ecco una bella domanda cui rispondere.
* * *
Secondo me la risposta è molto semplice. Prodi, uomo senza partito, è stato il candidato d´una coalizione di partiti ormai arrivati al capolinea, indipendentemente dalla loro storia, dalla qualità morale e intellettuale dei loro dirigenti, dal loro radicamento sul territorio. Nessuno di quei partiti aveva più un orizzonte davanti a sé, nessuno poteva illudersi di creare un orizzonte nuovo e perseguirlo da solo.
Da solo poteva soltanto immaginare che portare avanti lotte di potere, complicate ipotesi di nuovi schieramenti, scomposizione e ricomposizione di sigle e correnti o infine – per quanto riguarda i piccoli e piccolissimi – il ricatto di mandare in crisi il governo data la scarsissima maggioranza al Senato. Quindi ricerca perenne di visibilità, perenne litigiosità all´interno della maggioranza e del governo, discredito sempre più diffuso nella pubblica opinione. Di tutto ciò Prodi ha pagato il conto, ma non lui soltanto; l´ha pagato l´intera coalizione in quanto tale e quindi la governabilità del paese.
Questa classe di governo ha comunque prodotto, nonostante le difficilissime condizioni esistenti e in larga misura auto-create, alcuni risultati positivi che emergeranno se e quando il polverone che staziona da tempo sull´operato del governo si dissiperà.Continuo a pensare che la Finanziaria del 2007 sia stata importante per aver rimesso in piedi la finanza pubblica, avere incentivato la produttività delle imprese con lo sgravio dell´Irap, avere avviato una politica di redistribuzione che ora dovrebbe passare da un livello simbolico ad un livello effettivo. Infine questa classe di governo "moritura" (come i "morituri" di Palazzo Carignano, il vecchio Parlamento piemontese che proclamò la nascita dello Stato italiano) ha immaginato e perseguito la creazione del Partito democratico affrontando il giudizio di una platea di elettori nuovi, attivi, decisi a superare e anzi a sotterrare le vecchie nomenclature. Ne va dato merito a entrambi i gruppi dirigenti dei due partiti promotori e in modo particolare a Fassino e a Rutelli. Resta una domanda: riguarda il paese, la sua fibra morale, la sua passività e reattività. Finora le prove non sono state esaltanti. Potranno migliorare?
* * *
Si è sempre detto che in democrazia si possono cambiare e alternare i gruppi dirigenti, ma non si può chiedere al popolo di dimettersi. Ovviamente è così. Ma che cos´è il popolo se non la sua classe dirigente nel senso più ampio del termine: politici, amministratori, imprenditori, intellettuali, ricercatori, professionisti, scuola, Università? Si dice anche: ogni popolo ha la classe dirigente che si merita, ma questo è sbagliato. Questo modo di dire va capovolto: ogni classe dirigente ha il popolo che si merita. Se il popolo si comporta male rispetto alla responsabilità del proprio presente e del proprio futuro, dipende dal fatto che la classe dirigente non fornisce l´esempio dovuto. Nella storia è sempre stato così e penso proprio che sempre così sarà.
La classe dirigente italiana, salvo brevi intervalli e poche luminose figure, ha avuto scadente qualità. Il trasformismo del piccolo cabotaggio è stato pratica diffusa e così la corruttela politica, la cupidigia, l´esercizio del potere usato prevalentemente per mantenere il potere, la mancanza di carattere, il servilismo e il ribellismo a corrente alternata. L´impunità.
Questi difetti sono presenti in tutte le classi dirigenti, non si può infatti immaginarne una composta di angeli o di filosofi stoici. Platone la vagheggiò.
Marc´Aurelio altrettanto. Ma si sa come finirono quelle utopie.
Il guaio accade quando quei difetti fisiologici diventano patologia. In Italia questa discesa di livello è avvenuta più spesso che altrove ed ora il compito che incombe soprattutto ai giovani è di ricondurre la qualità della classe dirigente e i suoi difetti nell´ambito della fisiologia, di modo che possano anche rifulgere le qualità che certamente essa possiede.
* * *
I difetti e le patologie dei politici le conosciamo ampiamente. Non si fa che discuterne da tempo. Non abbastanza, secondo me, quelle di altri settori della classe dirigente. Penso per esempio alla questione delle tasse che da anni infiamma l´Italia. So bene di toccare un nervo scoperto, ma che altro sarebbe la professione che faccio se non quella di toccare i nervi più sensibili per capire la natura di ciò che avviene? Le tasse. Sono troppo alte. Tutti lo sanno e lo dicono. Le spese sono troppo alte, tutti lo sanno e lo dicono. L´evasione fiscale è troppo alta, tutti lo sanno e lo dicono. Padoa Schioppa e Visco (i due nomi più impopolari d´Italia) l´hanno quantificata sulla scorta dei dati Istat: 100 miliardi di imposte evase, più di 300 miliardi di imponibile che sfugge al fisco. Tutti sono d´accordo di combatterla. Da qualche parte l´evasione starà.
Ebbene, l´evasione sta dovunque l´imposta non sia trattenuta alla fonte. Non dico con questo che i lavoratori dipendenti siano dei santi. Dico che il reddito da lavoro dipendente è il solo che non sfugge e non può sfuggire.
I lavoratori dipendenti sono 20 milioni di persone. I pensionati sono 16 milioni. Il lavoro autonomo in tutte le sue forme occupa 4 milioni di persone. Anche i lavoratori dipendenti e i pensionati spesso fanno doppio lavoro e il loro secondo lavoro assume forme autonome o addirittura sommerse. Queste sono le quantità ed è ovvio che l´evasione sta interamente nei redditi che non hanno un sostituto d´imposta. Dove si deve cercare allora l´evasione? Sulla luna?
Negli scorsi giorni non ho trovato un solo giornale che aprisse la prima pagina sulle dichiarazioni dei redditi autonomi pubblicate dall´Istat. Salvo due volte "Repubblica" e una volta "La Stampa". Grandi titoli invece alle proteste (e i fischi al governo) dei commercianti, degli artigiani, dei professionisti. Le tabelle dei ridicoli redditi dichiarati nelle pagine interne, i fischi in prima pagina e spesso in apertura di pagina.
Poiché faccio questo mestiere auspico che anche i giornalisti, che fanno parte anch´essi della classe dirigente, correggano alcuni dei loro evidenti errori e non soltanto gli errori degli altri. Sparare la notizia dell´uomo che morde il cane è sacrosanto ma quali sono l´uomo e il cane della metafora?
Bastonare sempre e comunque il governo non è più una notizia. Bastonare la politica e gli uomini politici non è più da tempo una notizia. Bastonare il cane che affonda è semplicemente sadismo (metaforico).
Perciò io continuo a difendere Prodi, Padoa Schioppa e Visco. E Bersani. Poiché fischiarli è ormai come un cane che morde l´uomo, io mi metto nell´angolo opposto.
Del resto i buoni giornalisti hanno sempre fatto così.
La Prima Repubblica finisce adesso
Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera
Abbiamo tutti più o meno pensato che la Prima Repubblica — o almeno, diciamo, il suo sistema politico — fossero finiti nel 1992-'94. Ma ci siamo sbagliati. In realtà essa sta finendo solo ora, in questi mesi, sotto i nostri occhi: perché è solo ora che il processo iniziatosi allora con la crisi-decomposizione dei partiti di centro e di centro-sinistra fondatori del sistema nel 1945-48 (la Dc e il Psi principalmente) sta arrivando a compimento con la crisi-decomposizione del pezzo di sinistra a suo tempo fortuitamente salvatosi, e cioè quella cattolica e comunista. (Da questo punto di vista la fondazione — per ora e per meglio dire, la tentata fondazione — del Partito democratico ha lo stesso valore sintomatico e semplicemente palliativo, mi pare, del cambiamento di nome in Partito popolare allora tentato dalla Dc).
Certo, le intercettazioni telefoniche di D'Alema e Fassino appena pubblicate non hanno nulla di penalmente rilevante, ma di simbolicamente rilevante sì, eccome! E in politica ciò conta in misura anche maggiore. Quelle parole, infatti, hanno spazzato via l'immagine d'innocenza, l'alone di purezza, che erano riusciti a sopravvivere a Mani Pulite, lasciando così in vita la cultura del vecchio Pci e dunque aperta la crisi scoppiata nel 1992-93. La quale ebbe nella corruzione solo il suo innesco, non certo la sua vera causa, che invece stava nell'esaurimento storico di tutte quante le culture politiche della Prima Repubblica, inclusa quella del vecchio Partito comunista. Come oggi ci è chiaro, dopo che da quindici anni (quindici anni!) vediamo proprio quella cultura dibattersi nell'inutile tentativo (che nulla ci assicura oggi destinato invece al successo), da un lato di rinnovarsi in senso moderato, restando però in certo modo sempre se stessa, dall'altro di trovare una piattaforma di valori comune con l'area cattolica. In questo per il momento inutile tentativo si rispecchia, come dicevo, un dato storico. Quello delle culture politiche tipiche della Prima Repubblica che avendo visto tutte quante la luce nei primi due, tre decenni del Novecento si sono mostrate ottimamente capaci di accompagnare l'Italia nella fase della sua piena industrializzazione/ modernizzazione (non a caso avviata dal fascismo, loro sostanziale coetaneo); non solo: ma soprattutto per circostanze fortemente dipendenti dal contesto internazionale esse sono riuscite altresì a coniugare quella modernizzazione con la democrazia, dando vita alla Repubblica. E però, quando è finita l'epoca della modernizzazione del Paese ed è iniziata quella della sua piena modernità, quelle stesse culture politiche hanno mostrato i propri limiti. Capaci di mobilitare energie intellettuali e sociali in vista di un grande sforzo nazionale, all'interno di una società ancora sostanzialmente arretrata, e di governare quelle energie in modo "forte", esse non avevano, invece, la capacità di organizzare in modo appropriato un sistema democratico-capitalistico maturo, e di gestire in modo efficace ma "leggero" le relative relazioni sociali, culturali e industriali.
La corruzione è stata (ed è!) "soltanto" la manifestazione e la conseguenza patologica di questa incapacità che dura da almeno vent'anni: la quale nella sostanza è mancanza di cultura democratica circa i limiti del governare, e insieme mancanza di progetti generali adatti a una società ormai articolatissima nonché, dall'università ai trasporti, immersa nel confronto con gli altri. E' per questa incapacità delle sue culture politiche che la Prima Repubblica è entrata nel 1992 in una lunga agonia, ed è di questa incapacità, mai sanata, che ora sta finalmente morendo.
I mostri del passato
Barbara Spinelli su La Stampa
Dicono che l'esperienza e gli errori servono a maturare, ma per l'Unione europea le cose non stanno così: nel vertice di Bruxelles che venerdì e sabato doveva salvare la Costituzione dei Ventisette si è scelto di tornare indietro, non di andare avanti e di ripartire dal punto più alto cui si era arrivati. Hanno contato più i pochi Stati ansiosi di frenare l'Unione, che non gli Stati che in gran parte avevano già ratificato il progetto costituzionale proposto nel luglio 2003 dai rappresentanti del popolo, dei governi, delle istituzioni europee. Pochi Stati hanno spadroneggiato sui più, e a forza di spadroneggiare hanno spostato le lancette degli orologi costringendo il tempo ad arretrare e a cancellare non solo le esperienze vissute ma anche le risposte date agli errori passati.
La finta che da decenni consuma l'Europa ricomincia dunque, impermeabile agli insegnamenti della storia: continua l'abitudine a costruire l'Europa senza darle né il metodo né i mezzi né le parole per affermarsi. Non solo: pur appellandosi alle volontà dei cittadini, pur affermando di voler riavvicinare l'Europa alle popolazioni deluse, i capi di Stato e di governo hanno ignorato il parere delle genti. Il popolo europeo non aveva chiesto queste pavide rinunce. Aveva chiesto una costituzione europea, in cui potersi identificare come ci si identifica con le costituzioni nazionali: il 66 per cento l'aveva reclamata con forza, nel sondaggio Eurobarometro di giugno. Non è quello che gli Stati gli hanno dato, se è vero che perfino la parola costituzione li ha impauriti. Gli Stati hanno protetto non i popoli ma se stessi e le proprie false sovranità. Il linguaggio del progetto costituzionale era troppo farraginoso - era stato detto e per questo francesi e olandesi l'avevano respinto nel 2005. I testi odierni hanno un linguaggio infinitamente più opaco, impenetrabile, ambiguo. Più precisamente, i Ventisette sono tornati al trattato di Nizza del 2000, migliorandolo in alcuni punti importanti ma non decisivi. Di qui l'impressione che sette anni siano passati invano, quasi non fossero esistiti. Non è esistito il momento in cui fu chiaro a tutti che Nizza era una trappola paralizzante, e venne convocata una Convenzione più rappresentativa delle volontà popolari. Non è esistita la decisione di affidare la riforma delle istituzioni e dunque la nascita di un'Europa politica non più a governi gelosi delle proprie prerogative ma a un corpo più democratico (la Convenzione appunto, composta di rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei governi, del Parlamento europeo, della Commissione di Bruxelles). Ogni futura modifica non richiederà la convocazione di un'analoga Convenzione, come era scritto nella parte quarta della Costituzione oggi affossata (articolo IV-443).
Anche questo paragrafo viene estromesso, assieme a tanti altri paragrafi, dal mandato su cui lavorerà, a partire dal 23 luglio, la Conferenza intergovernativa incaricata di emendare i vecchi trattati e proporli a ratifica prima delle elezioni europee del 2009.
Ma, soprattutto, gli Stati hanno agito come se non avessero avuto alle spalle una serie di fallimenti, riconducibili tutti all'incapacità dell'Unione di prendere decisioni comuni anche quando fra i Ventisette c'è disaccordo: fallimenti come la spaccatura sull'Iraq e l'impossibilità di una comune politica internazionale. Il ministro degli Esteri europeo, che doveva avere una sua autonomia e presiedere i Consigli dei ministri, diventa una figura senza autorità. Non si chiamerà d'altronde ministro degli Esteri ma Alto Rappresentante. Sarà una copia di quello che abbiamo già dal 1999 (Xavier Solana) e che ha dimostrato di non funzionare.
Gli Stati insomma si riprendono per intero i poteri che avevano promesso di delegare. In politica estera non accetteranno alcuna autorità sopra di sé, e ciascuno ottiene di gestirla "secondo i propri interessi nazionali". Non ci sarà una Carta dei diritti obbligatoria per tutti, ma solo un accenno alla sua esistenza e la possibilità, per Inghilterra e Polonia, di non considerare i suoi dettami vincolanti. Londra non considera validi i paragrafi sul diritto di sciopero e altri diritti sociali. Varsavia giudica irrilevanti diritti etici come la non discriminazione.
In realtà non si è tornati indietro di sette anni ma di più di mezzo secolo. Certo, l'europeizzazione delle politiche nazionali è un dato di fatto difficilmente smantellabile, anche se viene restaurato il falso potere sovrano degli Stati. Ma nei modi di pensare e di fare, i dirigenti nazionali tornano all'epoca che precedette la nascita stessa dell'unificazione europea. Il vertice appena concluso a Bruxelles ha svegliato mostri maligni, che sembravano dormienti, e l'Europa torna a essere un continente dove quel che conta è l'equilibrio di potenze invece della cooperazione e della comune volontà: la balance of power che tiene le singole nazioni del nostro continente in stato di perenne rivalità, intente a tenersi a bada reciprocamente e a brandire l'una contro l'altra le proprie sovranità assolute.
La balance of power è il veleno che per secoli ha corroso l'Europa fino a distruggerla, e contro cui fu inventata dopo la guerra l'Unione europea: questo veleno viene inoculato di nuovo nelle nostre vene, spensieratamente, come se la storia fosse fatta di nulla. Altro significato non ha lo scontro Berlino-Varsavia, che ha impregnato l'intero semestre di presidenza tedesca. Il governo polacco si è presentato a Bruxelles con l'esplicito proposito di ottenere un risarcimento per i disastri bellici causati dalla Germania ("Se nel 1939 la Germania non avesse invaso la Polonia, oggi avremmo 66 milioni di abitanti invece di 38 e il problema non si porrebbe", ha detto il premier Jaroslaw Kaczynski) sostenendo che la regola di decisione basata sulla doppia maggioranza degli Stati e della popolazione è a ben vedere un premio dato alle stragi di Hitler.
Il risentimento, l'uso della storia, l'invidia per paesi come la Germania, divenuta ricca anche se perdente nell'ultima guerra: queste le emozioni che hanno dominato i lavori a Bruxelles. Quando Angela Merkel ha minacciato di convocare una conferenza senza Varsavia, ripetendo il gesto compiuto nell'85 a Milano dal governo Craxi (così si riuscì a convocare una conferenza intergovernativa sulla riforma delle istituzioni, mettendo in minoranza la Thatcher), era troppo tardi. Sarkozy e Blair si sono opposti, e l'Italia ha dimenticato Craxi e Andreotti.
Dicono che la sostanza resta, anche se la forma svanisce. Dicono che gli Stati non vogliono dire quel che fanno, e ancor meno scriverlo. In parte è vero: la dissimulazione torna a essere quel che distingue l'Unione. Ma proprio questa continua dissimulazione stava negli ultimi quindici anni uccidendo l'Europa, impedendole di divenire potenza per meglio salvare i simulacri che sono ormai gli Stati sovrani. Non si parla più di costituzione, non c'è più il preambolo del vecchio progetto né si accenna al comune inno, alla comune bandiera, alla comune parola d'ordine ("uniti nella diversità"). Non si critica il diritto di veto, anche se un pochino lo si attenuerà. Il presidente della Commissione Barroso annuncia che "dalla bella lirica si è passati alla più efficiente prosa", ma in questa prosa non c'è efficienza e nel pragmatismo non c'è che menzogna: la menzogna secondo cui gli Stati hanno sovranità autentiche, per il solo fatto che riprendono il controllo dell'Europa e le vietano di nascere.
Chi in Italia aveva previsto e voluto simili involuzioni ha parzialmente ottenuto ragione, anche se lo sguardo che getta sull'Unione è non meno menzognero: è uno sguardo che sottovaluta la debolezza effettiva degli Stati e il riaffiorare continuo delle volontà europeiste. Il governo, presente a Bruxelles con Prodi e D'Alema, ha fatto comunque poco per smentire queste previsioni. Ha acconsentito all'arretramento, ha accettato perfino una richiesta assai equivoca del presidente Sarkozy: la rinuncia a considerare la "concorrenza libera e non distorta" uno dei fini dell'Unione, che dà alla Commissione di Bruxelles il diritto di punire il protezionismo degli Stati.
Ma soprattutto ha accettato di negoziare sulla base del trattato di Nizza anziché sulla Costituzione ratificata da 18 paesi, tra cui il nostro. Proprio quello che si era impegnato a non fare, nell'incontro di Prodi e D'Alema con il Capo dello Stato il 16 maggio scorso. In realtà non c'era che Napolitano a volersi battere per una linea coerente e ferma anche a prezzo di rompere. La sua voce nei prossimi mesi e anni, quando inevitabilmente riaffiorerà il bisogno d'Europa, sarà sempre più preziosa.
Giocare con le parole
Sul blog L'angolo di Annarita
Lo scarto è divenuto anche un diffusissimo gioco enigmistico e consiste nell'ottenere una parola da un'altra eliminando una lettera.
Lo scarto può essere di consonante o di vocale, iniziale o finale.
Generalmente si chiede di individuare le parole tramite indovinelli:
SCARTO DI CONSONANTE SCARTO DI VOCALE
In chiesa li togliamo Un atto di saluto...
d'estate li tagliamo ...tra i rami di gelso
(cappelli-capelli) (bacio-baco)
SCARTO INIZIALE SCARTO FINALE
E' tipico del nostro genere... Sul fiume sacro... ...stringerla ...imperversano banditi
(umano-mano) (Gange-gang)
Servendosi degli scarti è possibile anche creare dei nonsense:
C'è un merlo sul melo,
ma le rape non piacciono all'ape
che sulla tavola vola
mentre con la borsa la vecchia orsa
per il rumore è di pessimo umore
così la nave è nel porto mentre annaffio il mio orto.
Per rendere il gioco un po' più complicato, si può ricorrere allo scarto di sillaba:
Lo è la persona forte
che la solleva piena di spesa
(robusta-busta)
e al biscarto (eliminare una sillaba comune a due parole per formarne una terza):
Fanno la ruota
nel rifugio dei ladri
gettandotici senza pietà
(pavoni-covo- panico)
La zeppa segue il procedimento contrario, la nuova parola si ottiene inserendo nella vecchia un'altra lettera:
Lo si legge...
...scarcerato
(libro-libero)
...o un'altra sillaba:
Ti segue fedele...
...e lo paghi
(cane-canone)
E anche in questo caso, con le parole ottenute, si può ripetere il gioco del nonsense.
Dopo lo scarto e la zeppa, parliamo del cambio, nel quale una parola viene trasformata in un'altra cambiando una lettera o una vocale. Questo gioco si presta benissimo ad essere fatto in gruppo.
In classe lo facevamo così: dividevo i ragazzi in due o più squadre, secondo il numero, scrivevo una parola alla lavagna poi chiamavo la prima squadra e ciascuno doveva scrivere sotto la nuova parola nella quale aveva cambiato una sola lettera. Vinceva la squadra che ci riusciva senza errori nel minor tempo possibile.
Per esempio:
Carla, parla, palla, calla, calma, salma, salsa, balsa, balza, bazza, mazza, tazza, tozza.
Breve, brave, trave, trame, trama, trema, crema, croma, aroma, Arona.
Un gioco che sembra il cambio, ma non lo è, si chiama falso derivato e si presta ottimamente ad un gioco linguistico con i ragazzi.
Si usano parole che sembrano essere i nomi alterati l'una dell'altra, ma in realtà hanno diversi significati.
i falsi accrescitivi: burro/burrone, melo/melone, gallo/gallone
i falsi diminutivi: botto/bottino, cane/canino, tacco/tacchino
i falsi vezzeggiativi: gazza/gazzella, bolla/bolletta, salvia/salvietta
i falsi dispregiativi: foca/focaccia, polpo/polpaccio, addio/addiaccio
i falsi cambi di genere: mostra/mostro, raspa/raspo, botola/botolo
Una volta individuate le coppie di falsi derivati o di falsi cambi di genere, creavo le frasi nelle quali poi i ragazzi dovevano inserirli esattamente.
Per esempio:
Osservo la mamma truccarsi con cura il ......... prima di indossare la pelliccia di ........ (viso/visone)
Sul ramo più alto è volata una ....... mentre passa una ........ dei Carabinieri (gazza/gazzella)
La signora camminava chiacchierando con l'amica, non si è accorta della .......... e così il .......... che l'accompagnava c'è finito dentro (botola/botolo)
Il resto di 50 euro
Sul blog Personalità confusa
Gradevole conversazione con il commerciante che non vuole darti il resto
Buongiorno, amico negoziante.
Buongiorno caro cliente.
Mi dà uno di quelli, per cortesia.
Ecco a lei. Fanno due euro.
Grazie. Tenga, buonuomo.
Ehi ehi, fermo lì. Che è 'sta schifezza rosa?
Una bella banconota da 50.
Lo vedo. Non hai due euro?
No. Altrimenti glieli avrei dati.
Guarda bene, chè ce l'hai. O almeno due monete da uno.
Le giuro su Dio di no, mi creda. Controlli lei stesso.
Opporcocane, non vorrai mica il resto, spero.
Ehm, veramente sì, lo vorrei.
Ma come osi? Io sono un nobile commerciante, mica un cambiamonete.
Sì ma…
No no e poi no! Non ho nessuna voglia di mettermi qui a prendere i MIEI soldi per darli a te, lurido bandito. Che dice, quello è il resto, mi spetta.
Adesso tu mi chiedi scusa, te ne esci, torni a casa e ti ripresenti con 2 euro esatti.
Si calmi. Perchè dovrei chiedere scusa?
Io li conosco quelli come te: lo fate apposta. Vi procurate le banconote grosse e venite qui a comprar la prima schifezza da due euro solo per farmi dispetto.
Senta, la aiuto io, è facile: 50 meno 2 fa 48. Mi renda due banconote da 20, una da cinq…
Braaavo! Adesso pure l'aritmetica mi vuoi insegnare, mi vuoi. A me che coi soldi ci passo le giornate intere.
Abbia pazienza, allora: qual è il problema?
I problemi, caro il mio bandito, son parecchi. Primo, mi stai antipatico, tu e tutti quelli come te che girano impunemente senza spiccioli. Secondo, non c'ho voglia di contare. Terzo, se io do a te il resto, poi in cassa non mi restano altri tagli piccoli.
Embè?
Embè tuo nonno. Metti che tra poco entra qui un altro signore, un altro miserabile come te che compra una cosina da due euro con una banconota da 50, io non ho resto da dargli, ti rendi conto?
E che c'entro io, scusi?
C'entri, c'entri.
Ma ragioniamo…
Basta, finiamola che sennò ti metto le mani addosso. T'è andata bene che oggi son di buon umore. Tieni il tuo resto [ti lancia addosso una gragnuola di monetine da 1 centesimo, ferendoti al viso, ndr] e vattene.
Ahia, però. Che male.
Adesso fuori, fuori di qui.
Le chiedo perdono, amico negoziante, non succederà mai più.
Ci mancherebbe altro.
Arrivederci.
Vaffanculo.
Grazie.
Brianza Drive my Car
Sul blog Brianzolitudine 9 giugno 2007
Autobianchi a Desio: ci lavorava
la Brianza contadina lasciato
l'aratro alle spalle, un salto al fossato,
il rastrello abbandonato e la bava
alla bocca per avere l'ottava
d'ore di lavoro al giorno, col fiato
grosso per tornare indietro al passato
ritrovato a sera in stalla, da rava
a fava, da vacca ad Ypsilon dieci
(l'auto che piaceva alla gente che
piace) e adesso è il nuovo a fare le veci
in quell'area industriale, con altri
automezzi più scafati e più scaltri
di quella Bianchina un metro per tre.
Bianchina, A112 ed Y10. Tesi, Antitesi, Sintesi, chioserebbe Hegel: la logica idealistica brianzola sostanziata in quelle tre automobili, che hanno degnamente rappresentato la Brianza Way nella motorizzazione italiana di massa.
Parliamoci chiaro: l'Autobianchi a Desio, con quell'enorme area industriale da 200.000 e rotti metri quadri, è stata la fucina che dal 1958 fino al 1970 ha sfornato il vero sogno a quattro ruote dei giovani individualisti di quel periodo, la superba Bianchina tre volumi.
Mangiadischi Geloso sul sedile posteriore gracchiante Drive My Car dei Beatles a manetta, la morosa di fianco e la Bianchina a palla per le strade della Brianza: poteva mai la vita dei mitici sixties brianzoli essere più luminosa? Ah, Bianchina: nome quanto mai indovinato, tanto esso ricordava ai brianzoli che lavoravano in Autobianchi la vacca da regondà la sera, tornati dalla fabbrica alla propria stalla.
Se ci fosse oggi Darwin, egli ben sosterrebbe che l'Autobianchi rappresenta l'anello mancante che collega il brianzolus contadinus al brianzolus industrialis: con le otto ore di lavoro fisse al giorno, il contadino brianzolo scoprì che poteva svolgere simultaneamente il lavoro di operaio e il lavoro dei campi alla sera. Tornando in cascina, gli avanzavano ancora (soprattutto d'estate) quelle tre/quattro ore necessarie per accudire bestie e campi, che diversamente sarebbero finiti kaputt.
Adesso la transizione industriale della Brianza è completamente avvenuta e in quei campi ci stanno sempre e solo loro, i vecchietti ex-dipendenti, oggi in pensione a farci un po' d'orto. Mentre i giovani d'oggi sono tutti su un'altra strada, che non porta esattamente nel cuore della brianzolitudine.
Ma ritorniamo alla Corvette brianzola, la Bianchina. Essa nacque nel 1958 come auto pensata per il pubblico femminile dell'alta società (oggi la cosa può far sorridere, ma tant'era; il messaggio pubblicitario della foto sopra è chiaro, guardatela bene: donna davanti alla guida e uomo dietro). Per costruirla venne utilizzata la meccanica della Fiat 500, come estetica cambiarono il frontale, i fari e la forma posteriore, che fu realizzata in tre volumi.
All'inizio la Bianchina era una microvettura a 4/5 (!?!) posti con tetto apribile in tela, poi fu sviluppata in quattro versioni differenti: Berlina, Trasformabile, Panoramica (poi Giardiniera). Un sogno di modernità per almeno due generazioni, che non si accontentavano della pur degna 500.
Più tardi, dall'Autobianchi venne la A112. Presentata nel 1969 al Salone di Torino, fu realizzata in sostituzione dell'ormai vetusta Bianchina, presentando agli italiani una vettura compatta e scattante ma più spaziosa, distinguendosi dalle altre utilitarie. Una (mia) menzione particolare è per la A112 Abarth, questo per il motore assai brillante che piacque molto alla clientela giovanile. Era la macchina cosiddetta dello “sciupafemmine brianzolo fighetta”, il Cayenne odierno dei canturini CCC o meglio ancora - come fu definita - la Mini italiana, che grazie a spiccate doti di manovrabilità era capace di staccare le automobili più grosse e potenti dell'epoca, come le Alfa Romeo.
Nel frattempo, nel 1968 la Autobianchi venne completamente assorbita dalla FIAT e per qualche anno nello stabilimento di Desio vennero trasferite parti di lavorazione di modelli Fiat: la 126 e la Panda. L'ultimo modello autoctono prodotto a Desio fu la Y10. Anche quella un'auto azzeccata, simbolo della Brianza da bere, con quello stabilimento brianzolo che faceva fatica a stare dietro alla domanda.
L'Autobianchi Y10 debuttò ufficialmente al Salone di Ginevra nel 1985. La nuova utilitaria ebbe l'impegnativo compito di sostituire l'A112 che da quindici era presente con successo sulla scena del mercato automobilistico. Le vendite dei primi mesi stentarono tuttavia a decollare. Il vero problema iniziale fu il prezzo, considerato eccessivo per i primi potenziali clienti Y10. Ma tarato il prezzo ed il target, anche per la Y10 fu un più che discreto successo.
Successo che durò fino al 1992, quando per problemi organizzativi interni la Fiat cessò completamente la produzione Autobianchi a Desio. Là dove si producevano 800 autovetture al giorno e vi lavoravano 5.000 operai e impiegati (più una stima di indotto per altri 20.000 lavoratori) ci fu improvvisamente - e di colpo - il vuoto totale.
Un vuoto che creò anche qualche serio problema sociale, considerata l'imponenza delle maestranze coinvolte che furono con gran fatica assorbite dalle altre aziende del territorio. Ma il vuoto fisico dell'enorme spazio ex-Autobianchi rimase, ed esso è stato lo scorso anno colmato con l'inaugurazione del Polo Tecnologico della Brianza, realizzato nel 2006 con tempi da fare invidia alla grande Fiera di Milano.
Nell'area ex-Autobianchi non ci sono megacentri commerciali, nè le villette a schiera tanto richieste dai tanti che lasciano Milano, ma 70 tra imprese e impresine. E' il trionfo del post-fordismo. Dell'Autobianchi di una volta oggi non c'è più traccia, la storia è comunque a lieto fine grazie al Polo Tecnologico.
Ora nell'Area Ex-Autobianchi vive e pare prosperare questo Centro, sede di aziende orientate alla ricerca ed allo sviluppo come il solare fotovoltaico. Ma per i brianzoli più vecchietti come me, l'Area Autobianchi è ancora legata a quella dolcissima Bianchina, la Trabant italiana, che rappresentava il sogno e il senso di una gioventù libera e gioiosa, orientata al futuro e che purtroppo fatico a riconoscere negli occhi delle ultime generazioni.
Ah, dimenticavo una nota di colore che piacerà agli amici cinefili di abbracci&popcorn: la Bianchina di colore bianco è la mitica autovettura del ragionier Fantozzi, immortalata nei vari film della serie. Perchè anche il buon Fantozzi ha una sua libera anima brianzola, alla fin fine. L'avreste mai detto?
Le magie di San Giovanni
Sul blog Placida Signora
Lasciarono la Lanterna nel luglio del 1097; alcuni mercanti e nobili genovesi avevano armato 10 galee dirette in Terrasanta per accompagnare “fortissimi guerrieri” a combattere contro i Turchi e, già che s'era lì, a tentare l'impresa d'espansione coloniale.
Un anno dopo tornarono a casa senza più guerrieri, ma con in tasca la donazione della città d'Antiochia e, nella stiva, i resti mortali di San Giovanni Battista recuperati a Mira e deposti subito nella cattedrale di San Lorenzo.
Nel 1327 il cosiddetto Precursore fu eletto Patrono della città, e forse qualcosa di più, visto che i genovesi in lui ebbero sempre la fiducia che si può avere in un padre.
Lo invocarono ogni volta che un pericolo minacciava la Superba; invasioni, epidemie, incendi, ma soprattutto violente burrasche che minacciavano il porto: le sue ceneri ogni volta venivano portate sul luogo del periglio, e la calma tornava.
Miracoli testimoniati negli annali dello Stella, del Bonfandio e nelle Cronache del 1406, 1414, 1613, 1640, tanto che proprio in quegli anni si prescrisse una solenne processione che ogni 24 giugno, giorno della nascita del Santo, ne scortasse la sacra Arca contenente le reliquie attraverso la città fino al porto.
San Giovanni fu prediletto dai genovesi anche come nome di battesimo; sino al 1950 fu proprio Giambattista il nome più diffuso, coi diminutivi di Gio Batta e Baciccia.
Ma piacque soprattutto perché caldo simbolo di luce; dall'Oriente quelle galee portarono non solo un emblema religioso, ma un culto antico, dal fascinoso sapor profano, fatto di fuochi e falò derivati dagli antichissimi fulgori che salutavano il solstizio d'estate.
E quei falò brillarono da subito sul greto del Bisagno, sulle spiagge, sulle fasce dell'entroterra, accesi da contadini e pescatori che s'illudevano così di cacciare spiriti maligni e streghe che la notte tra il 23 e il 24 uscivano dai loro antri nascosti scatenandosi in sabba infernali.
I fuochi divennero poi mero motivo di festa e convivio; ovunque in città vi fosse un minimo spazio, piazza Sarzano, Santa Maria di Castello, Principe, San Teodoro, persino sui merli di Torre Embriaci e in tutte le alture alle spalle di Genova, s'innalzavano fiamme e si ballava attorno a loro la “moresca“.
Si cuocevano nelle braci le cipolle, quella notte terapeutiche per allontanar febbri e vermi; e migliaia di lumache, poste su grandi graticole con la bocca del guscio all'insù, coperta di olio, prezzemolo, sale ed aglio.
E dove non si potevano accendere falò, si appendevano lanternine di carta rossa, verde e gialla, con dentro lumini; e poi fuochi artificiali, mortaretti, girandole, razzetti: un tripudio di luci che illuminava la notte più magica dell'anno.
Quella in cui bisogna raccogliere le erbe per sfruttarne appieno le virtù salutari; immergersi nell'acqua, mare fium lago che sia, o rotolarsi su prati bagnati di rugiada per preservarsi dai reumatismi; esporre indumenti di lana e di seta all'aperto, affinché non vengano mai toccati dalle tarme ed infine scambiarsi promesse d'eterno amore saltando, in coppia, le braci rimaste nei falò.
©Mitì Vigliero
Tarkovsy, Wertmuller, Ivory
Giuliano, Solimano, Roby sul blog Abbracci e pop corn
Lo specchio di Andrei Tarkovsky Giuliano 14 giugno 2007
" Dalla stazione, la strada passava per Ignatieva, svoltava seguendo l'ansa della Gruna a un chilometro circa dalla cascina dove allora, prima della guerra, trascorrevamo tutte le estati; e insinuandosi in un fitto bosco di querce proseguiva oltre, verso Tomscinò. Di solito riconoscevamo i nostri solo quando li vedevamo apparire da dietro il grande cespuglio che si alzava in mezzo al prato: se dal cespuglio la persona si dirigeva verso casa, si trattava di papà; altrimenti non era papà. E un giorno papà non sarebbe più tornato.
- Scusate, è questa la strada per Tomscinò?
- Non dovevate svoltare al cespuglio.
- Ah. E voi, perché...
- Perché cosa?
- Perché ve ne state lì seduta.
- Io vivo qui.
- Dove, sullo steccato?
- Ma cosa volete sapere, la strada per Tomscinò o dove vivo io? " (...)
Una donna è seduta su uno steccato, in aperta campagna. Da lontano, un uomo che passa la nota e le si avvicina; la donna è molto bella. L'uomo, un medico, tenta un approccio educato e gentile, chiede informazioni; infine le si siede accanto, ma lo steccato non regge il peso e si rompe. I due finiscono a terra, la donna si rialza subito e l'uomo ride. Poi anche l'uomo si rialza, si spolvera, sorride, riprende la sua strada e fa un cenno di saluto. Un'improvvisa folata di vento piega dolcemente l'erba del prato.
Questa è la scena iniziale (ma, prima dei titoli di testa, a un ragazzo balbuziente viene insegnato “a non aver paura della sua voce”) di uno dei film più difficili e affascinanti che mi sia mai capitato di vedere. E' poco comprensibile perché è autobiografico e parla della madre di Tarkovskij, e dell'infanzia del regista, negli anni precedenti alla Guerra. Nella scena dello steccato, Tarkovskij ha la finezza di citare Cechov: ed è solo una delle piccole e grandi citazioni fatte in questo film. C'è il richiamo ai grandi pittori: Leonardo, Monet, ma anche Brueghel e Bosch, e Giorgione con la sua Tempesta.
Ma i protagonisti sono gli elementi atmosferici, il fuoco, l'acqua, il vento, la luce, gli elementi primordiali. I movimenti di macchina hanno una magia nascosta, il vento arriva nel momento esatto in cui ce ne è bisogno, un uccellino si posa sul berretto di un ragazzo e il ragazzo lo prende, un oggetto cade dal tavolo proprio quando la telecamera si ferma ad osservarlo, passato e presente si fondono, perfino un alone di vapore su un tavolo diventa importante. La comunione con la Natura, paganesimo e panteismo, religione panica sono tra i protagonisti dei film di Tarkovskij. Il film è composto di vari episodi, quadri apparentemente semplici che vanno a formare un disegno complesso, un arazzo, un tappeto persiano, leggibile solo a pochi e anche ad essi con grande difficoltà. I colori sono i colori dei sogni, colore pieno oppure altri colori; il bianco e nero non è mai quello classico, è piuttosto un grigio, un seppia, un verdastro, il colore dei sogni e dei ricordi. Tarkovskij filma i sogni, e i ricordi.
Come Bertolucci, anche Tarkovskij è figlio di un grande poeta: e “Lo specchio” comprende molte poesie del padre di Andrej, poesie bellissime lette, nella versione italiana, dalla voce toccante di Romolo Valli.
Amo gli occhi tuoi, amica mia,
e i loro giochi.
Splendidi di fiamme quando
li alzi all'improvviso e,
come fulmine celeste,
guardi veloce tutt'intorno.
Ma c'è un fascino più forte:
gli occhi tuoi rivolti verso il basso,
negli attimi che un bacio appassionato,
e fra le ciglia semichiuse del desiderio,
il fumo, il fosco fuoco...
( Arsenij Tarkovskij )
Film d'amore e d'anarchia di Lina Wertmuller Solimano 17 giugno 2007
Ancora Lina Wertmuller, dopo Travolti da un insolito destino, e non finirò qui, ce ne ho almeno un altro, forse due. Che sovrabbondanza di trovate! Di alcune potrebbe fare a meno, tipo il titolo lungo: Film d'amore e d'anarchia sarebbe un titolo perfetto, più bello non si può, e invece ci mette la giunta. Secondo me lo fa apposta, un po' per spregio un po' per sberleffo ai dottori in scienze filmiche che se la prendono con lei, fra supponenza ed invidia. Perché le invidiano la sua velocità vivace, il suo spendersi senza misura, il suo avere le mani piene non si sa se di gioielli o di bigiotteria, per me c'è di tutto, e i gioielli si riconoscono perché luccicano di meno, ma ci stanno, ci stanno.
In Italia c'è stata una diffusa cultura postribolare che ha riguardato giornalisti, scrittori, registi: Montanelli e Fellini, ad esempio. In uno fra i film di Fellini che ammiro di più, Roma, c'è una lunga scena in un bordello di fronte a cui sono diviso, c'è il Fellini più grande, che per me è il Fellini potente, e il Fellini piccino, mischiato di nostalgie e di ghiribizzi maliziosi. Ma in letteratura ci sono esempi alti: la Ghisola di Con gli occhi chiusi e la Angiolina Zarri di Senilità. Forse, e non ci si bada, il più grande è nel Pasticciaccio, con le pagine in cui il commissario Ingravallo interroga Ines Cionini, e l'antro della Zamira, che finisce con il brano meraviglioso della gallina guercia, e magari lo inserirò nei commenti. Ma Gadda, Svevo, Tozzi sono ben altra cosa rispetto ai rimpianti mezzo gaglioffi mezzo coglioni e sempre dolciastri di altri, anche ben noti, in cui l'esaltazione del meretricio nei bordelli è un come eravamo: non erano bene, tutto lì.
Lina Wertmuller conosce questo lato a volte miserello del milieu di cui fa parte, e un po' ci si adegua un po' no, ma l'aiuto di Mariangela Melato è formidabile: la sua Salomè, prostituta focosissima e furba, ma affetta da idealismo anarchico, riesce a tenersi stretto il gerarca Spatoletti (Eros Pagni), di cui andrebbero sentiti e risentiti i monologhi tronfi che gli fa dire la Wertmuller. Ne esce una Italia trasformata dal fascismo in un paese-lupanare, si badi, non solo per violenza del regime, ma per corrispondenza a certi caratteri costruiti giorno per giorno nei secoli di dominazione spagnola, papalina, austriaca, borbonica e chi più ne ha più ne metta: l'Italia non paese povero ma povero paese, come diceva quello sciovinista di De Gaulle, avendo ragione, in questo caso. Tunin (Giancarlo Giannini) è l'anarchico che progetta un attentato e che viene ospitato nel bordello; sminuito nel confronto con Salomè, si riabilita alla grande quando incontra l'Amore per la Tripolina (Lina Polito), prostituta molto giovane e concupita da tutti, Amore assolutamente ricambiato. La storia finirà male, la trama la conoscete, ma c'è una parte del film che ho trovato di commossa grandezza: la Tripolina vuole tenersi Tunin, non vuole perderlo con l'attentato, e se lo imbambola a furia di amplessi, perché così la mattina non sentirà la sveglia e farà tardi all'appuntamento con l'attentato - con la galera e con la morte – e Salomè, pur utopista anarchica, le tiene bordone. Tunin si sveglia in ritardo, ma si ribella alla possibile felicità che gli sta davanti e corre - in ritardo – dietro al suo nero destino. Qui la commedia all'italiana diventa Tragedia vera, non da povero paese. Per me Lina Wertmuller se n'è accorta benissimo, di quello che le è uscito dalle mani, meno ci hanno fatto caso i dottori in scienze filmiche, disposti a togliersi il cappello di fronte ad operazioni di altri, operazioni seriose, noiose e furbe: retoriche, in una parola. Politicamente corrette, anche: ovvìa, certe cose alte in un bordello non possono accadere! E invece la Wertmuller le fa accadere e ce le fa ammirare, quindi c'è speranza che cose alte possano accadere perfino in un paese chiamato Italia.
Camera con vista di James Ivory Roby 21 giugno 2007
Mentre Ivory girava a Firenze questo film, io ero impegnata nella faticosa stesura della mia chilometrica tesi di laurea, giusto a due passi dai luoghi principali delle riprese. Ricordo di aver visto Piazza SS. Annunziata "travestita" da piazza d'inizio Novecento, piena di figuranti in costume, con la macchina da presa che inquadra da sotto in su la protagonista, per evitare le vetrine moderne di via dei Servi: e poi, in S. Croce, il cast impegnato nell'ennesimo ciak della scena dell'accoltellamento fra i due giovinastri, che tanto turba con il rosso violento del sangue l'anglosassone miss Lucy Honeychurch, giunta in riva all'Arno insieme alla cugina-chaperon Charlotte e all'immancabile guida Baedeker. Strano tipo, quest'inglesina "perbene", in apparenza freddina e sotto sotto, invece, tutta fuoco: la Bonham-Carter e il bel Julian Sands -George, suo aitante ma problematico "seduttore"- s'impegnano molto ma non riescono ad entusiasmarmi più di tanto, penalizzati dal confronto con tre "mostri" come Judy Dench, Maggie Smith e Daniel Day-Lewis. L'emancipata scrittrice della Dench è irresistibile quando coinvolge l'impettita Smith-Charlotte in una passeggiata nei vicoletti del centro storico, tra gli sguardi equivoci e le grossolane avances dei bellimbusti locali: e la Smith è perfetta nella caratterizzazione del personaggio di parente povera e zitella, costantemente bisognosa di attirare l'attenzione sui suoi innumerevoli problemi di salute: mentre Daniel Day-Lewis -molto attraente in altre pellicole- qui riesce a trasformarsi in un Cecilio ridicolo, al limite della macchietta. Memorabile la scena del bacio (???) fra lui, tutto rigido e sussiegoso, e Lucy, la quale, avendo sperimentato in precedenza le infuocate labbra di George, rimane lì perplessa, dubbiosa e insoddisfatta. E' in quel momento, probabilmente, che decide: non sarà certo con questo dandy impomatato che trascorrerà il suo prossimo soggiorno in una "camera con vista"... perchè del panorama esterno, in certi casi, si può benissimo fare a meno: di quello interno (oh my God!) assolutamente no.
PS: oltre alle musiche originali di Robbins, da segnalare nella colonna sonora la presenza di veri gioiellini, tra i quali spicca l'aria "O mio babbino caro" tratta dal Gianni Schicchi.

 24 giugno 2007
24 giugno 2007
![]() 24 giugno 2007
24 giugno 2007