



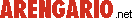
La settimana in rete
a cura di Primo Casalini - 17 giugno 2007
Gli scrittori che hanno fatto l'Europa
Eugenio Scalfari su la Repubblica
Il 6 maggio scrissi un articolo sul canone letterario europeo dando notizia di una iniziativa presa dal preside della facoltà di Lettere umanistiche della Sapienza di verificare quali fossero oggi gli autori e le opere che, a giudizio di docenti e studenti, avevano contribuito a formare la civiltà letteraria e morale del nostro continente.
Ritenevo che quella ricerca fosse importante e preannunciavo che a metà giugno i risultati sarebbero stati presentati in un convegno cui avevano già aderito molte Università europee. Il convegno, come "Repubblica" ha già riferito due giorni fa, si è svolto il 15 e il 16 scorsi con ampia partecipazione di docenti di tutta Europa. Debbo alla cortesia del Rettore e del preside della facoltà d´esser stato anch´io invitato a svolgervi una relazione.
Il tema del convegno, che ha chiuso ieri sera i suoi lavori, merita attenzione. In tempi che non sembrano favorevoli all´idea di Europa l´apporto della cultura può essere essenziale. Del resto così è stato fin dall´alto Medioevo e le Università vi svolsero un ruolo determinante a Parigi, a Bologna, a Heidelberg, a Oxford, a Salamanca, a Lubecca, a Praga e in tante altre città. Ai tempi nostri molte cose sono ovviamente cambiate ma la cultura resta un fattore primario nella formazione dello spirito europeo.
Le Università che hanno risposto all´iniziativa della Sapienza hanno indicato gli scrittori e le opere più presenti nel canone europeo, mettendo ai primissimi posti Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Tolstoj, Flaubert, Proust e poi molti altri. Omero occupa in questa enumerazione variabile nel tempo come tutti i canoni repertoriali, un posto a sé: gli si riconosce un ruolo di fondatore del romanzo agli albori della civiltà ellenica e dei miti che nutrirono poi la cultura e la poesia latina divenendo infine patrimonio di tutto l´Occidente. Quindi un´influenza essenziale anche nella formazione del canone europeo senza tuttavia farne direttamente parte. Come dire che l´Iliade e l´Odissea sono patrimonio dell´umanità e non soltanto dell´Europa. Così anche la Bibbia e le Sacre Scritture delle varie religioni e teosofie. Questo è il quadro entro il quale si è svolto il dibattito della Sapienza, un tema affascinante con implicazioni attuali che vanno oltre la letteratura coinvolgendo l´insieme delle arti ma anche la filosofia, l´etica e la politica se intesa, come sempre si dovrebbe intenderla, come visione del bene comune.
Nella pregevole relazione svolta ieri mattina Cesare Segre ci ha ricordato che il canone letterario europeo nasce nel XVI secolo; infatti è in quell´arco di anni che il romanzo moderno fa le sue primissime prove, affidate alla signora de La Fayette e alla sua "Princesse de Clèves". Milan Kundera nella sua "Arte del romanzo" va ancora più indietro e risale a Rabelais e ai suoi Gargantua e Pantagruel.
Se per canone intendiamo una sorta di repertorio di autori e di opere circolanti in Europa, conosciute dalla società dei dotti e quindi influenti sulla formazione del gusto, dei modi di sentire e insomma di una civiltà non bloccata nei confini della geopolitica, allora la datazione è certamente quella.
Ma se vogliamo inventariare le forme della comunicazione artistica che hanno raggiunto, ciascuna nella sua epoca, l´opinione pubblica europea e si sono stratificate e metabolizzate nelle fasi successive fino a formare la civiltà dell´Europa, credo che si debba risalire molto più indietro: ai "troubadours" di Provenza e di Aquitania che diffusero l´ideale dell´amore cortese nei castelli di Francia, di Spagna, e di Sicilia, di lì risalendo per tutta Italia fino a trovare nella Toscana del Guinizelli e di Cino la loro forma poetica più compiuta.
Diciamo pure che di lì ha inizio la letteratura romanza, con lo strumento d´una lingua appena in formazione e non ancora coincidente con le varie nazioni; una sorta di lingua franca, parlata a Londra come in Normandia, a Lione come a Bordeaux, a Parigi come a Bologna, a Milano, a Bruges, a Digione.
Il canone europeo propriamente detto non c´era ancora ma si stavano costruendo gli strumenti che l´avrebbero reso possibile. Stavano sorgendo dal basso le premesse per quella poetica laica – nel senso di non legata alle liturgie religiose – che in Italia si sarebbe manifestata nell´ispirazione creativa che da Guido Cavalcanti va, attraverso la "Vita Nova" fino al Petrarca e poi al Tasso, al Foscolo, a Giacomo Leopardi e (aggiungo io) a Montale.
So che anche questa è una nomenclatura che rischia di sacrificare alla classificazione il patrimonio vivente delle singole opere, ma il canone se inteso come classificazione, serve a formare una prima bussola per orientare scrittori e lettori, la formazione del gusto e delle mode, dell´apprendimento e delle libere scelte creative.
* * *
Se dalla preistoria del romanzo moderno vogliamo compiere un passo avanti, troviamo "Candide". Si dirà che si tratta più d´un apologo che d´un romanzo ed è certamente così. Ma un apologo è pur sempre racconto e il "Candide" volterriano ebbe ai suoi tempi una tale forza d´urto sull´opinione pubblica europea che difficilmente fu superata nei secoli successivi prima di "Guerra e pace" e soprattutto di "Anna Karenina". Qui non parlo più della società dei dotti, ma dell´opinione pubblica: un fenomeno relativamente recente, che ha inizio in Francia con gli enciclopedisti e con apologhi, appunto, del genere di "Candide" e in Inghilterra con la libellistica che ebbe in Swift il suo maggior campione.
Ma ora entriamo nel cuore vero e proprio del tema che ci occupa: la grande stagione del romanzo che vede fiorire nello stesso tempo le opere dei grandi russi e dei grandi francesi. Soprattutto Tolstoj, Balzac, Flaubert, Stendhal. A distanza di pochi anni Marcel Proust e la "Recherche".
Non ho né i titoli né lo spazio per approfondire quella importante stagione della letteratura europea. Dirò soltanto quale fu il suo impatto sull´opinione pubblica. Un impatto formidabile. Intanto perché, per quanto riguarda i romanzi francesi, non c´era praticamente bisogno di traduzione: la borghesia cittadina usava ampiamente il francese come seconda lingua e ciò assicurava la diffusione delle opere nella versione originale. Lo stesso francese fu usato per la traduzione "europea" dei romanzi russi che circolarono infatti soprattutto in quella lingua in tutte le nazioni del Continente.
Quanto all´effetto di quei romanzi sul pubblico dei lettori, pur nella differenza degli stili e delle vicende narrate, esso fu quello di trasmettere lo spaccato d´una società attraverso personaggi e vicende private, intrecciate strettamente alle vicende e ai personaggi pubblici. Ai costumi e ai pregiudizi dominanti, alla pressione che esercitavano sull´esistenza delle persone e sui loro rapporti sociali.
Il conformismo e la ribellione contro di esso, la cupidigia e il potere, la generosità e l´ipocrisia, il coraggio e la viltà costituirono il telaio sul quale l´arte del romanzo ottocentesco si esercitò creando una sorta di epopea borghese nella quale il pubblico si specchiò e l´opinione generale prese forma e consistenza.
Proust rappresentò la conclusione e al tempo stesso l´inizio d´una fase nuova. Nel "Tempo ritrovato" allestì il sontuoso funerale dell´aristocrazia, costruì il modello d´una società nevrotizzata scegliendo se stesso come documento e testimonianza; costruì la nuova forma-romanzo in cui la trama – cioè l´urto dell´io col mondo esterno – cede il posto al viaggio dell´io dentro se stesso nelle più riposte latebre dell´inconscio e nei recessi della memoria involontaria. Era difficile che avesse imitatori, ma non si capirebbero ne Virginia Woolf né lo stesso Joyce senza Proust, sebbene le vite di questi grandi siano state più o meno contemporanee.
Imitatori no, ma seguaci sì. In Italia ancora negli anni Cinquanta del secolo scorso i lettori che definirei proustiani militanti erano numerosi in tutto il paese e ben lo sanno gli editori e i giornalisti del "Mondo" e dell´ "Espresso" di quegli anni, che ebbero nei proustiani lo zoccolo duro del loro pubblico.
* * *
Si è parlato molto, nel convegno della Sapienza, di Shakespeare e di Goethe. Mi auguro che Roberto Antonelli, promotore di questa meritoria iniziativa, faccia pubblicare almeno in qualche sito della rete i testi registrati.
L´influenza esercitata dall´autore dell´Amleto, di Romeo e Giulietta, del Riccardo III, dell´Enrico V e della Tempesta sul pubblico europeo è stato enorme. Mi permetto di dire: soprattutto nel Novecento. Attraverso il teatro, certo, ma anche attraverso la lettura dei testi e la trascrizione cinematografica di alcuni di essi. Il cinematografo negli ultimi settant´anni si è collocato legittimamente accanto alle altre arti con pari dignità anche se con una differenza non da poco: ha sostituito l´autore individuale con un "cast" di autori del quale fanno parte il soggettista, lo scenografo, il regista, il fotografo, il produttore, gli attori. Una novità non dappoco, destinata a cambiare i parametri d´un canone che volesse repertoriare i prodotti del cinema.
Dicevo che non mi azzardo ad approfondire il tema Shakespeare neppure per accenni. Tanto meno il tema Goethe, altro gigante che troviamo nel canone letterario. Ma un´osservazione posso fare sull´autore del Faust: il suo rapporto con l´opinione pubblica è stato assai più limitato della sua potenza letteraria. Non parlo ovviamente di diffusione quantitativa nelle biblioteche delle famiglie europee. Io non credo che la pubblica opinione europea abbia sentito l´influsso goethiano. L´arte, la letteratura, il romanzo occidentale gli debbono molto. Le modalità della scrittura, la classicità dello stile, la passionalità del "romantik", hanno avuto in Goethe un modello costante. Ma l´opinione pubblica di oggi non ha introitato il suo lascito letterario e culturale. Molto di più quel pubblico ha sentito e sente Kafka. Pietro Citati, che ha studiato a fondo sia l´uno che l´altro, potrebbe spiegarci il perché.
Anzi: chi ha letto i suoi libri su quei due scrittori la risposta a questa domanda può già averla avuta.
* * *
I lettori mi perdoneranno se ho divagato e dilungato: un tema come quello del canone letterario affascina a tal punto che non vorresti lasciarlo e continuare a discuterne in un ideale convivio con i lettori.
Ho accennato all´ingresso del cinema accanto alle altre arti, ma voglio aggiungere al cinema anche la televisione che nella civiltà delle immagini in mezzo alla quale viviamo sempre più immersi da mezzo secolo in qua rappresenta il maggiore strumento di comunicazione.
Anche la televisione – nonostante la peculiarità del mezzo e la sua necessitata dipendenza dagli indici di ascolto – può avere ed anzi ha il suo canone qualitativo. Purtroppo però presenta una singolarità rispetto a tutti gli altri strumenti di comunicazione: se fosse possibile redigere un elenco repertoriale al negativo, la televisione ne guadagnerebbe sicuramente la palma a molte distanze di vantaggio su tutti gli altri mezzi, cinema compreso.
La devastazione delle coscienze, della cultura, dei comportamenti e dei modi di sentire e di pensare prodotta dalla televisione commerciale in tutti i paesi a cominciare dal nostro, è stata immensa e difficilmente reversibile. Ha desertificato la morale, l´autonomia del giudizio, la sobrietà del costume, la privatezza dei sentimenti, il garbo, l´eleganza. Ha soppresso il silenzio. Ha confiscato il tempo libero. Ha imbarbarito il linguaggio. Le nuove invasioni barbariche hanno sede e forse addirittura origine nella televisione.
Ciascuno di noi denuncia questo stato di cose e nel contempo ne è servo. C´è dunque un barbaro in ciascuno di noi? Ecco una questione politica – sì, politica – che andrà prima o poi posta senza reticenze perché riguarda, al fondo, la nostra libertà.
Se il partito nasce vecchio
Giovanni Sartori sul Corriere della Sera
Nascerà davvero il Partito Democratico? Intendi: nascerà vitale o nascerà morto? Sarà un successo o sarà un fiasco? Margherita e Ds riusciranno davvero a fondersi, oppure la loro sarà soltanto una somma di due partiti che restano litigiosi ed eterogenei? E quale sarà "il valore aggiunto" del nuovo pargolo?
Di regola la somma (unificazione) di due o più partiti non produce valore aggiunto: la somma dei voti ricevuti dal partito unificato è inferiore alla somma dei voti ricevuti dai partiti separati. Nel nostro caso, perché mai un marxista dovrebbe gradire di trovarsi diluito in sempre meno marxismo; oppure perché mai un cattolico dovrebbe gradire di essere soverchiato da laici? Sia come sia, dobbiamo capire a quali condizioni un nuovo movimento o partito riesce a sfondare.
La prima condizione è che la nascita del Pd comporti una drastica semplificazione del sistema partitico, e così l'eliminazione del pulviscolo dei partitucci, dei "nanetti". E da quando i partiti esistono il loro numero viene ridotto dai sistemi elettorali, non dalla nascita di un nuovo partito che se li mangia. Prodi si è messo in testa, invece, di risolvere il problema con un partito "mangia-partiti ", con un partito-pitone. Ma, se così, a me sembra un controsenso che il progetto aggreghi soltanto due su circa dodici partiti. E' vero che la Margherita e i Ds mettono assieme circa la metà dei voti dello schieramento; ma i restanti nanetti mantengono lo stesso il loro potere di interdizione e di ricatto. Il che lascia il problema come è. Tanto più che nell'accorparsi i Ds si sono scissi perdendo il loro Correntone.
La seconda condizione è che il nuovo partito sia percepito come davvero nuovo, come portatore di aria fresca e di energie giovani. Invece il Pd sta nascendo senza slancio, già logorato dai tempi troppo lenti della sua gestazione e soprattutto dalle complicazioni nelle quali riesce sempre a impastoiarsi. Se fosse un architetto, Prodi costruirebbe tortuosissime pagode; e certo ha il genio della complessità superflua. Per le elezioni del 2006 escogitò una pletorica officina di teste d'uovo che gli regalò un programma di quasi trecento pagine, che gli fece quasi perdere le elezioni e che quotidianamente lo impaccia nel governare. E per il nuovo partito la tabella di marcia prevede un Comitato dei 45 per le regole dell'assemblea costituente; poi, il 14 ottobre, l'elezione dei delegati alla suddetta assemblea costituente, alla quale compete la redazione dello statuto del Partito Democratico; per poi finalmente arrivare, quando sarà, alla prova delle elezioni politiche. Nell'interim i 45 già dissentono su come e quando eleggere il loro leader e il loro segretario. Il tutto appesantito da un ulteriore, e sospetto, ricorso alla primarie. Dico "sospetto" perché per Prodi è ovvio che le primarie devono confermare e scegliere lui. Tantovero che, al momento, non le vuole perché i sondaggi danno per vincente Veltroni. Con tanti saluti al partito che "nasce dal basso". A Prodi piace far sembrare che sia il suo popolo a creare il suo Pd. Ma in verità non è così. E a questo modo molte, troppe energie vengono sprecate nel costruire una finzione populista.
Allora, il Pd nascerà vitale o morto? La previsione è difficile. Ma il fatto è che le elezioni amministrative hanno confermato la regola che le unioni perdono voti. Dove Ds e Margherita si sono uniti, hanno perso mediamente 10 punti percentuali (vedi Genova, La Spezia, Ancona). Questo è solo un campanello di allarme. Certo è, però, che la strada del Pd è piu che mai in salita.
Palestina, morte di uno Stato
Barbara Spinelli su La Stampa
Cercare le ragioni di una follia omicida è sempre impresa equivoca, anche se aiuta a capire quel che succede. Nell'immediato rischia di scompigliare l'azione, addirittura di paralizzarla: subito dopo l'attentato dell'11 settembre, ad esempio, il governo Usa decise di reagire immediatamente invece di ricostruire il perché dell'omicidio di massa, e in questo fu sostenuto da un gran numero di Stati, non solo alleati. Ma poi viene sempre il momento in cui conviene mettersi al lavoro e provare a comprendere la genesi della violenza: per evitare errori futuri, per apprendere qualcosa dalla storia che si fa, per capire che di tale storia non siamo oggetti ma soggetti, capaci di scelte libere, difficili e non caotiche.
Se c'è del metodo in ogni follia dobbiamo studiare l'uno e l'altra: follia e metodo, violenza e sua ragion d'essere. Questo vale anche per la guerra civile dell'ultima settimana a Gaza. Rinunciare a studiarne la genesi è qualcosa che va bene in una logica di guerra, dunque in una logica di comodità o di caos: lo scrittore David Grossman spiega molto bene come guerreggiare sia un atto quasi naturale per troppi Paesi, culture, religioni. "Ho la sensazione che nessuno cominci veramente una guerra: le guerre si continuano. La pace, quella è una cosa che si deve cominciare", dice in un'intervista a Repubblica, "alle volte bisogna agire contro i propri istinti per cominciare a dare fiducia agli altri". Non solo: il rifiuto di esplorare le ragioni conduce a conclusioni fuorvianti. La conclusione cui si è giunti, dopo l'assalto di Hamas alle strutture di comando di Fatah a Gaza, è stata: ogni ipotesi di due Stati indipendenti (israeliano e palestinese) è finita per sempre col nascere di poteri palestinesi antagonisti. Questa volta davvero Israele non avrebbe più interlocutori. Questa volta davvero sarebbe inconcepibile una Palestina araba: governata da Hamas, essa degenererebbe in base terrorista. È la tesi esposta venerdì sul Corriere della Sera da Magdi Allam. È quello che effettivamente si può credere, se lo sguardo non va oltre l'ultimo anello della catena di eventi. Ma se si guarda alle ragioni della follia, si arriverà a una opposta e ben più inquietante conclusione. Se c'è follia omicida è perché la creazione d'uno Stato palestinese è già da molto tempo divenuta impossibile, non viceversa. Più tale creazione veniva auspicata, negli ultimi decenni, più si agiva per impedirla. Tutti gli attori l'hanno ostacolata: i governi israeliani con la politica di insediamenti che ha fatto seguito a una guerra - quella del '67 - che per molti aveva creato la vera Israele biblica; i Palestinesi con l'ambiguità sul destino di Israele il giorno che fosse nato il loro Stato; le potenze tutrici infine - Usa, arabi - che non hanno pesato sui loro protetti risolvendone le ambiguità. Nell'88 l'Olp ha annunciato di voler creare uno Stato non nell'intera Palestina ma nelle terre occupate, e fu un primo progresso anche se Arafat dovette riconoscere più esplicitamente Israele, un mese dopo. La vecchia posizione, favorevole a una Palestina unificata comprendente i tre monoteismi, era, pur con nebulosità, finalmente abbandonata: i dirigenti palestinesi avevano capito che il sionismo non era una religione ma un movimento nazionale. Su quella base nacque il processo di pace, tra i primi Anni 90 e il 2000: un decennio che molti oggi giudicano aureo, ma che in realtà sancì l'impossibilità pratica di uno Stato palestinese, screditando in tal modo Fatah, interrompendo la sua maturazione e aprendo spazi enormi a Hamas. La tragedia palestinese si consuma in quel decennio, non in questi giorni. Si consuma a causa degli equivoci palestinesi, e s'infrange completamente su una pratica di annessione territoriale cui è stato dato il nome, beffardo, di Processo di Pace. L'annessione continuava infatti la guerra del '67: nell'aureo decennio gli insediamenti raddoppiarono, passando da 200 mila coloni a circa 400 mila. E il controllo israeliano si fece sempre più capillare: sulle fonti d'acqua, sul movimento delle persone, sul reticolato di strade che connettono i centri israeliani e son riservate solo a loro. A ciò si aggiunga il muro di separazione, il moltiplicarsi di punti d'accesso che rendono umiliante l'ingresso dei palestinesi in Israele. Il ritiro da Gaza nel 2005 non ha impedito che gli attributi sovrani (confini, vie d'accesso) restassero israeliani. Chiunque parli, scriva e decida su Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est farebbe bene a dotarsi di una carta geografica. Vedrà una sorta di denso pulviscolo stendersi sui territori: una miriade di puntini, ognuno di quali è un insediamento israeliano più o meno fortificato. Qualsiasi Stato funzionante - basato cioè sulla continuità geografica, sul controllo del territorio, sul monopolio della forza - gli apparirà una beffa assurda. C'è da divenir folli a guardare quella carta. Certo, Hamas è responsabile degli eccidi di questi giorni: ci saranno ragioni nella sua follia, ma follia omicida resta pur sempre. Rashid Khalidi, storico della Palestina e professore a New York, evoca altri fallimenti delle classi dirigenti palestinesi: l'incapacità di predisporre strutture statali, la non consapevolezza dei limiti della violenza, l'inettitudine nell'amministrare i territori e di capire la forza locale di Hamas. Inoltre manca nei Palestinesi ogni sforzo storico revisionistico: sforzo presente in Israele, dove tanti miti sono stati messi in questione. Ma sentieri analoghi sono percorribili quando c'è uno Stato, quando ci sono archivi centrali, quando si è in presenza di una forte narrazione ufficiale da contestare: condizioni che non esistono in regime d'occupazione. L'impossibilità di uno Stato palestinese è il non-detto degli ultimi decenni, non degli ultimi giorni: è la politica israeliana di annessione dei territori. Il fondamentalismo ha accentuato tale impraticabilità - l'Islam politico ha senso del potere, non senso dello Stato e dei confini - e proprio per questo Israele l'appoggiò, per indebolire l'Olp di Arafat e rallentarne l'evoluzione. A queste manchevolezze degli attori locali si affiancano quelle delle potenze retrostanti, in particolare dell'America. Allo stesso modo in cui Washington finanziò e addestrò Al Qaeda contro l'Urss, in Afghanistan, e oggi asseconda di nuovo il fondamentalismo sunnita per far fronte agli sciiti in Iraq e Iran, l'uso della religione come sostituto della politica è quel che ha dilatato il disastro palestinese e numerosi altri disastri. La radice di questo comportamento è antica, risale ai tempi del mandato britannico in Palestina dopo la prima guerra mondiale: per dividere i palestinesi e controbilanciare il loro movimento nazionale, Londra diede alle istituzioni islamiche il potere ma non la forza del comando, il pieno controllo sul denaro pubblico ma non l'accesso a un potere statuale (Rashid Khalidi, The Iron Cage, Boston 2006). Celebrare oggi la fine dei due Stati in Palestina non annuncia dunque novità sostanziali. Serve a nascondere responsabilità ben più diffuse, a non vedere la lunga storia dell'odierna catastrofe. È inutile, anche, presentare l'uccisione dello Stato palestinese come vittoria d'un campo, come rivincita di chi mai credette nel negoziato: la rivincita non insegna nulla, e far chiarezza su Hamas è inane se non si fa chiarezza su tutto. Anche parlare di tragedia non ha senso, perché la tragedia classica ha ingredienti che qui mancano in quasi tutti: la scoperta di sé, il riconoscimento del proprio limite, la catarsi. Certo il fallimento palestinese è profondo. Ma considerarlo fatale e non pensare a un ricominciamento significa cedere all'istinto bellicoso e respingere quel che Grossman ci dice: "Esiste sempre una scelta nella vita". Se non ci sarà Stato palestinese le cose non miglioreranno, ma si complicheranno grandemente. Le classi dirigenti palestinesi torneranno all'originario progetto, che prevedeva uno Stato binazionale. Bush stesso ha favorito questo sviluppo: proprio lui, che per la prima volta nella storia americana aveva auspicato la creazione di due Stati nel 2002, scrisse poi una lettera a Sharon, il 14 aprile 2004, che rendeva tale creazione del tutto impraticabile. In essa dava a Israele assicurazioni unilaterali, senza comunicarle ai Palestinesi: assicurazioni sul ritorno dei rifugiati; e assicurazione che le colonie israeliane nei territori sarebbero state considerate "nuove realtà createsi sul terreno", di cui tener conto in futuri accordi. Il diritto internazionale ne patì, perché esso giudica "inammissibile l'acquisizione di territori con la guerra" (preambolo e primi due articoli della carta Onu). Lo Stato palestinese finisce allora, e nel decennio precedente. Quella lettera fu un atto di follia senza spargimento di sangue, ma non senza relazione con le follie di oggi.
Minimizzare è un errore
Sergio Romano sul Corriere della Sera
Massimo D'Alema ha ragione quando deplora queste intercettazioni telefoniche, appese come panni sporchi alle finestre del Paese di fronte allo sguardo "trascurato" della magistratura. Non è bello che una conversazione privata, soprattutto se non contiene indizi di reato, venga ascoltata, trascritta e gettata in pasto alla pubblica opinione. È grave che queste intrusioni surrettizie nella vita privata degli italiani stiano diventando lo strumento preferito della magistratura inquirente. Ed è ancora più grave che servano ad accrescere l'instabilità politica di un'Italia già così faziosa e litigiosa.
Ma temo che il vicepresidente del Consiglio, in questo caso, non abbia colto il punto. Certe intercettazioni assomigliano a una delazione anonima e dovrebbero suscitare un moto di sdegno. Ma se apro una lettera anonima e scopro che contiene informazioni importanti per la sicurezza e il buon governo del Paese, debbo forse stracciarla per ragioni di principio? Posso deplorare l'uso eccessivo delle intercettazioni e il modo in cui vengono divulgate. Posso auspicare una legge che protegga la vita privata degli italiani da questi pubblici linciaggi. Ma non posso ignorare che la lettura di certe conversazioni e di alcuni verbali d'interrogatorio (come quello di Stefano Ricucci sui legami esistenti fra le scalate dell'estate del 2005) ha spalancato le finestre del palazzo e ha rivelato l'esistenza di rapporti su cui è necessario fare chiarezza.
Abbiamo scoperto anzitutto che esiste al vertice del Paese, fra gli uomini della politica e quelli degli affari, una familiarità non meno "indecente" dello spettacolo a cui D'Alema ha fatto riferimento nella sua intervista al TG5. Quando trattano con i loro amici, alcuni leader di partito, membri del governo e parlamentari parlano il linguaggio del bar, della caserma e dello stadio. Non è semplicemente una questione di stile e di buona educazione. Il linguaggio, in questo caso, dimostra che non hanno il sentimento della loro dignità e della distanza che dovrebbe sempre esservi, anche in un sistema democratico, fra coloro che rappresentano interessi pubblici e coloro che rappresentano interessi privati.
Abbiamo scoperto, in secondo luogo, che alcune conversazioni vanno molto al di là della semplice informazione. Posso capire che un uomo politico non voglia apprendere dai giornali, all'ultimo momento, la notizia di una fusione o di una acquisizione che modifica il panorama della finanza nazionale. Ma vi sono circostanze in cui sembra diventare un interessato collaboratore. Accade quando il segretario dei Ds Piero Fassino chiede al presidente di Unipol Giovanni Consorte come comportarsi con il presidente della Banca Nazionale del Lavoro Luigi Abete quando questi gli farà visita, di lì a poco.
Accade quando il senatore Nicola Latorre accetta di trasmettere a Fassino i ringraziamenti dell'immobiliarista Stefano Ricucci per un non specificato favore. E accade infine quando D'Alema sembra essere il tramite di un contatto fra Consorte e il parlamentare europeo dell'Udc Vito Bonsignore per una questione di azioni della Bnl detenute da un'azienda della famiglia di quest'ultimo. È probabile che in nessuno di questi casi vi sia l'ombra di un illecito. Ma l'opinione pubblica ha il diritto di chiedersi se e quali interessi si nascondessero dietro una tale pasticciata confusione di ruoli. Non è tutto.
Dalla lettura di queste intercettazioni gli italiani hanno appreso che nei tre grandi arrembaggi del 2005 (alla Bnl, alla Banca Antonveneta e alla Rcs-Corriere della Sera) gli stessi finanzieri facevano i loro affari ora con la sinistra, ora con la destra. E hanno il diritto di chiedersi se i grandi partiti siano sempre pronti a litigare in pubblico, ma sempre altrettanto disposti a perdonare le loro rispettive colpe in privato.
Se cessiamo di essere uno Stato
Ilvo Diamanti su la Repubblica
E´ riemerso il "male del Nord". Che, peraltro, non è mai passato, davvero. Solo che, dopo le minacce secessioniste e gli assalti Serenissimi degli anni Novanta, la rabbia pareva sopita. Temperata dal disincanto. Incanalata in un progetto molto più realista: negoziare con Roma.
Soprattutto dopo le elezioni del 2001, vinte dalla Cdl guidata da Berlusconi. Quando a Roma si era insediato un governo "amico". Perché il Nord insofferente vota a destra. Per Forza Italia e anzitutto per la Lega. Che, non a caso, alle elezioni amministrative recenti, ha conseguito un risultato importante, imponendo i suoi candidati al governo di molte importanti realtà locali, superando il 60%, talora il 70% dei voti. Come a Vicenza e Verona. Segno che il Nord è tornato all´opposizione. Come si era verificato alle elezioni politiche del 2006, ma anche in occasione del referendum costituzionale di un anno fa. Quando in Lombardia e in Veneto, uniche regioni in Italia, era prevalso il Sì (alla "devolution").
La febbre, però, è salita rapidamente. Soprattutto nel Nordest, la zona più reattiva – e produttiva – del Paese. Caratterizzata da una base estesa di piccoli imprenditori e lavoratori autonomi. I ceti sociali più insofferenti, verso lo Stato e verso la sinistra. Percepiti come una entità unica e ostile. L´avversario. Il nemico. Puntualmente ricambiati. Perché, nonostante le parole, nei fatti, il centrosinistra ha sempre espresso un certo fastidio nei confronti dei "ceti medi privati". Perché, appunto, né lavoratori dipendenti né grandi imprenditori. Ceti a metà. Anomali. E perdipiù evasori. Difficile farsi capire da chi non capisci. Per cui, tornato al governo il centrosinistra, il "male del Nordest" si è risvegliato, più acuto di prima. Come dimostra il secondo rapporto sul "senso civico", presentato nei gironi scorsi a Venezia da Demos e dalla Fondazione Nord Est. A cui Alessandra Carini, ieri, ha dedicato una lettura puntuale. Mettendone in luce alcuni atteggiamenti significativi, che pervadono questa società.
Anzitutto, l´insofferenza fiscale, visto che circa quattro persone su dieci giustificano l´evasione delle imposte e altrettante la pratica di pagare "in nero". Poi, la sfiducia nei confronti dei partiti e delle istituzioni nazionali: il Parlamento e lo Stato. Cui corrisponde il crescente consenso verso i governi locali: il Comune e la Regione. Su questa via, peraltro, si sono incamminati alcuni fra i più significativi soggetti della rappresentanza di quest´area. Le associazioni artigiane e del lavoro autonomo, le federazioni degli industriali venete: sostengono apertamente la protesta antitasse. Fino a minacciare lo sciopero fiscale. Gli amministratori locali: sindaci, presidenti di Regione. A partire dal governatore Galan, che ha invitato il Consiglio regionale a (auto) proclamare il Veneto "regione a statuto speciale". Come quelle confinanti.
D´altronde, in nome dei benefici (soprattutto) fiscali un crescente numero di comuni ha promosso referendum per sconfinare. Entrare in Friuli Venezia Giulia e, soprattutto, nelle province autonome di Trento e Bolzano. Il 46% della popolazione, d´altronde, è d´accordo. Per evitare l´estinzione naturale del Veneto, oltre che per rispondere all´insofferenza dei cittadini, gli amministratori reagiscono apertamente. Contro lo Stato centrale. Così si delinea la "nuova" questione settentrionale.
Che salda l´insofferenza fiscale e la domanda di autonomia intorno ai sindaci e ai governatori. Non solo di destra, ma anche di sinistra. Non solo del Veneto. Non solo del Nordest. Insieme a Galan, infatti, contro le politiche "romane" si schierano anche Cacciari e, inoltre, Illy e Dellai. E ancora: Chiamparino, Penati, la Bresso. Non si tratta più, come negli anni Novanta, di una protesta sociale sorda, esaltata da un unico attore antagonista, la Lega, ma di una "ribellione istituzionalizzata".
Sostenuta dalle associazioni di categoria e dai governi locali. Da Nordovest a Nordest, attraversando la Lombardia. Il che rende tardivo e insidioso il viaggio lungo il Po, intrapreso da alcuni leader del centrosinistra (in primis, Franceschini), a cui ieri ha partecipato anche Prodi. Perché il livello del fiume, a lungo in secca, sta salendo pericolosamente, alimentato dalle acque limacciose portate degli affluenti di sinistra (in senso idrogeografico, evidentemente).
Tuttavia, il male del Nord, oggi, presenta un´altra sostanziale differenza rispetto al passato. Negli anni Ottanta e Novanta era esploso in contrasto con lo Stato e in controcanto con il Mezzogiorno. Al malessere dettato da sottosviluppo del Sud si sostituiva la protesta delle aree di piccola impresa del Nord. Contro lo Stato assistenziale. E contro il Mezzogiorno assistito.
Mentre nel Sud il clima sociale si era sopito. Dapprima, per i crescenti trasferimenti dello Stato, che avevano garantito ai partiti di governo un ampio consenso sociale. Poi, negli anni Novanta, perché effettivamente nel Mezzogiorno si erano diffusi significativi segni di risveglio. Economico, sociale, politico. A cui aveva dato visibilità la stagione dei sindaci: Bassolino a Napoli, Orlando a Palermo, Bianco a Catania. Indicavano una svolta, la possibilità di cambiare. Quasi un rovesciamento dello "stivale" e della "questione nazionale". La rabbia del Nord faceva il paio con l´ottimismo sociale del Mezzogiorno. Da qualche anno, però, quella stagione sembra sfiorita. Tra Nord e Sud, i differenziali di reddito, benessere, occupazione hanno ripreso ad allargarsi. Come gli indici di "capitale sociale" (lo dimostra il recente saggio di Roberto Cartocci: "Mappe dei tesori", Il Mulino). Le condizioni di sicurezza e di qualità della vita, inoltre, si stanno degradando. La stagione della speranza è stata devastata dalle emergenze: criminalità e rifiuti. Così, anche nel Sud, l´atteggiamento dei cittadini è cambiato. E´ tornata l´antica sfiducia verso Stato e istituzioni.
Talora alimentata ad arte, esplode la rabbia. Com´è avvenuto, nei giorni scorsi, ad Ariano Irpino, in occasione della visita di Guido Bertolaso. "Il volto presentabile dello Stato. L´uomo delle emergenze, l´angelo custode di tutti gli italiani", lo ha definito, sulla Stampa, Massimo Gramellini.
Intendeva spiegare ai cittadini la necessità di riaprire la discarica della zona, per alleggerire l´emergenza dell´area napoletana, sepolta dai rifiuti. La sua auto è stata sommersa e scossa dalla folla. Quasi un tentativo di linciaggio.
E´ questa la novità. Fino ad oggi, nella storia della Repubblica, la "questione nazionale" ha coinciso con una sola "questione territoriale". Il Sud, dapprima e a lungo. Poi, dopo gli anni Ottanta, il Nord (padano). Oggi non è più così. Il "male del Nord" corrisponde alla "rabbia del Sud". La sindrome della sfiducia, diagnosticata nel Nordest, ha contagiato il resto del Paese. Il Mezzogiorno. E lambisce le stesse regioni del centro (allargate all´Emilia Romagna). L´Italia rossa, tradizionalmente integrata, pervasa di civismo, densa di capitale sociale, come hanno mostrato le ricerche di Robert Putnam. Fa osservare, anch´essa, segni di nervosismo e di insofferenza nei confronti delle istituzioni e dei governi locali, come hanno mostrato, da ultimo, le elezioni amministrative recenti. Come segnalano alcune indagini sugli atteggiamenti sociali (l´Osservatorio sulle Marche del laPolis dell´Università di Urbino, per esempio). Però, se le principali zone, il Sud e il Nord, sollevano altrettante "questioni". Sintomatiche di altrettante malattie sociali e civili. Mentre la cerniera del Centro mostra segni di usura.
Allora il rischio è alto. Assai più che nei primi anni Novanta, quando Gian Enrico Rusconi, in un noto saggio dedicato alla sfida secessionista, sollevò la questione: cosa potrebbe succedere "se cessiamo di essere una nazione"? Perché oggi siamo all´emergenza assoluta. Che riguarda tutti. La maggioranza di governo, ma anche l´opposizione che si oppone. E procede a spallate. Perché vuole tornare al governo al più presto. Ma per governare chi e cosa, "se cessiamo di essere uno Stato"?
Marameo al galateo
Edmondo Berselli su L'espresso
Qui non è il caso di fare l'agiografia del bel tempo andato, quando le nevi erano bianche, le spiagge semideserte, c'erano le quattro stagioni, vestivamo alla marinara e gli uomini politici andavano in spiaggia con la maglia a maniche lunghe e i pantaloni arrotolati sulle caviglie. Tempi in cui Enrico Cuccia rifiutava le interviste, Gianni Agnelli le concedeva con il suo stile sublime e granducale emettendo sentenze di alta sostanza ironica, si trattasse di Guido Carli o di Zibì Boniek, della Banca d'Italia o del tocco di palla di Platini; mentre a Roma i segretari di partito parlavano di rado e dopo avere soppesato tutto, anche le virgole, provocando magari sconquassi ma dopo avere calcolato ogni ripercussione: quando insomma i ruoli venivano puntualmente rispettati e avevano confini stilistici inderogabili, e nel caso di affari economici e finanziari di rilievo i segretari di partito non telefonavano dicendo "abbiamo una banca" ma si informavano con discrezione, eventualmente convocando gli interlocutori e i brasseur in segreto, nel sancta sanctorum, e facendo fare lunga anticamera, tanto per chiarire chi stava dalla parte che conta della scrivania.
Tuttavia evitare la 'laudatio temporis acti' non esime dal guardare con una perplessità di stampo scettico lo stile della classe dirigente attuale, e porsi domande conseguenti. Esiste ancora un galateo della suddetta classe dirigente? Più in sintesi, se lo stile è l'uomo (e la donna), e il galateo è l'etichetta di un ceto, esisterà davvero un complesso di atteggiamenti che certifica l'esistenza di una classe dirigente? Oppure il generone, la consorteria, il ceto medio qualificato e squalificato, riflessivo e irriflessivo, con i suoi comportamenti esteticamente problematici, è l'unica classe residua nella struttura sociale del paese?
Lo diceva e lo ripeteva qualche anno fa, in modo preveggente, Giuseppe De Rita, molto prima che la coscienza collettiva e televisiva mettesse a fuoco le autoreggenti di Michela Vittoria Brambilla o i tacchi assertivi di Daniela Santanché, leader in pectore di esperienze politiche imprecisate ma in cui la fisicità è un atout superiore alla cultura: in Italia non c'è una borghesia, c'è una "enorme bolla di ceto medio". Ossia all'incirca una poltiglia sociale, paludosa, capace soltanto di degradare ogni giorno un po' di più. Sicché anche gli stili si omologano. La riservatezza è un ricordo del passato. Il rispetto dei ruoli, una fisima culturale da babbioni. Non ci sono molti principi sacri nel nuovo galateo, ma il primo comandamento è presto detto: spifferare tutto. Senza remore. Passare i documenti ai giornali. Telefonare a Dagospia. Intervenire comunque perché solo il silenzio, naturalmente, uccide.
Giovedì 31 maggio, sul 'Foglio' di Giuliano Ferrara, Barbara Palombelli, ha realizzato una strepitosa impresa, sola contro tutti. Offrendo la sua opinione sulle miserie del centrosinistra, sulla questione della leadership, sul sistema politico ed elettorale, sull'efficacia del governo: "Il ministero Prodi, alla vigilia delle ultime elezioni, non è riuscito a spegnere i falò della spazzatura in Campania, e neppure quelli in Rai". Per poi spiegare la sua ricetta, la "strada seria", ossia "larghissime intese, governo forte, soluzioni veloci per una modernizzazione straordinaria del paese".
Ora, qualsiasi politologo abituato al bel mondo come il grande Giovanni Sartori potrebbe ragionare a lungo dubbiosamente e chiedersi se effettivamente le larghe o larghissime intese siano in grado di produrre soluzioni veloci o non piuttosto nuovi negoziati, nuovi patteggiamenti, mediazioni e compromessi inutili. E giungere semmai alla conclusione che oggi ciò che conta non è il contenuto dei ragionamenti espressi, e delle idee manifestate, quanto la possibilità in sé di accedere ai mezzi di comunicazione.
Toccherebbe poi alle Donne Letizia o alle Irene Brin della contemporaneità mediatica formulare certe domande sull'opportunità che la moglie di un importante leader politico, ex candidato alla guida del paese, impegnato nella costruzione del Partito democratico, entri in campo con tanta scioltezza. Chi parla, la Palombelli giornalista o la Palombelli governo ombra? La commentatrice politica inciucista o la moglie del politico che deve tener fede al bipolarismo? Già, che cosa ne avrà pensato lui, Francesco Rutelli, battuto sul terreno delle intese larghe? E formulate queste strane domande, siamo sicuri di non ricevere nei denti la risposta definitiva, quella che accomuna politici e calciatori, "io non devo dimostrare niente a nessuno"?
D'altronde, le questioni di famiglia sembrerebbero il centro vero dell'agire politico, come dimostrò la lettera del cuore inviata da Veronica Berlusconi al marito sulle colonne della 'Repubblica', con il seguito della risposta strappalacrime del buon mascalzone latino e più tardi le rivincite sarde del Cavaliere in compagnia delle squinzie, con tanto di foto che testimoniavano la perdurante inclinazione per il gentil sesso da parte dell'ex premier (sulle vacanze di Berlusconi, risulta sempre attuale come principio avverso, una volta di più, il calembour dell'Avvocato: "Andavo a Capri quando le contesse facevano le puttane. Ora che le puttane fanno le contesse non mi diverte più").
Così la sensazione prevalente è che nonostante le modernizzazioni più o meno veloci siamo sempre dentro un 'Family day', magari a rovescio, come testimonia l'iniziativa di Margherita Agnelli, che ha citato madre Marella e figlio John Elkann, "esclusivamente per motivi tecnico-legali", insieme ai grandi sauri della Fiat Gianluigi Gabetti e Franzo Grande Stevens, per cercare di mettere in chiaro alcune vicende patrimoniali attinenti all'eredità dell'Avvocato (anche se non ci sarebbe da aggiungere che la migliore eredità di Gianni Agnelli è impalpabile, un fenomeno volatile di magie e di vezzi: come ha raccontato Marco Ferrante nel recente 'Casa Agnelli. Storie e personaggi dell'ultima dinastia italiana', "Giuliano Lanza di Trabia seguiva Agnelli con funzioni di intendenza, quando uscivano pagava le mance", e s'è detto tutto, signori si nasce).
Altro che salotti buoni, stanze ovattate, tavole di noce, silenzi, confidenze preziose e telefonate meditabonde. Guerra di tutti contro tutti, semmai. Qualcuno si è dimenticato quale fu la risposta tattica di Marco Tronchetti Provera a Romano Prodi sull'affare Telecom, mentre circolavano le ipotesi su spezzatino, vendita presunta, liquidazione della telefonia cellulare? Il documento del 'piano Rovati' passato graziosamente per ritorsione al 'Corriere della Sera', cioè uno sgarro impensabile quando la politica godeva ancora di deferenza.
Ma la politica invece si adegua. Nessuno che si stupisca se Gianfranco Fini, che piace tanto alle signore moderate per il suo aplomb sarkozista, al convegno dei giovani della Confindustria a Santa Margherita, invece di discutere di riforme, aggredisce Pier Luigi Bersani a proposito del caso Visco-Speciale: e ci vuole il coraggio di Matteo Colaninno, con quella faccia da ragazzino, a salire sul palco e a dire al portabandiera della destra 'identitaria' che il tema non sarebbe all'ordine del giorno. Forse la civile coscienza o incoscienza del giovane Colaninno sarebbe stata utile anche a Vicenza, quando nel 2006 si assistette allo show incendiario dello sciancato miracolato Silvio Berlusconi. Se invece di Diego Della Valle a dargli del buffone ci fosse stato un ragazzino cortese a dire al Caballero, guardi che qui si stava facendo un dibattito, e non è il momento di un comizio, chissà, ora la politica sarebbe meno isterica.
I giornali hanno titolato quasi tutti, con animo bipartisan: 'Rissa tra Fini e Bersani'; ma l'unico titolo decente e adeguato ai fatti reali avrebbe dovuto identificare l'aggressione a freddo, fuori contesto, fuori luogo, perpetrata da Fini contro il ministro diessino (dev'essere una tecnica studiata con precisione scientifica, visto che pochi giorni prima, durante un 'Porta a Porta' sul risultato elettorale delle amministrative, il presidente di An si era rifiutato di rispondere alle considerazioni espresse dal direttore della 'Stampa' Giulio Anselmi dicendo pressappoco: "Caro direttore, io non le rispondo perché noi ci parleremo in tribunale, dato che io l'ho querelata", senza degnarsi di aggiungere una parola nemmeno sui contenuti della querela, con Anselmi e Bruno Vespa che lo guardavano un po' scossi).
Il secondo principio fondamentale del galateo della nuova classe si riassume nell'aureo principio: 'Abbiamo sempre ragione noi'. Noi vuol dire tutti coloro che si riconoscono nell'agenda Giavazzi, nel centrismo riformatore di Mario Monti, nell'idea che i problemi non sono né di destra né di sinistra, nel mainstream di pensiero secondo cui le liberalizzazioni non bastano mai e le privatizzazioni neppure. Noi che ci diamo tutti del tu anche in tivù. Noi che siamo d'accordo su tutto: sul taglio delle ali, sulla crisi del bipolarismo, sul tracollo dei partiti, sull'insufficienza (a essere di buon cuore) del Partito democratico. Ma possibile che siano scomparse tutte le differenze, anche quelle di classe, in senso sociale e in termini di eleganza?
Per appartenere alla classe dirigente occorre soltanto imparare alcuni mantra del tipo: 'Sono sereno', che è la frase preferita da tutti quelli che stanno per andare in galera. Non sembra ancora entrata nel lessico la straordinaria performance del generale Speciale, appena deposto dal ministro Padoa-Schioppa, il suo couplet irridente ma rivelatore davanti a Berlusconi alla festa della Repubblica: "Sempre agli ordini, presidente". Ma diventerà un cult, come da tempo è diventato un fiore del blog lo scambio fra Claudio Sabelli Fioretti e l'intervistata Lavinia Borromeo, giovane consorte di Jaki: "Ha amici poveri?". "Dipende da che cosa si intende per povertà. Parliamo di persone che devono lavorare per mantenersi?". Se c'è da gettare la maschera, gettiamola, senza ipocrisie, à la guerre comme à la guerre. Se va male, è sempre utile la conclusione di Altan, fra i lavoratori della vecchia classe, quella operaia: "E allora concedimi l'ultimo slow e poi que serà serà".
Mozart e Da Ponte
Su Il compagno segreto
1. Come si scrive un libretto?
Che cosa complicata! – Goldoni per esempio all'inizio sbagliò tutto. Aveva 25 anni, e già una buona esperienza di autore teatrale. Nelle Memorie racconta che, sicuro di aver composto un capolavoro che non avrebbe dovuto che essere adattato per essere un libretto perfetto, andò – era a Milano – da un suo amico potente, direttore dei balletti, perché lo esaminasse. Il testo fu esaminato assieme a un gruppo di cantanti di grido, tra cui spiccava il celebre castrato Caffariello: non ci fu uno che salvò la fatica del giovanotto da una bocciatura senza appello.
Accompagnato il giovane sfiduciato in un'altra stanza, Goldoni si sentì dire:
“Ascoltate, vi indicherò qualcuna di queste regole, che sono immutabili e che voi non conoscete. I tre personaggi principali di un Dramma devono cantare cinque arie a testa: due nel primo atto, due nel secondo, e una nel terzo. La seconda attrice e il secondo alto possono averne solo tre, e gli ultimi ruoli devono accontentarsi di una, o al massimo due. L'autore delle parole deve fornire al musicista le differenti sfumature che formano il chiaroscuro della musica, e stare attento che due arie patetiche non vengano uno dopo l'altra; bisogna alternare, con la stessa precauzione, le arie di bravura, le arie d'azione, le arie di mezzi caratteri, i minuetti e i rondò.” (Goldoni, Memorie, pp.148-51).
Tornato a casa, Goldoni prese il manoscritto e lo gettò nel fuoco.
Morale: solo chi fa parte di un ambiente teatrale, coi cantanti e il compositore, può scrivere un buon libretto d'opera. Il librettista è uno scrittore obbediente. Anche un Racine e un Alfieri, del resto, lo erano nelle loro tragedie; diversi sono solo gli “Aristoteli”: non le fatidiche unità di tempo, luogo e azione, ma le esigenze del compositore e “anche del primo buffo, la prima donna, e più di qualche volta il secondo, terzo e quarto cantante della compagnia”! (L. Da Ponte, An Extrat, 1819).
Lo scrittore obbediente, il risolutore di situazioni impossibili, si faceva eroico nella scrittura dei finali d'atto, garbuglio rispetto al quale le regole aristoteliche erano giochetti per infanti:
“In questo finale devono per teatrale domma comparire in scena tutti i cantanti, se fosser trecento (…) e se l'intreccio del dramma nol permette, bisogna che il poeta trovi la strada di farselo permettere, a dispetto del criterio, della ragione e di tutti gli Aristoteli della terra.” (Memorie).
E, una volta finito, il testo non è qualcosa che possa illudersi di riposare nell'Eden della raggiunta definitezza: quel testo non esisterà mai: esisteranno solo libretti da adattare costantemente: alla compagnia e al pubblico, ai cantanti che cambiano e a qualunque altro accidente: vedi anche le differenze tra il Don Giovanni di Praga e quello di Vienna…
2. Non Sparate sul librettista!
Contentare in pria conviene
Il maestro di cappella (…).
Quando poscia egli è contento,
ti rimangon mille impicci:
dei combattere con cento
teste piene di capricci.
S'anco i primi son discreti
Coi maestri e co' poeti
V'è il terz'uom, la quarta buffa
Che risveglia la baruffa.
Chi la parte vuol migliore
Perch'egli è secondo attore;
chi vuol l'aria di bravura
perché là fa più figura;
chi non vuol quelle parole,
chi la musica non vuole…
(L. DA PONTE, Saggi poetici)
3. Prima la forma
Poi il contenuto. Ma l'Ottocento non ci aveva insegnato il contrario? - Qui Mozart definisce un campo di regole buone per impossessarsi di un contenuto qualunque, purché disposto a piegarsi alla legge armoniosa di una forma, per ora, astratta:
“La cosa però più importante è che l'insieme risulti veramente comico; se poi fosse possibile, bisognerebbe includere due buone parti femminili dello stesso livello. Una dovrebbe essere Seria, l'altra Mezzo Carattere. Ma le due parti dovrebbero avere la stessa importanza. La terza donna può anche essere del tutto Buffa, e così tutti gli uomini, se è necessario.”
(Lettera al padre, Vienna 7 maggio 1783)
Due film
Lo specchio
Film d'amore e d'anarchia
Giuliano e Solimano su Abbracci e pop corn
Lo Specchio di Andrei Tarkovsky (1975) Giuliano 14 giugno 2007
" Dalla stazione, la strada passava per Ignatieva, svoltava seguendo l'ansa della Gruna a un chilometro circa dalla cascina dove allora, prima della guerra, trascorrevamo tutte le estati; e insinuandosi in un fitto bosco di querce proseguiva oltre, verso Tomscinò. Di solito riconoscevamo i nostri solo quando li vedevamo apparire da dietro il grande cespuglio che si alzava in mezzo al prato: se dal cespuglio la persona si dirigeva verso casa, si trattava di papà; altrimenti non era papà. E un giorno papà non sarebbe più tornato.
- Scusate, è questa la strada per Tomscinò?
- Non dovevate svoltare al cespuglio.
- Ah. E voi, perché...
- Perché cosa?
- Perché ve ne state lì seduta.
- Io vivo qui.
- Dove, sullo steccato?
- Ma cosa volete sapere, la strada per Tomscinò o dove vivo io? " (...)
Una donna è seduta su uno steccato, in aperta campagna. Da lontano, un uomo che passa la nota e le si avvicina; la donna è molto bella. L'uomo, un medico, tenta un approccio educato e gentile, chiede informazioni; infine le si siede accanto, ma lo steccato non regge il peso e si rompe. I due finiscono a terra, la donna si rialza subito e l'uomo ride. Poi anche l'uomo si rialza, si spolvera, sorride, riprende la sua strada e fa un cenno di saluto. Un'improvvisa folata di vento piega dolcemente l'erba del prato.
Questa è la scena iniziale (ma, prima dei titoli di testa, a un ragazzo balbuziente viene insegnato “a non aver paura della sua voce”) di uno dei film più difficili e affascinanti che mi sia mai capitato di vedere. E' poco comprensibile perché è autobiografico e parla della madre di Tarkovskij, e dell'infanzia del regista, negli anni precedenti alla Guerra. Nella scena dello steccato, Tarkovskij ha la finezza di citare Cechov: ed è solo una delle piccole e grandi citazioni fatte in questo film. C'è il richiamo ai grandi pittori: Leonardo, Monet, ma anche Brueghel e Bosch, e Giorgione con la sua Tempesta.
Ma i protagonisti sono gli elementi atmosferici, il fuoco, l'acqua, il vento, la luce, gli elementi primordiali. I movimenti di macchina hanno una magia nascosta, il vento arriva nel momento esatto in cui ce ne è bisogno, un uccellino si posa sul berretto di un ragazzo e il ragazzo lo prende, un oggetto cade dal tavolo proprio quando la telecamera si ferma ad osservarlo, passato e presente si fondono, perfino un alone di vapore su un tavolo diventa importante. La comunione con la Natura, paganesimo e panteismo, religione panica sono tra i protagonisti dei film di Tarkovskij. Il film è composto di vari episodi, quadri apparentemente semplici che vanno a formare un disegno complesso, un arazzo, un tappeto persiano, leggibile solo a pochi e anche ad essi con grande difficoltà. I colori sono i colori dei sogni, colore pieno oppure altri colori; il bianco e nero non è mai quello classico, è piuttosto un grigio, un seppia, un verdastro, il colore dei sogni e dei ricordi. Tarkovskij filma i sogni, e i ricordi.
Come Bertolucci, anche Tarkovskij è figlio di un grande poeta: e “Lo specchio” comprende molte poesie del padre di Andrej, poesie bellissime lette, nella versione italiana, dalla voce toccante di Romolo Valli.
Amo gli occhi tuoi, amica mia,
e i loro giochi.
Splendidi di fiamme quando
li alzi all'improvviso e,
come fulmine celeste,
guardi veloce tutt'intorno.
Ma c'è un fascino più forte:
gli occhi tuoi rivolti verso il basso,
negli attimi che un bacio appassionato,
e fra le ciglia semichiuse del desiderio,
il fumo, il fosco fuoco...
( Arsenij Tarkovskij
Film d'amore e d'anarchia di Lina Wertmuller (1973) Solimano 17 giugno 2007
Ancora Lina Wertmuller, dopo Travolti da un insolito destino, e non finirò qui, ce ne ho almeno un altro, forse due. Che sovrabbondanza di trovate! Di alcune potrebbe fare a meno, tipo il titolo lungo: Film d'amore e d'anarchia sarebbe un titolo perfetto, più bello non si può, e invece ci mette la giunta. Secondo me lo fa apposta, un po' per spregio un po' per sberleffo ai dottori in scienze filmiche che se la prendono con lei, fra supponenza ed invidia. Perché le invidiano la sua velocità vivace, il suo spendersi senza misura, il suo avere le mani piene non si sa se di gioielli o di bigiotteria, per me c'è di tutto, e i gioielli si riconoscono perché luccicano di meno, ma ci stanno, ci stanno.
In Italia c'è stata una diffusa cultura postribolare, che ha riguardato giornalisti, scrittori, registi: Montanelli e Fellini, ad esempio. In uno fra i film di Fellini che ammiro di più, Roma, c'è una lunga scena in un bordello di fronte a cui sono diviso, c'è il Fellini più grande, che per me è il Fellini potente, e il Fellini piccino, mischiato di nostalgie e di ghiribizzi maliziosi. Ma in letteratura ci sono esempi alti: la Ghisola di Con gli occhi chiusi e la Angiolina Zarri di Senilità. Forse, e non ci si bada, il più grande è nel Pasticciaccio, con le pagine in cui il commissario Ingravallo interroga Ines Cionini, e l'antro della Zamira, che finisce con il brano meraviglioso della gallina guercia, e magari lo inserirò nei commenti. Ma Gadda, Svevo, Tozzi sono ben altra cosa rispetto ai rimpianti mezzo gaglioffi mezzo coglioni e sempre dolciastri di altri, anche ben noti, in cui l'esaltazione del meretricio nei bordelli è un come eravamo: non erano bene, tutto lì.
Lina Wertmuller conosce questo lato a volte miserello del milieu di cui fa parte, e un po' ci si adegua un po' no, ma l'aiuto di Mariangela Melato è formidabile: la sua Salomè, prostituta focosissima e furba, ma affetta da idealismo anarchico, riesce a tenersi stretto il gerarca Spatoletti (Eros Pagni), di cui andrebbero sentiti e risentiti i monologhi tronfi che gli fa dire la Wertmuller. Ne esce una Italia trasformata dal fascismo in un paese-lupanare, si badi, non solo per violenza del regime, ma per corrispondenza a certi caratteri costruiti giorno per giorno nei secoli di dominazione spagnola, papalina, austriaca, borbonica e chi più ne ha più ne metta: l'Italia non paese povero ma povero paese, come diceva quello sciovinista di De Gaulle, avendo ragione, in questo caso. Tunin (Giancarlo Giannini) è l'anarchico che progetta un attentato e che viene ospitato nel bordello; sminuito nel confronto con Salomè, si riabilita alla grande quando incontra l'Amore per la Tripolina (Lina Polito), prostituta molto giovane e concupita da tutti, Amore assolutamente ricambiato. La storia finirà male, la trama la conoscete, ma c'è una parte del film che ho trovato di commossa grandezza: la Tripolina vuole tenersi Tunin, non vuole perderlo con l'attentato, e se lo imbambola a furia di amplessi, perché così la mattina non sentirà la sveglia e farà tardi all'appuntamento con l'attentato - con la galera e con la morte – e Salomè, pur utopista anarchica, le tiene bordone. Tunin si sveglia in ritardo, ma si ribella alla possibile felicità che gli sta davanti e corre - in ritardo – dietro al suo nero destino. Qui la commedia all'italiana diventa Tragedia vera, non da povero paese. Per me Lina Wertmuller se n'è accorta benissimo, di quello che le è uscito dalle mani, meno ci hanno fatto caso i dottori in scienze filmiche, disposti a togliersi il cappello di fronte ad operazioni di altri, operazioni seriose, noiose e furbe: retoriche, in una parola. Politicamente corrette, anche: ovvìa, certe cose alte in un bordello non possono accadere! E invece la Wertmuller le fa accadere e ce le fa ammirare, quindi c'è speranza che cose alte possano accadere perfino in un paese chiamato Italia.

 17 giugno 2007
17 giugno 2007
![]() 17 giugno 2007
17 giugno 2007