



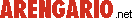
sulla stampa
a cura di P.C. - 19 luglio 2006
La sproporzione che non capiamo
Ernesto Galli Della Loggia sul Corriere della Sera
È rispettoso delle giuste "proporzioni", così care al nostro ministro degli Esteri e ancora ieri tanto appassionatamente difese a Montecitorio, ciò che Israele fece, mettiamo, nel 1960, quando impegnò decine e decine di uomini dei servizi segreti, rischiando pure le sue relazioni con l'Argentina, al semplice scopo di catturare un vecchio boia nazista, processarlo e condannarlo a morte? È lecito dubitarne. E cosa avrebbero detto l'onorevole D'Alema e i suoi funzionari della Farnesina nel 1976, facciamo un altro caso, allorché sempre Israele, violando immagino un buon numero di norme del diritto internazionale, organizzò un rischiosissimo raid aereo verso l'aeroporto di una lontana città africana e un'altrettanto rischiosa operazione di commando pur di recuperare qualche decina di passeggeri ebrei tenuti in ostaggio da un gruppo di dirottatori? Avrebbero forse detto che sono cose che non si fanno, che non stanno bene: cose tipiche, per l'appunto, di un Paese che non sa mantenere le giuste proporzioni tra azioni e reazioni.
Naturalmente l'onorevole D'Alema ha ragione da vendere a osservare come anche il comportamento israeliano di questi giorni sia segnato da un'evidente mancanza di misura. Non solo per l'entità e la qualità delle operazioni belliche in corso, ma anche pensando a come tutto è cominciato, e cioè alla minaccia di rappresaglie durissime se non fossero stati immediatamente liberati il soldato rapito il 25 giugno a Gaza, e insieme a lui i due militari anch'essi rapiti pochissimo dopo alla frontiera del Libano; il cui rilascio è ancora oggi considerato da Gerusalemme condizione irrinunciabile per la fine dei combattimenti. Non è forse esagerato, sproporzionato appunto, un simile coinvolgimento per tre coscritti qualunque? Che razza di Paese è quello la cui politica obbedisce a sentimenti così fuori misura? Che agisce in maniera così reattiva, che si fa guidare da criteri così irragionevoli e perentori? Sono domande e considerazioni sensate — chi potrebbe negarlo? — ma proprio la loro sensatezza non ci fa capire nulla di che cos'è Israele, e dunque non ci permette di avere alcuna vera politica nei suoi confronti. Lo diciamo nella convinzione che anche il nostro ministro degli Esteri, nella sua intelligenza, ne è alla fin fine consapevole.
La nostra sensatezza di bravi europei, di bravi democratici, di bravi diplomatici, non ci permette di capire, ad esempio, che ad essere sproporzionata è innanzi tutto la condizione materiale di quel Paese. Che senso della misura c'è, infatti, ad essere in cinque-sei milioni di abitanti su un territorio grande più o meno come la Puglia e avendo di fronte un oceano di terre e di uomini ostili? Per forza poi da questa sproporzione nasce una sensibilità sopra le righe, un'esasperazione di sentimenti sempre in agguato, un sentirsi votati tutti al combattimento come un solo esercito. Se persone come Amos Oz o Avrahm Yehoshua si dicono oggi d'accordo con il loro governo non è forse perché ogni abitante d'Israele sa bene che avrebbe potuto essere lui uno di quei tre soldati rapiti, e dunque pensa che sia sacrosanto fare di tutto per riportarli a casa sani e salvi: anche a costo di dispiacere a qualche cancelleria del Vecchio continente?
Ciò che in Israele altera tutte le misure, deforma tutte le proporzioni, è la dimensione simbolica che abita in quei luoghi, che spira da quei nomi. È il significato simbolico del suo popolo, di cui proprio noi europei, se non sbaglio, dovremmo sapere qualcosa: qualcosa che faremmo bene a non scordare.
Non sarà una guerra lampo
Davide Frattini sul Corriere della Sera
GERUSALEMME — "Se mi richiamano tra i riservisti, dobbiamo cominciare a preoccuparci", scherza Avi, che ha 36 anni, e dice "prima di arrivare a noi vecchietti, questa guerra deve durare ancora a lungo". Per ora il ministero della Difesa ha ordinato la mobilitazione di tre battaglioni, almeno mille uomini, che dopo un breve addestramento verranno piazzati in Cisgiordania per sostituire le truppe spedite al confine Nord. "Vogliamo rafforzare la frontiera — spiegano dallo Stato maggiore — per evitare infiltrazioni dell'Hezbollah nei nostri villaggi".
Lunedì è stata superata la linea che gli analisti avevano fissato per giudicare l'andamento della guerra: quei "sei giorni" che negli ultimi quarant'anni gli israeliani hanno usato per valutare "le vittorie lampo". "Dobbiamo cominciare a chiederci — scrive Shimon Shiffer su Yedioth Ahronoth — quando il primo ministro potrà dichiarare: abbiamo vinto". E ricorda quel senatore americano che per uscire dalla palude del Vietnam aveva suggerito "proclamiamo di aver vinto e torniamocene a casa".
...
Lo storico Michael Oren, che proprio sul conflitto dei Sei giorni ha scritto il suo libro più importante, crede che dal 1967 vadano ricavate le lezioni per capire come proseguire l'offensiva. E sul settimanale liberal The New Republic suggerisce di bombardare la Siria oggi per evitare problemi più grandi domani: "Fino a quando Damasco viene lasciata fuori dal gioco, Israele non può raggiungere in alcun modo un cambiamento nel labirinto politico libanese e assicurare un cessate il fuoco duraturo al Nord. Al contrario, rassicurati dal fatto che gli israeliani non vogliono attaccarli, i siriani possono continuare a far crescere le tensioni. Il risultato potrebbe essere una guerra totale con Damasco, l'Iran e gravi disordini in Giordania, Egitto, i Paesi del Golfo".
L'attacco che Oren propone è un bombardamento delle forze di terra dislocate al confine con il Libano. "Eliminando cinquecento tank siriani — che servono al presidente Bashar Assad per preservare il suo regime — possiamo mandare il segnale di non voler ritornare allo status quo". O come ha detto il ministro della Difesa Amir Peretz, senza accennare a Damasco: "Non accetteremo di ritrovarci con l'Hezbollah a distanza di sputo".
Il mondo arabo si frantuma
Antonio Ferrari sul Corriere della Sera
L'obiettivo di Hassan Nasrallah, leader dell'Hezbollah libanese, di raccogliere simpatie, sostegno, aiuti e di scatenare la rivolta delle masse musulmane e dei loro regimi contro Israele, è fallito. I ministri degli Esteri arabi, convocati al Cairo, si sono abbandonati infatti a un furibondo litigio che ha fatto tremare i muri già cadenti della Lega e ha prostrato il suo segretario generale, Amr Moussa, ormai ridotto a un osservatore senza potere, costretto ad annotare odi, sospetti e periodici cambiamenti di campo. Sul fatto che il processo di pace sia morto, che il Quartetto (Usa, Ue, Onu e Russia) sia rimasto un'illusione operativa e che occorra tornare a investire di autorità il Consiglio di sicurezza erano d'accordo quasi tutti. Ma sulla solidarietà ad Hezbollah la rottura è stata clamorosa e accompagnata da velenose stilettate. Una su tutte: "Quelli sono al servizio dell'Iran".
...
Attorno a Walid Muallem, ministro degli Esteri di Damasco, diplomatico troppo sottile e astuto per non comprendere il rischio di un abbraccio troppo affettuoso tra il suo Paese e il regime degli ayatollah, quindi bisognoso dell'aiuto equilibratore dei fratelli nel sostenere la lotta contro Israele, si sono schierati senza rocciosa convinzione Sudan, Algeria, Qatar e Yemen; mentre i Paesi più influenti e insieme preoccupati del mondo sunnita, Egitto, Arabia Saudita e Giordania, con l'aggiunta del Kuwait, hanno opposto uno sprezzante rifiuto. Quando il ministro di Doha ha chiesto di tener conto dei desiderata delle "strade arabe" e, quindi, di appoggiare l'Hezbollah, è stato zittito dal principe saudita Feisal, che lo ha invitato a svegliarsi "invece di pensare alle strade e alle masse". E a comprendere — questo voleva intendere — il pericolo rappresentato dai piani tentacolari di Teheran.
Una lettura superficiale potrebbe giustificare i due schieramenti, incasellandoli come antiamericani e filoamericani. La realtà è che l'allargamento dell'influenza sciita in tutto il Medio Oriente risulta essere il collante di antiche paure. Che in qualche modo coinvolgono la stessa Siria, che ha un regime alauita e la maggioranza della popolazione sunnita. Quello della Lega araba al Cairo è dunque un campanello d'allarme. E non sorprende che, nel rifiuto del sostegno all'Hezbollah sciita, sia stato incluso (anche se non vi sono stati riferimenti diretti) anche il governo palestinese di Hamas, che pure è sunnita. In tanti infatti vi è la convinzione che il sequestro del caporale israeliano a Gaza e il conseguente e quasi simmetrico rapimento di altri due militari dello Stato ebraico da parte degli estremisti libanesi siano parte della stessa premeditata trappola. Voluta da Teheran, cioè dal Paese che si era offerto di aiutare economicamente Hamas, sottoposto a un boicottaggio internazionale.
La distanza da Tel Aviv compatta la maggioranza
Massimo Franco sul Corriere della Sera
Massimo D'Alema è riuscito a compiere un piccolo miracolo unitario. Le sue posizioni sul conflitto mediorientale hanno cementato l'Unione più di quanto non fosse accaduto sull'Iraq e sull'Afghanistan. Per il ministro degli Esteri, il plauso parte dalla Margherita e arriva ai duri e puri della sinistra antagonista: partiti tradizionalmente antiisraeliani e filopalestinesi come Prc e Pdci lodano "l'aria nuova" portata da D'Alema. Sono gli ultimi mattoni, agognati, per costruire quella maggioranza "autosufficiente" che fa penare da un mese Romano Prodi e la Farnesina. E per ufficializzare la "discontinuità" con le scelte internazionali di Silvio Berlusconi.
Dal centrodestra cercano di far notare che le novità, in politica estera, non sempre aiutano la credibilità di un Paese. L'ex ministro Gianfranco Fini avverte che "la discontinuità non è una buona carta da giocare". E il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini invita a non disperdere una strategia mediterranea pluridecennale, che fa risalire ai tempi della Dc. Ma l'Unione tende a ritenere Berlusconi responsabile del primo "strappo" rispetto alla tradizionale politica di equidistanza fra palestinesi e israeliani. Lo accusa d'avere scelto un atteggiamento troppo comprensivo verso il governo di Gerusalemme. E, per calcoli insieme interni e internazionali, il governo Prodi si mostra deciso a correggere quest'impostazione, approfittando della crisi libanese; e aggrappandosi a un'Europa divisa e impacciata; ma spaventata dall'escalation fra Israele ed Hezbollah.
...
Il modo in cui l'Unione sottolinea la svolta e ne dilata la portata sembra fatto apposta per marcare i confini parlamentari con l'opposizione. Ma anche per sostenere che grazie a queste posizioni l'Italia starebbe recuperando un ruolo nella politica mediterranea e nei rapporti con i Paesi arabi. Si conferma dunque la volontà di smantellare le strategie mediorientali di Berlusconi e Fini; e di riaffermare una politica più filopalestinese, nonostante sia cambiato il contesto del conflitto, proiettandolo verso Siria e soprattutto Iran. Paradossalmente, una posizione dell'Unione meno ostile a Israele è quella del segretario ds Piero Fassino (oltre che del radicale Capezzone).
In teoria, la conseguenza dovrebbe essere un "sì" di tutta la maggioranza al rifinanziamento delle operazioni militari oltre confine. Ma non è detto che sia così. Alla Camera la questione non è mai stata considerata dirimente. Al Senato, dove l'Unione rimane in bilico, le consonanze sul Medio Oriente promettono di smussare, se non azzerare, i contrasti sull'Afghanistan, con qualche incognita. Per un D'Alema che sul "no" della sinistra radicale alle nostre truppe a Kabul aveva minacciato le dimissioni, si tratterebbe di una rivincita: anche se i complimenti lasciano presagire un'ipoteca delle frange anti- israeliane sulla politica estera italiana.
Ma il plauso di Prc e Pdci mette un'ipoteca sulla politica estera del governo
Afghanistan, sì alla mozione dell'Unione
su la Repubblica
ROMA - La Camera ha approvato la mozione della maggioranza sulla missione militare in Afghanistan con 298 i voti a favore e 249 contrari. In precedenza l'assemblea di Montecitorio aveva bocciato la mozione dell'opposizione (248 i si e 291 i no).
L'Unione ha superato così la prima prova sull'Afghanistan, approvando la mozione che propone in prospettiva il superamento di Enduring Freedom, ma ci è riuscita a caro prezzo: uno dei dissidenti, Paolo Cacciari (Prc) per non partecipare al voto ha preferito addirittura dimettersi da parlamentare. Un gesto plateale, annunciato in aula dallo stesso Cacciari, che ha colto tutti di sorpresa, in primis il capogruppo del Prc, Gennaro Migliore, che "stupito e frastornato" ha spiegato di non condividere ma di rispettare tale scelta.
...
"Bondi - è stata la replica del ministro degli Esteri - ha chiamato per sette volte in ballo la mia dignità. E' un pulpito tanto autorevole che merita un chiarimento". A queste parole dai banchi della Cdl si è alzato un boato di disapprovazione, ma D'Alema è andato avanti per la sua strada. "Sono stato insultato - ha sottolineato - e non chiedo a nessuno di chiedere scusa. Non vedo di cosa dovrei scusarmi, non ho detto nulla di offensivo contro il Parlamento".
Spiegazione che non ha convinto affatto il leader dell'Udc Pierferdinando Casini. "D'Alema - ha osservato - ha un carattere, diciamo, complesso. Ma è una persona intelligente. Non faccia finta, allora, di essere Biancaneve. Ha fatto una battuta umiliante nei confronti di Bondi perché si è sentito piccato per le parole pronunciate dal collega di Forza italia. Però è ministro degli Esteri e forse avrebbe fatto meglio a non rispondere".
Ancora più dura la presa di posizione del capogruppo di An Ignazio La Russa. "Caro ministro degli Esteri, il suo eloquio nei riguardi dell'onorevole Bondi appartiene più al consiglio comunale di Gallipoli che a quello di un ministro degli esteri", ha commentato il parlamentare della Cdl. "Di quale pulpito parlava? - ha insistito - quel pulpito è la natura politica del movimento di Bondi o forse i comuni trascorsi comunisti?". Comunque, ha concluso La Russa, "il suo intervento è completamente fuori luogo".
Che invidia la Germania
Gian Enrico Rusconi su La Stampa
“Confesso di provare invidia per la Germania”. Così ha intitolato la Frankfurter Allgemeine l'intervista di Giorgio Napolitano, giorni fa, in occasione della sua visita (di oggi) a Berlino. E' una frase schietta in un colloquio che esprime apprezzamento per il sistema politico tedesco. Un sistema che sa coniugare una forte competizione tra i partiti con la loro sostanziosa convergenza sui grandi temi e interessi nazionali (che può tradursi eventualmente anche in formule politiche come la Grande Coalizione). Napolitano ammira in particolare lo sviluppo della socialdemocrazia tedesca che considera "esemplare" per la sinistra italiana.
Sono giudizi che esprimono la personalità politica del Presidente, che giustificano la sua "invidia" e alludono in modo elegante alla distanza esistente tra il sistema politico tedesco e quello italiano. Con il sottinteso che il primo funziona, il secondo - quello italiano- no. O comunque funziona in modo pericolosamente diverso. Oggi i politici italiani del centro-sinistra guardano a Berlino. Molti hanno già fatto visite di cortesia. Contano sulla Germania per ricominciare ad essere presi in considerazione in Europa. Ma non sarà facile. I politici tedeschi ascoltano gentili, gratificati ma, in fondo, si chiedono che cosa vogliono esattamente i colleghi italiani. Non si sono ancora accorti, gli italiani, che gli ultimi dieci anni hanno irreversibilmente alterato non solo le condizioni che hanno consentito le mitiche (e un po' mitizzate) convergenze tra Adenauer e De Gasperi, ma anche le concrete cooperazioni degli Anni Ottanta (Genscher- Colombo-Andreotti)?
...
L'ambito primo e naturale di un nuovo rapporto italo-tedesco è l'Europa. Ma anche qui non basta dichiarare di avere grandi aspettative nella presidenza tedesca dell'Unione nel primo semestre 2007, per un rilancio politico-costituzionale del processo europeo. Che cosa si fa in concreto? Sono previsti incontri, gruppi di lavoro, cooperazioni? Tedeschi e italiani hanno contingenti di pace, fianco a fianco, dal Kosovo all'Afghanistan. Sono guidati dalla stessa filosofia politica umanitaria. Fanno qualcosa per coordinarsi, al di là degli aspetti tecnici?
L'elenco delle occasioni per riprendere contatti per un rinnovato rapporto italo-tedesco - anche in altri ambiti - è infinito. Ma ho l'impressione che si faccia solo retorica.
Tornando alla politica interna, vorrei fare una considerazione finale sulla Grosse Koalition. Si tratta di una tipica esperienza tedesca, molto istruttiva per altre situazioni nazionali. Questo vale anche per l'Italia dove viene evocata spesso fantasiosamente.
Non si tratta infatti di una "coalizione grande" - perché in questo caso l'avremmo già con il governo di Romano Prodi, "supergrande" in termini di rappresentanze politiche. Grande, alla tedesca, non sarebbe neppure una coalizione che portasse a una formazione governativa che comprendesse l'Udc (ora nel centro-destra) accanto ai Ds. Questa ipotesi, per il momento del tutto irrealistica, ci serve per ricordare che ciò che qualifica la Grande Coalizione tedesca non è semplicemente l'estensione politico-ideologica, che include sinistra (socialdemocratica) e destra (democristiana). Ma è la volontà politica di due "partiti popolari" (così si autodefiniscono Spd e Cdu/Csu), dotati di una propria solida struttura, identità e leadership politica - volontà di stringere una alleanza contrattata e limitata nel tempo per poi riprendere ciascuno la propria strada. Non è un "inciucio", ma un atto di responsabilità verso l'elettorato in una congiuntura politica particolare. La Grande Coalizione non è una fase di passaggio per ricreare nuove condizioni politiche o magari un nuovo partito di centro, come è evidente nelle attese degli ex democristiani italiani delusi dall'esperienza berlusconiana.
Soprattutto però - e qui il discorso torna sulla "invidia" di Napolitano per la Germania - il presupposto fondamentale della Grande Coalizione è una cultura politica in cui gli avversari politici hanno rispetto e considerazione reciproca, pur nella forte differenziazione delle linee politiche. E' un sogno per la situazione italiana odierna.
La tentazione di allargarsi
Claudia Mancina su La Stampa
Il tema di una ridefinizione della maggioranza sembra destinato a segnare la vita di questo governo. La fragilità della sua base al Senato è un problema difficile: anche se non si tratta sempre di questioni delicate come la spedizione militare in Afghanistan, nell'aula del Senato può essere Afghanistan tutti i giorni. Non è un caso che la capogruppo Finocchiaro e il sottosegretario Letta abbiano sollevato il problema nelle assemblee dei rispettivi partiti.
L'hanno sollevato quasi come un problema tecnico, che riguarda la conduzione dell'aula. Ma ovviamente non è un problema tecnico, e incorpora un dilemma politico che è costitutivo di questa coalizione e del modo in cui si è formata: unita dall'antiberlusconismo più che da una omogenea cultura di governo. Per dirla con le parole del ministro Mussi, "ora che il dovere patriottico di cacciare Berlusconi è stato compiuto, possiamo sentirci più liberi". Mussi parlava del partito democratico, ma la formula si attaglia benissimo anche ai vari mal di pancia che in queste settimane minacciano il governo, e continueranno a minacciarlo nel futuro. Liberi di che? Di non essere d'accordo; di privilegiare la propria astratta coerenza rispetto agli impegni di coalizione; di tirare la corda sino al punto critico; e anche di seguire meschine logiche di visibilità differenziale.
...
Questo è il dilemma di fondo, che stringe in un unico nodo il partito democratico e l'allargamento della maggioranza. Restare vincolati allo schema politico della coalizione antiberlusconiana - col suo programma spesso ambiguo, formulato in modo da scontare in anticipo defatiganti bracci di ferro tra riformisti e massimalisti - o affrontare un'evoluzione politica che metta capo, a poco a poco, a un equilibrio più normale, più europeo, tra il nucleo politico riformista della coalizione e le ali estreme? Si tratterebbe di un equilibrio difficilissimo: ma il messaggio di Finocchiaro e Letta dice che anche nell'altro caso l'equilibrio è difficilissimo e precario. Vedremo se e come Prodi e l'Ulivo sceglieranno di risolvere il dilemma.
Fin qui si parla di un allargamento della maggioranza, che porti voti in più e non determini un mutamento degli assetti politici. Ben altra cosa sarebbe la sostituzione di un pezzo di maggioranza con un pezzo dell'attuale opposizione. Questo è lo scenario paventato, quasi per contrappasso, da Rifondazione; ma è difficile pensare che il centrosinistra voglia ripetere l'infelice esperienza del 1998. Ancora diverso è lo scenario della grande coalizione, sul quale è tornato Tremonti: un'ipotesi che entrerebbe in gioco in caso di caduta dell'attuale governo. Sarebbe, in quel caso, un'ipotesi legittima; ma è lecito per lo meno dubitare che quella soluzione possa giovare all'evoluzione del sistema politico italiano, che non è caratterizzato, come quello tedesco, da un bipolarismo consolidato, ma annaspa ancora in una transizione incompiuta, sempre a rischio di ritorni al passato.
Ma i soldati europei servirebbero
Avraham B. Yehoshua su La Stampa
Ancora guerra. Ancora sirene di allarme, rifugi. E ancora una volta, al suono della sirena, mia moglie e io ci trasferiamo velocemente dai nostri rispettivi studi alla minuscola stanza di sicurezza le cui pareti sono un po' più spesse e dove, fra le carrozzine, le bambole e i libri per bambini delle nipotine, sentiamo i boati dei missili caduti, vicini e lontani, aspettando la sirena del cessato pericolo.
Sono nato nel dicembre del 1936, quasi settant'anni fa. In quell'anno scoppiò una rivolta palestinese contro ebrei e inglesi che mieté centinaia di vittime fino a che la grande fiammata della seconda guerra mondiale riportò per qualche anno la calma. Nel 1947, bambino di undici anni, trascorsi lunghi mesi in un rifugio con mia madre e mia sorella in una Gerusalemme assediata mentre mio padre, grande conoscitore della lingua araba, era stato reclutato dai servizi dell'Intelligence malgrado si fosse appena ripreso da una ferita subita durante un'azione di sabotaggio di disertori inglesi.
Più tardi, come soldato paracadutista, presi parte alle rappresaglie in Giordania e nell'ottobre del 1956 penetrai nel deserto del Sinai durante la guerra di Suez contro l'Egitto. Continuai poi a prestare servizio per anni come riservista mentre si susseguivano nuove guerre: quella dei Sei giorni, dello Yom Kippur, l'infelice guerra del Libano, e poi gli atti terroristici, la prima Intifada, la guerra del Golfo con i missili Scud, la seconda Intifada con gli attentati suicidi. Nel frattempo anche i miei due figli maschi si arruolavano nel corpo dei paracadutisti e la saga proseguiva infinita.
...
Gli atti di aggressione dei miliziani di Hezbollah portano loro denaro e prestigio politico e quindi poco gli importa se altri cittadini libanesi precipitano in una spirale di distruzione e di morte. L'incapacità di uno Stato sovrano di imporre le proprie decisioni crea situazioni tutt'altro che semplici. Questa debolezza non è però una caratteristica di tutti gli Stati arabi. Dopo tutto vediamo come alcuni di essi riescano a imporre la propria linea politica pur usando il pugno di ferro. Il caos è molto più pericoloso della politica di un regime centralizzato e assertivo e il problema nasce allorché è quest'ultimo ad avere il sopravvento. Come nel caso dei palestinesi, o dei libanesi amanti della bella vita, incapaci di imporre le decisioni del governo centrale su falangi armate che non ne accettano l'autorità.
La guerra di Israele contro Hezbollah è giusta da un punto di vista morale. Noi israeliani non abbiamo alcun interesse a conquistare territori in Libano, non aspiriamo a rovesciarne il regime, non ci immischiamo nelle sue faccende interne, ne riconosciamo i confini storici, ne rispettiamo la sovranità e vogliamo mantenere con il suo governo rapporti di buon vicinato. Abbiamo però il diritto di difenderci con fermezza da rapimenti di soldati seguiti da lanci di missili. I miliziani di Hezbollah sanno benissimo che non riusciranno mai a distruggere Israele, nonostante i proclami della loro ideologia ufficiale. E i loro attacchi di missili non allevieranno in alcun modo le sofferenze dei palestinesi ma ne causeranno di nuove.
Ma anche quando si combatte una guerra giusta occorre mostrarsi saggi e sensati, stabilire obiettivi razionali e realistici e non aspirare a creare un "nuovo ordine" in Libano. Abbiamo visto cosa è successo a quello che abbiamo cercato di imporre durante la guerra del 1982 e vediamo cosa succede agli americani in Iraq. Noi israeliani non abbiamo nemmeno interesse a cancellare Hezbollah in quanto organizzazione economica e sociale della comunità sciita. Anche la liquidazione della sua attuale dirigenza non è diretto scopo di Israele. Non è corretto immischiarci negli affari interni di un popolo o di una comunità. Israele rimarrà vicino del Libano per l'eternità e dobbiamo quindi pensare al futuro. Non riusciremo a distruggere tutti i missili presenti in Libano e non abbiamo interesse a farlo. Dopo la tregua dovremo creare una zona cuscinetto che separi le nostre forze da quelle di Hezbollah, allontanare i miliziani venti chilometri dal confine, al di là del fiume Litani e naturalmente riportare a casa i due soldati rapiti, anche a prezzo della liberazione di alcuni prigionieri libanesi. Questi sono obiettivi reali e morali e per raggiungerli la comunità internazionale deve dare un aiuto concreto ai due popoli.
Oggigiorno l'Europa è unita in una comunità politica, economica e militare. Non c'è motivo che non invii nella regione una forza internazionale che goda della fiducia di libanesi e di israeliani e che serva da barriera di separazione tra noi e Hezbollah. Allo stesso modo è necessaria la partecipazione dell'esercito libanese in veste di forza ausiliaria. La massiccia presenza di alcuni battaglioni di soldati europei potrebbe riportare la calma e la serenità per parecchi anni. L'Europa gode di un periodo di tranquillità e di benessere, non è minacciata da guerre o conflitti etnici. È giunto il momento che contribuisca concretamente alla pace in Medio Oriente. Un suo intervento al confine tra Libano e Israele potrebbe essere un buon esempio per una simile iniziativa lungo i confini tra Israele e il futuro Stato palestinese. La pace in Medio Oriente non è meno importante dei festeggiamenti per i Mondiali di calcio.

 19 luglio 2006
19 luglio 2006
![]() 19 luglio 2006
19 luglio 2006