





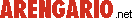
La settimana in rete
a cura di Primo Casalini - 8 gennaio 2006
Sinistra e capitalismo
Eugenio Scalfari su la Repubblica 8 gennaio
Sui risvolti politici della vicenda Unipol si è già scritto e detto quasi tutto, ma c'è ancora qualcosa da aggiungere in attesa che la Direzione Ds si pronunci l'11 gennaio.
Le questioni che secondo me meritano un chiarimento ulteriore sono almeno tre: quella della diversità della sinistra, quella del fuoco incrociato contro i Ds e, l'ultima, sulla emendabilità del capitalismo italiano. È inutile aggiungere che si tratta di tre questioni interamente intrecciate tra loro nel senso che ciascuna è concausa delle altre due. Insieme stanno e insieme cadono, sicché bisogna anche porsi la domanda se sia nell'interesse del paese risolverle o impedirne la soluzione.
Dico subito che a mio avviso è interesse della democrazia italiana che quelle tre questioni siano risolte e che la loro soluzione non passi attraverso il dissolvimento del gruppo dirigente diessino, anche se è vero che la responsabilità di uscire dal bunker in cui si è cacciato spetta principalmente ad esso (come del resto ha già cominciato a fare Piero Fassino, nell'intervista che pubblichiamo oggi sul nostro giornale).
* * *
A proposito della diversità della sinistra italiana citai la settimana scorsa il "lascito" di Enrico Berlinguer. Un lascito costruito dalla coerenza di tutta la sua azione di dirigente politico, volta a evitare il rischio dell'omologazione del suo partito. Berlinguer aveva misurato quel rischio attraverso l'esperienza fatta dai socialisti. Non solo nella fase craxiana, ma già dal centrosinistra di Nenni e di Giacomo Mancini. La resistenza dei socialisti all'omologazione restando saldi in una versione riformista che incidesse sulla realtà italiana durò poco più d'un anno, dall'autunno del 1962 al giugno del '63.
Fu la fase della nazionalizzazione dell'industria elettrica e della nominatività delle cedole e dei dividendi, ben presto caduta. La fase guidata da Riccardo Lombardi e da Antonio Giolitti nella breve esperienza della programmazione.
Quella fase ebbe termine con il "rumore di sciabole" del generale De Lorenzo, con l'intervento del ministro del Tesoro Emilio Colombo per una politica economica più rigida, con l'uscita di Giolitti dal ministero e l'emarginazione politica di Lombardi. Da allora la presenza politica del Psi si esaurì (con l'eccezione della legge Brodolini sulla giusta causa) nella "conquista" delle vicepresidenze negli enti pubblici di ogni genere e tipo, cioè nell'occupazione condominiale con la Dc delle caselle d'un potere che diventava rapidamente sempre più clientelare e partitocratico e sempre meno democratico e rappresentativo.
Poi arrivò Craxi e non fu più pioggerella ma grandine. La diversità berlingueriana aveva ben presente quell'esperienza e non voleva che si ripetesse. Non in quei modi. L'austerità berlingueriana era del resto un costume di tutto il partito, del gruppo dirigente, dei quadri, della base sociale in gran parte composta da operai, lavoratori dipendenti, braccianti, insomma proletari. E anche borghesia liberal-radicale.
Oggi la base sociale diessina è in parte cambiata, il partito attuale è, io dico per fortuna, molto diverso dal vecchio Pci, l'ideologismo rivoluzionario e massimalista non c'è più, la libertà è diventata un valore almeno pari ed anzi superiore a quello dell'eguaglianza.
Ma la moralità politica è rimasta. Di qui l'anti-berlusconismo. Volete chiamarlo viscerale? Chiamatelo pure così perché viene dalla visceralità della gente di sinistra.
Il presidente della Camera, Casini, ha dichiarato due giorni fa che non vuol più sentir parlare d'una superiorità morale della sinistra. Dal suo punto di vista ha mille ragioni, ma non si tratta di superiorità, bensì di diverso modo di sentire. Ne volete una prova? La gente di destra (e di centro) non è rimasta affatto scossa dalle notizie di denari passati dalla Popolare di Lodi nelle mani di alcuni autorevoli esponenti di Forza Italia, Udc, Lega, An.
Quelle notizie sono scivolate come gocce d'acqua su un vetro. Così pure per il ben più grave problema del conflitto d'interessi di Berlusconi.
Ma è invece bastato un sostegno "tifoso" e certamente impreveggente dei dirigenti Ds all'Unipol per scatenare una tempesta nella sinistra e nei giornali. Perché? Perché la sinistra non solo è diversa nella sua sensibilità morale, ma è considerata diversa anche da chi non è di sinistra. La sua diversità dovuta alle ragioni e alle motivazioni di appartenenza alle quali ho accennato, è dunque un dato di fatto.
Si può dire che è un dato di fatto negativo, un errore, un residuo ideologico. Si può dire qualunque cosa, ma resta un dato con il quale sia gli avversari sia soprattutto i dirigenti debbono fare i conti. Se non li fanno sono loro a sbagliare.
Voglio dire al presidente Casini che quel modo di sentire "diverso" rispetto ai temi della moralità pubblica, dell'austerità del vivere, dei valori della solidarietà e dell'eguaglianza, dovrebbero anche essere patrimonio dei cattolici. Di quelli veri e non di quelli che si fanno il "nomedelpadre" baciandosi le dita e poi crogiolandosi nel sistematico malaffare.
Ce ne sono pochi di cattolici veri e sono anch'essi diversi.
Mi rammarica perciò il disprezzo con cui il cattolico presidente della Camera parla dei diversi. Mi rammarica ma non mi stupisce. Non sempre i cattolici sono veri cristiani che rinunciano al potere per testimoniare la loro fede.
* * *
E vengo alla seconda questione: il fuoco incrociato contro i Ds. Scrissi la settimana scorsa che la dirigenza diessina ha commesso alcuni gravi errori. Si è volutamente impigliata in una difesa di Unipol e del milieu circostante a Consorte, offrendo occasione ad un attacco nei suoi confronti e nei confronti del suo partito. Da questi errori non si è ancora completamente districata ed è sommamente opportuno e urgente che se ne liberi.
Che il centrodestra in tutte le sue componenti ne abbia approfittato era nell'ordine delle cose e non può stupire. Fa parte della logica elettorale. Stupisce semmai l'impudenza con cui Berlusconi si è gettato in prima persona nella battaglia; stupisce che abbia potuto rivendicare, nell'indifferenza di gran parte della stampa, la sua estraneità alla mescolanza della politica con gli affari.
La fortuna di Berlusconi come imprenditore immobiliare prima e come concessionario di emittenti televisive poi è interamente legata a connivenze politiche; in particolare al legame strettissimo che ebbe con Bettino Craxi.
I decreti craxiani che sospesero l'applicazione esecutiva delle sentenze della Corte costituzionale in materia televisiva, non a caso furono chiamati decreti Berlusconi, primo e gravissimo esempio d'una legislazione "ad personam". Per non parlare della legge Mammì che sancì di fatto il duopolio Rai-Mediaset.
Alla fine, dal 1994, avemmo il gigantesco conflitto d'interessi che tuttora incombe sulla vita nazionale.
Ma se vogliamo restare al tema delle Opa tuttora in atto, è stupefacente che le pagine dei giornali e i resoconti delle tivù siano pieni di Unipol mentre è totale l'assenza delle implicazioni ben più gravi di autorevoli politici del Polo, sottosegretari, presidenti di commissioni parlamentari, a finire con lo stesso presidente del Consiglio significativamente presente in compromettenti intercettazioni.
Perché dunque tanto accanimento unilaterale al quale, lo ripeto, la dirigenza diessina ha colpevolmente offerto il destro? La risposta è semplice.
Esiste in certi settori della politica e della stampa una nostalgia di centrismo che trova come impedimento maggiore la presenza d'un forte partito Ds. L'occasione offerta dal caso Unipol è stata da questo punto di vista preziosa. Ma è preziosa anche per rinverdire la visibilità elettorale di quella sinistra radicale "pura e dura" cui sembra in certe occasioni star più a cuore l'interesse della "ditta" che quello del paese.
Qui non si tratta della diversità berlingueriana ma d'un massimalismo a buon mercato, velleitario quanto nocivo come tutti i massimalismi. Berlinguer, tanto per ricordare ancora una volta la lezione dell'ultimo vero segretario del Pci, fu nel suo partito il punto centrale dello schieramento interno, distinto e spesso in contrasto con la sinistra di Ingrao, con quella filosovietica di Cossutta, oltre che con il gruppo moderato di Napolitano.
Non darò - non ne avrei alcun titolo - giudizi di valore su queste diverse posizioni, ma ricordo appunto che Berlinguer rifuggì dal massimalismo e dall'estremismo come già prima di lui Longo e Togliatti.
In conclusione, si spara contro i Ds in nome del centrismo e dell'anti-riformismo. Questa è la verità del "fuoco incrociato".
* * *
Infine la terza questione, l'emendabilità del capitalismo italiano. Questo tema non è stato posto esplicitamente da nessuno con due eccezioni che mi piace citare: Alfredo Reichlin e Franco Debenedetti sulle pagine dell'Unità: due osservatori impegnati con biografie politiche assai diverse e tuttavia in consonanza su un tema di così grande rilievo.
Il capitalismo è stato modificato in modo sostanziale tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta, cioè prima e dopo il secondo conflitto mondiale, dal pensiero di Keynes, dall'azione politica di Roosevelt e da quella successiva di Beveridge in Gran Bretagna e della socialdemocrazia in Germania.
Cioè dal pensiero e dalla pratica liberale e socialista abbinate alla forza del movimento sindacale. Questo assetto ha configurato il capitalismo nella seconda metà del XX secolo accrescendo benessere e piena occupazione.
Da un paio di decenni questa fase si è chiusa; la globalizzazione, l'informatica, la finanziarizzazione dell'economia hanno posto problemi nuovi tra i quali predominano la riforma del mercato del lavoro, la riforma del "welfare" e, soprattutto, la riforma dell'offerta di beni e servizi a cominciare dalla riorganizzazione dei mercati finanziari e delle società che vi operano.
Illudersi che una delle alternative a questa riorganizzazione sia il settore delle imprese cooperative è un grave errore di prospettiva. La cooperazione rappresenta un modello diverso di organizzazione dei consumi e del lavoro, non già un'alternativa al capitalismo. Merita di espandersi ma senza farsi "contaminare". Se non vuole scomparire e essere assorbita e omologata deve restare nel settore "non profit" che costituisce la sua forza e il suo limite.
Un grande partito riformista deve invece porsi il tema di stimolare la riforma dell'offerta, che riguarda la struttura societaria delle imprese capitalistiche, le piccole, le medie, le grandi e grandissime. Il fisco sulle imprese. L'accesso al credito e alla Borsa. Gli intrecci tra banche e imprese.
Gli organi di controllo esterni e interni alle imprese. La dimensione delle imprese. L'internazionalizzazione e soprattutto l'europeizzazione delle imprese. Ci sono nel capitalismo italiano forze consapevoli di questa necessità evolutiva del sistema e forze che vi si oppongono. Ma una cosa è certa: il sistema da solo non riuscirà a riformarsi. Lo stimolo politico gli è indispensabile come lo fu per arrivare alla fase denominata "mercato sociale" e "welfare".
Sono dunque tre questioni in una, come abbiamo indicato all'inizio. E ad esse bisognerà porre energicamente mano quando la nottata berlusconiana sarà finalmente passata.
Una stagione di pace lampo
Gianni Riotta sul Corriere della Sera 8 gennaio
La storia vola. La guerra fredda durò dal 1946 al 1989 e, come scrive John Lewis Gaddis nel nuovissimo saggio The cold war: a new history, smentì le cupe previsioni di Orwell sul trionfo del totalitarismo, promuovendo «democrazia globale e speranza». Fu la breve stagione del «nuovo ordine mondiale» sognato da Bush padre, Gorbaciov, Clinton, guerra ai despoti con Onu e Nato, prima Saddam, poi Milosevic. Finì l'11 settembre 2001, quando bin Laden distrusse i sogni di pace e l'Occidente si divise, insieme a Kabul, lacerato a Bagdad. Ariel Sharon, il generale e premier israeliano più amato e detestato, comprende per primo come la coalizione alleata a Bagdad cambi il mondo. Liberato dal nemico giurato Saddam Hussein, Sharon ordina il ritiro unilaterale da Gaza, svelando paralisi palestinese, tra corruzione e inanità dell'Olp, durezza di Hamas e anarchia delle gangs, e umori profondi di Israele: pace e sicurezza, insieme, per sempre.
«Arik» Sharon lotta tra la vita e la morte e le sue gesta, dalla gloria di guerra e pace alla polvere della Commissione d'inchiesta sulle stragi di Sabra e Chatila, trasmigrano dalle prime pagine ai libri di storia. Con lui se ne va la stagione, contratta, seguita all'11 settembre, e si apre l'era della guerra senza limiti, l'arma energia imbracciata da Putin, la Cina che si sgancia da Re Dollaro, gli americani che addestrano l'ex nemico Vietnam, aprendo con la Intel una fabbrica di microprocessori dove prima bruciava il napalm. La nuova sfida è Usa-Cina, con Ue e Russia ai bordi del campo.
Dalla sua vita di ufficiale carrista, lodata per il blitzkrieg contro gli egiziani nel 1973 e deprecata per le stragi dello squadrone «101», Sharon importa in politica l'idea che la tattica sia la sola strategia. Inutile imbarcarsi in defatiganti trattative con i palestinesi, pronubi Usa e Ue, meglio blindare Israele dietro un muro di protezione e ritirarsi dalle zone occupate, prima Gaza poi il West Bank, lasciandone infine l'85%. Dalla guerra lampo alla pace lampo. Generazioni di fallimenti e sangue hanno avviluppato in groviglio il nodo Medio Oriente. Sharon lo recide con la spada, come Alessandro Magno a Gordio: perfino i suoi avversari devono riconoscergli risolutezza. Con il vecchio guerriero abbattuto sul campo, come la sua nemesi, il generale statista Rabin, Israele vede con sgomento riaprirsi il labirinto della trattativa faticosa e incerta, mentre nessuno dei leader, Olmert, Netanyahu, il Barak che si dichiara al Corriere « sharoniano», il decano laburista Peres e il neofita Peretz, sa parlare di pace e sicurezza con la rassicurante grinta di Sharon.
Il presidente Bush è al tramonto del mandato, i palestinesi confusi e gli israeliani smarriti, le elezioni vicine: difficile prevedere progressi. Si negozierà, si combatterà, si perderanno tempo e sangue. A meno di non ricordarsi che nel post 11 settembre la storia facit saltus progredendo per strappi improvvisi. Sarebbe la migliore novità se fosse l'Unione Europea, ora che si riparlerà di road map e trattativa, a lanciare dei blitz diplomatici, buttando via posizioni obsolete e spazzando il campo con offerte radicali e garanzie dure di pace e sicurezza. Ritirandosi dalla Gaza intellettuale del passato, riconoscendo che i confini del 1967 non sono dogmi e che è possibile ripetere lo sgombero di Sharon anche da gran parte del West Bank, disarmando i terroristi, imbrigliando Hamas e gli estremisti ortodossi. La pace richiede audacia e sarebbe meraviglioso, e inatteso, se fossero finalmente gli europei a dimostrarla.
Fassino: “La Quercia è sana”
Massimo Giannini su la Repubblica 8 gennaio
ROMA - «Sono certamente giorni amari. Forse i più amari della mia vita politica...». Chiuso nel suo ufficio a Via Nazionale, Piero Fassino respinge colpo su colpo le accuse e i sospetti sullo scandalo di Bankopoli. E grida forte il suo «non ci sto». «C´è una campagna di aggressione indecente nei nostri confronti – esordisce il segretario dei Ds – e a 90 giorni dal voto il tentativo della destra è chiarissimo. Far dimenticare 5 anni di un governo fallimentare. Occultare le responsabilità di una maggioranza coinvolta anche nello scandalo Fiorani. Delegittimare il centrosinistra, infangando il suo principale partito. Non a caso chi guida la campagna è il "Giornale", di proprietà della famiglia Berlusconi. Lo stesso quotidiano che nel 2004 fece una vergognosa campagna su Telekom Serbia, scrivendo di conti segreti di Fassino, Prodi e Dini presso una banca austriaca. Attendo ancora le scuse. Ora adottano la stessa tecnica: provano a dimostrare che anche noi abbiamo le mani impastate con soldi loschi».
Non saranno soldi loschi, onorevole Fassino, ma qualche relazione pericolosa l´avete tessuta anche voi attraverso Consorte, no?
«Stiamo ai fatti, per favore. Per dimostrare l´indimostrabile hanno fatto ricorso a qualsiasi menzogna, chiamando in causa con riferimenti falsi prima Bersani e Visco, poi Sposetti (che ha la sola colpa di aver risanato in modo trasparente i conti dei Ds), e infine D´Alema con una provocazione indecente sul leasing per la barca. Si scrive ogni giorno che i conti esteri di Consorte in realtà sono la fonte di finanziamento ai Ds, una vera e propria calunnia di cui chiameremo in tribunale a rispondere chi l´ha scritto e continua a scriverlo. Alla fine di questa sequenza vergognosa c´è Fassino. Viene considerato una persona perbene, anche se ha un brutto carattere. E allora bisogna sporcarlo, bisogna tagliargli la faccia... «.
Segretario, lei è in piena sindrome da complotto.
«No, io questa parola non la uso e non l´ho usata mai. Ma c´è un´aggressione, questa sì. Ed è un´aggressione violenta, fondata sull´odio: pur di non perdere le elezioni, sono disposti ad uccidere l´avversario politico. Così si travolge non solo un partito, ma una democrazia, si stravolgono le normali regole di convivenza civile. Negli anni '50 lo scontro tra Dc e Pci fu durissimo. Ma a De Gasperi e a Togliatti non è mai venuto in mente di scambiarsi la reciproca accusa di essere ladri. Per questo. oggi, io dico "no, noi non ci stiamo". Non ci stiamo a sentir parlare di Tangentopoli, perché qui di tangenti non ce ne sono, quanto meno non ce ne sono ai Ds. Non ci sono soldi occulti. Noi non abbiamo conti in Svizzera, non li ha il nostro partito, non li ha nessuno di noi».
Quindi secondo lei il suo partito non ha nulla da rimproverarsi? Questo vuol dire?
«Io voglio dire che questo non è un partito marcio. Errori possiamo commetterne, perché siamo uomini in carne ed ossa, e nessuno di noi, tanto meno io, ha l´idea dell´infallibilità. Discutiamo pure degli errori. Ma deve essere chiaro che noi non accettiamo nessuna campagna di delegittimazione morale e politica».
E allora discutiamone, di questi «errori». La sua telefonata con Consorte è stata un errore?
«Proprio quella telefonata (pubblicata in modo illegale, visto che in America, per molto meno, Nixon è arrivato all´impeachment) conferma la assoluta mia buona fede. La notizia di questa conversazione era già venuta fuori in estate. Tanto che Scalfari, in un bell´articolo del 14 agosto, chiese direttamente a me: che cosa si sono detti Fassino e Consorte? Io, il giorno dopo, scrissi una lettera a Repubblica, nella quale riferivo: "A Consorte non ho chiesto niente di più che semplici informazioni sul carattere dell´operazione Bnl". Cinque mesi dopo, la lettura dell´intercettazione telefonica conferma quanto io sia stato sincero allora: mi sono limitato a chiedere notizie a Consorte, tra l´altro su fatti già avvenuti. Non c´è stata da parte mia una sola parola sulle scelte future dell´Unipol. E´ stata una pura telefonata informativa».
Proprio questo è il problema. Perché il partito si informa su come va un affare di una società quotata in Borsa?
«Perché tutto quello che succede oggi dimostra che quelle vicende non avevano solo un rilievo bancario, ma avevano anche politico, come dimostrano i veleni di questi giorni. Quindi, allora, era del tutto ovvio che il segretario del principale partito si informasse su cosa succedeva. E poi c´è un altro aspetto: io ho chiesto informazioni a Consorte, ma non si troverà mai una mia telefonata a Fazio, a Fiorani, a Caltagirone, a Ricucci. Il che conferma che non c´è stata nessuna forma di interferenza da parte mia. Perché in questo caso sì, il mio comportamento sarebbe censurabile. Ma questo non è accaduto».
D´accordo. Però c´è stato, da parte sua, un eccesso di «partecipazione». Perché dire «abbiamo comprato una banca»?
«Chiariamo anche questo, una volta per tutte. Io ho sempre rivendicato, per il movimento cooperativo, non privilegi ma uguali diritti e uguali opportunità rispetto a qualsiasi altra impresa. Ezio Mauro, in un articolo di tre giorni fa, ha scritto: "Vogliamo essere sicuri che i Ds non pensino che il movimento cooperativo debba essere il figlio di un dio maggiore, protetto e benedetto da una grande forza politica". Io sono perfettamente d´accordo. E infatti ho sempre chiesto che il movimento cooperativo non venga considerato figlio di un dio minore. E non l´ho fatto per un interesse personale dei Ds, come si vuol fare credere. L´ho fatto perché parto dall´idea che il movimento cooperativo è un pezzo molto importante dell´economia italiana. Sulle prime 100 aziende per fatturato, 30 sono imprese cooperative. La stessa Unipol è diventata, diretta da Consorte e non da altri, la terza assicurazione del Paese».
Nessuno mette in discussione il diritto a competere delle coop.
«Lo dice lei. Si vada a rileggere le parole del presidente della Confindustria Montezemolo, che ad agosto ha dichiarato "cosa c´entrano le coop con le banche? Si occupino dei supermercati...". Bene, questa frase è la dimostrazione di un fastidio. Le imprese cooperative vengono considerate come "intrusi". E io a questo non ci sto. Per questo rivendico il mio diritto ad aver fatto il "tifo". In un mondo di furbi, io preferisco essere tifoso che cinico. E comunque, se tutto questo pandemonio contro i Ds deriva dal fatto che ho tifato, allora per tagliarla corta dico: bene, ammetto la mia "responsabilità". Ho tifato. E se questo è stato fonte di equivoco me ne rammarico. Ma adesso, per favore, la piantiamo lì?».
Non prima di aver speso una parola su Consorte. Perché non riuscite a prendere fino in fondo le distanze da questo manager?
«Su questo certo occorre fare una riflessione. Sono emersi fatti sui quali non possiamo chiudere gli occhi: conti esteri, con depositi illeciti che poi sono stati condonati con lo scudo fiscale di Tremonti, consulenze equivoche, alleanze discutibili, commistione tra interessi privati e interessi societari. Non spetta a me pronunciarmi sul profilo giudiziario di questi comportamenti, ma alla magistratura. Mi auguro che Consorte dimostri l´assoluta liceità di tutto questo. Ma una cosa la voglio dire con chiarezza: non c´è dubbio che questi sono comportamenti del tutto estranei ai nostri valori e alla nostra storia. Tanto più per chi opera in un´organizzazione come il movimento cooperativo, che nasce e vive per affermare finalità solidaristiche. Nessuna società vive senza etica. Per noi questa è una regola irrinunciabile. E quando viene violata il nostro giudizio non può che essere severo e netto, e la presa di distanza assoluta».
Permette, segretario? Finalmente una parola chiara. Ma adesso, come ha detto Prodi, il problema è riscrivere le regole per evitare che certi errori si ripetano.
«Infatti, di questo dobbiamo discutere, e chiederci per quale ragione si sia allentata la capacità da parte di tutti, e anche nelle nostre file, di far prevalere quei principi etici e quel rigore che sono essenziali perché una società possa vivere. Questa questione chiama in campo temi molto più complessi. Per esempio, un primo tema è: qual è oggi il rapporto che siamo capaci di stabilire tra il solidarismo, che ispira la nascita e la vita di un´impresa cooperativa, e un mercato con cui ormai anche la cooperazione deve fare i conti? Qui c´è stato e c´è un deficit di riflessione di tutta la sinistra».
Poi c´è il tema del collateralismo, caro a Rutelli.
«Guardi, il collateralismo è finito da anni. Più attuale, invece, è secondo me il tema della governance. Le vicende di questi mesi hanno fatto emergere un puzzle di incroci, patti, contropatti, concertazioni. Tutto questo non l´ha inventato solo Consorte. E allora mi chiedo: non è forse questa una patologia che rischia di intaccare il capitalismo italiano? Non c´è qualcosa di sbagliato nel fatto che ormai spesso basta comperare il 2% di una società per controllarla? Che i patti di sindacato sono sempre di più dei circoli chiusi impenetrabili? Vogliamo affrontare il nodo del rapporto tra banche e imprese? Vogliamo risolvere seriamente il rapporto tra privatizzazioni e liberalizzazioni, visto che in questi anni, come dimostrano i casi di Enel e Telecom, abbiamo creato monopoli o oligopoli di tipo privatistico non dissimili da quelli pubblici, con un intreccio con il potere politico e istituzionale analogo. Se questi sono i nodi, qui c´è una responsabilità di tutti: di chi governa e di chi è all´opposizione, di chi è impresa e di chi è politica».
Per la politica c´è una responsabilità in più. E in questo voi avete palesato qualche difficoltà a gestire il rapporto con l´establishment.
«Sono assolutamente convinto, e non da oggi, che i comportamenti di chi ha una responsabilità pubblica non possono essere determinati solo dal rispetto della legge, ma anche da principi deontologici e da valori morali. Servono strumenti per sostenere tutto questo? Benissimo, diamoceli. Per esempio, propongo per la prossima legislatura il varo di un codice etico del parlamentare. E alla direzione del mio partito, mercoledì prossimo, proporrò la nomina di un´autorità di garanzia di 5 personalità neutrali, a cui sottoporre ogni anno il nostro bilancio e ogni nostra attività finanziaria. Spero che anche gli altri partiti facciano altrettanto».
C´è un altro sospetto, che aleggia intorno alla Quercia. Fassino e D´Alema, ormai, hanno due linee diverse. Nega anche questo?
«Certo che lo nego. È un´altra delle tante cattiverie e dei tanti tentativi di dividerci e di seminare zizzania tra noi. Al di là della differenza di carattere, che per altro di entrambi non è il migliore, il rapporto tra me e D´Alema è solido e saldo, perché c´è una condivisione politica e una storia personale comune. Ripeto quello che dissi concludendo la conferenza programmatica di Firenze: noi non ci divideremo e non ci faremo dividere».
Eppure, da Pansa ai girotondi c´è chi chiede a lei e a D´Alema di fare un passo indietro.
«Veniamo da quattro anni di successi elettorali. E adesso abbiamo la possibilità di mandare a casa Berlusconi: una cosa impensabile nel 2001. Tra tre mesi si vota: adesso a ognuno di noi è richiesto di stare in campo per vincere. E, in ogni caso, chi mi conosce sa che in 35 anni di responsabilità politiche non sono mai stato incollato alle sedie su cui ero seduto».
Insomma, Fassino al contrattacco. Ma basterà a calmare le acque, in vista della direzione dell´11 gennaio?
«Non sono arroccato in nessun bunker. In direzione discuteremo in modo libero e aperto, come sempre accade nel nostro partito, e sono sicuro che con il contributo di tutti invieremo un messaggio forte al Paese. E anche adesso voglio rivolgermi ai nostri alleati e alla nostra gente. Ai nostri alleati dico: ho apprezzato la misura con cui molti si sono espressi in queste settimane. E li ringrazio. Ma a loro vorrei ricordare che questo è anche un interesse comune, perché chi in questo momento attacca i Ds vuole mettere in crisi l´intera alleanza. E infine voglio dire alla nostra gente: colgo tutta l´ansia di cui è pervasa. Ma voglio dire ai nostri elettori e agli italiani: siate sicuri, noi siamo gente perbene».
Non tutti ne sembrano convinti, se siamo arrivati al punto di rievocare Berlinguer e la «questione morale».
«La lezione morale e politica di Berlinguer vive in noi ogni giorno. Per i comportamenti che abbiamo, per l´idea della politica che abbiamo, per come la viviamo tutti i giorni, per come cerchiamo tutti i giorni di servire il nostro paese. L´obiettivo di dar vita a un grande partito riformista e democratico in Italia non è, neanche per un istante, uno smarrimento della nostra identità, dei nostri valori, del nostro rigore, della nostra tensione morale. Io posso guardare negli occhi qualsiasi italiano. E noi tutti possiamo continuare a combattere a testa alta, perché chi vuole travolgerci non passi. E perché tra 90 giorni si raggiunga quell´esito elettorale per cui abbiamo lavorato con passione e fatica in questi lunghi 5 anni».
In un mondo senza senso
Umberto Galimberti su la Repubblica 6 gennaio
Questioni di fede è un gran bel libro scritto da Peter Berger, direttore dell´Istituto On Religion And World Affairs dell´Università di Boston, oggi disponibile in italiano (Il Mulino, pagg. 270 euro 15). Un gran bel libro, dicevo, molto ingannevole, che tenta di dimostrare che anche da laici, anche da scettici, anche senza sentirsi vincolati da nessuna delle tradizionali autorità in materia di fede, come nel caso dell´autore, si può scegliere o addirittura abbracciare il cristianesimo, non in quelle modalità «generiche» o «personalizzate» che papa Ratzinger ha di recente condannato, ma aderendo riga per riga a tutti gli articoli del «Credo» che i cristiani professano.
Ridotta all´osso, l´argomentazione così procede: oggi la fede non può più essere data per scontata, perché la modernità, con i suoi processi di migrazione, comunicazioni di massa, urbanizzazione mina quella forma di consenso sociale omogeneo che è il vero fondamento dell´autoevidenza di una fede. Spinto a confrontarsi in maniera sempre crescente con credenze, valori, stili di vita assai differenti, l´individuo non può più dare la sua fede per scontata, ma è costretto a sceglierla. E la scelta, anche quella di non credere, richiede un minimo di riflessione e quindi una forma anche rudimentale di pensiero teologico.
In una parola la modernità problematizza, perché se mi affido alla Chiesa e metto la mia fede al riparo della sua infallibilità, ci sono le scienze storico-sociali che mi dimostrano quante volte la Chiesa ha fallito, se mi affido alla Bibbia, come fanno i protestanti, c´è l´erudizione critica e la competenza scientifica che mi fanno vedere quanti errori sono contenuti nel Libro, se mi affido all´esperienza interiore che mi avvia verso sentieri mistici difficilmente sfuggo alle osservazioni che mi possono giungere dalle scoperte della psicologia.
Qualunque sia il percorso che scelgo, osserva Berger, incontro in ogni caso «il silenzio di Dio, della cui assenza soffro». Perché? chiedo io. Perché, risponde Berger: «Senza una realtà che trascende quella ordinaria della vita quotidiana, non riesco a reperire un senso alla mia vita e alla realtà che mi circonda. La religione non è altro, in definitiva, che questo reperimento di senso».
Vero. Ma proprio perché è vero, tutto il discorso crolla irrimediabilmente, perché, se la ricerca di senso è il tratto tipico della dimensione religiosa, devo essere già religioso per pormi il problema del senso che, altrimenti, come nel mio caso, non si affaccerebbe neppure lontanamente alla soglia dei miei pensieri.
La figura del «senso» nasce infatti all´interno della tradizione giudaico-cristiana, dove il tempo non è più pensato, alla maniera degli antichi greci, come un «ciclo» che, al suo compiersi, ritorna su se stesso (inverno, primavera, estate, autunno e poi di nuovo il ritorno delle stesse scansioni temporali), ma è pensato come iscritto in un disegno (di redenzione, di salvezza), dove alla fine si adempie ciò che all´inizio era stato annunciato. Quando il tempo è iscritto in un disegno, nasce la «storia» che è un tempo fornito di senso. Da dove nasce infatti la storia se non dalla persuasione di un primato del fine sulla fine, per cui lo scorrere del tempo ha una direzione, uno scopo, e quindi un «senso»?
La storia nasce quindi come «storia religiosa» e tutti quelli che vi partecipano (in pratica tutti noi occidentali che, per il fatto di essere cresciuti nella tradizione giudaico-cristiana, come ci ricorda Benedetto Croce: «Non possiamo non dirci cristiani») sono convinti che il tempo abbia un senso. E questa convinzione dura ha permeato a tal punto la nostra psicologia che anche i processi di secolarizzazione, che hanno in gran parte scristianizzato l´Occidente, in realtà si sono limitati a sostituire i contenuti di senso, senza minimamente dubitare che il tempo avesse un «senso», e quindi fosse «storia».
Così pensa la scienza quando legge se stessa iscritta nella figura del «progresso», dove il tempo è raggiungimento di certe conquiste e anticipazione di conquiste future, e dove la salvezza religiosa si materializza nella crescita eretta a senso della storia. Così pensa l´utopia, che riformula la triade religiosa: colpa, redenzione, salvezza in quell´omologa prospettiva in cui il passato appare come male, il presente come redenzione e il futuro come salvezza. Così pensa la rivoluzione, che prevede il rovesciamento del dominio del male nel dominio del bene, segnando quell´accelerazione del tempo verso la fine, per l´irruzione dell´elemento salvifico e risolutore.
Solo la tecnica, come universo di mezzi che non ha in vista alcun fine, ma solo i risultati delle sue procedure, che procedono unicamente in vista del loro potenziamento, abolisce ogni orizzonte di senso, e riconduce la figura del «senso» alla sua verità, che è poi quella di essere il prodotto della visione che l´uomo s´è fatta del mondo. Una visione antropologicamente limitata, che affonda le sue radici nell´antropologia dell´Antico Testamento, dove nel Genesi è scritto che tutte le cose sono state fatte per l´uomo, e quindi hanno senso solo in riferimento a lui, fatto a sua volta a immagine e somiglianza di Dio.
Noi oggi non viviamo più nella «natura» scandita dal tempo ciclico che, nella sua ripetizione, non ospita alcun senso, ma non viviamo più neppure nella «storia», perché non possiamo chiamare «storico» un tempo senza direzione. Noi viviamo nella pura accelerazione del tempo, scandita non dai progetti umani, ma dagli sviluppi tecnici che, consumando con crescente rapidità il presente, tolgono anche al futuro il suo significato prospettico, quindi il suo «senso». Non si può infatti parlare di «senso» di fronte a un processo evolutivo che si definisce tale solo in riferimento agli stadi precedenti, senza alcuna prospettiva rivolta, non dico a un «regno dei fini» come voleva Kant, ma almeno a un orizzonte di significato che non sia il puro e semplice sviluppo tecnico.
Fin qui le mie considerazioni, ma Peter Berger mi provoca con una citazione di Simone Weil che nell´Attesa di Dio, scrive: «L´incredulo è come il bambino che non sa che c´è del pane da qualche parte, ma comunque grida di avere fame. Il pericolo consiste non nel fatto che l´anima dubiti se il pane c´è o no, ma che si persuada con una menzogna di non avere fame. Può persuadersene soltanto con una menzogna, perché la realtà della sua fame non è una credenza, ma una certezza».
Sono d´accordo, ma allora diciamolo che il senso è come la fame che si avverte non quando si è sazi, ma quando manca il cibo. E´ l´esperienza del negativo a promuovere la ricerca di senso, è la malattia, il dolore, non la felicità, sul cui senso nessuno si è mai posto domande. Lamentare la mancanza di senso significa allora lamentarsi del dolore, della malattia, della morte, per cui «senso» è una parola nobile che nasconde solo il rifiuto da parte dell´uomo dell´esperienza del negativo, la non accettazione della propria finitezza, del proprio limite, a cui la teologia risponde rinviando all´essenza creaturale e perciò finita dell´uomo, mentre l´ateismo risponde in termini di scienza e di tecnica pensate come rimedio al negativo. In entrambi i casi è l´esperienza del negativo a promuovere la domanda intorno al senso, che dunque ha una matrice del tutto antropologica, e per giunta limitata al tipo umano cresciuto nella tradizione giudaico-cristiana, anche se la domanda di senso viene poi estesa e dilatata fino ai confini dell´essere.
Conclusione: se è vero, come scrive Peter Berger, che la ricerca di senso porta inevitabilmente ad ammettere una realtà trascendente, è altrettanto vero che questa domanda sorge solo in chi è già inserito in una tradizione religiosa che gli ha insegnato che il tempo è iscritto in un disegno e quindi è gravido di senso. Per questo dico che il libro di Berger è bello da leggere, persuasivo nelle sue argomentazioni, ma, siccome poggia su questo circolo vizioso che per intero lo percorre, è, per dirlo con simpatia, «privo di senso».
E tuttavia istruttivo, perché almeno a me fa capire che la tradizione giudaico-cristiana, per avere educato l´umanità occidentale alla ricerca di senso, ha inflitto a questa umanità una terribile sofferenza che è l´irreperibilità di un senso nell´età della tecnica. La tecnica, infatti, non tende a uno scopo che non sia il proprio autopotenziamento, non apre scenari di salvezza, non redime, non svela la verità, non promuove un senso, semplicemente «funziona», e siccome il suo funzionamento, in procinto di diventare planetario, subordina a sé tutti gli scopi, non c´è luogo in cui un orizzonte di senso sia reperibile.
Accade allora che tutti noi (atei compresi) educati come siamo dalla tradizione giudaico-cristiana alla ricerca di senso, ci troviamo oggi in quella tragica condizione dove la domanda di senso è irrinunciabile e tuttavia non è promossa, come nell´età pre-tecnologica dal «senso della sofferenza», ma - e questa è un´enorme differenza - dal senso stesso dell´esistenza che, nell´età della tecnica, non ci appare priva di senso solo perché è tormentata dalla sofferenza, ma al contrario appare «insopportabile» perché priva di senso. Questo è un dolore aggiunto, un dolore del tutto evitabile se la cultura in cui siamo cresciuti non ci avesse educato alla ricerca di senso, persuadendoci che il tempo è iscritto in un disegno, e quindi è storia fornita di senso, da reperire in questo mondo o in un altro mondo.
E siccome questo mondo di senso non ne offre un granché, avanti con la fede, quando invece la malattia si radica nella presunzione dell´uomo che crede che il mondo sia stato creato per lui, secondo un disegno che, non essendo molto visibile nei suoi contorni, esige fede.
Un treno in panne. Si ferma mezza Italia
Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera 8 gennaio
Unica eventualità esclusa: arrivare in orario. Per il resto, prendere un treno italiano significa entrare in quella che Umberto Eco chiama l'«infinita vertigine dei possibili». Non solo banali scontri e ovvi deragliamenti; può accadere anche di correre per 170 chilometri su un treno fantasma senza macchinista (da Longobardi, Calabria, a Rutino, Campania; 15 ottobre 2004).
E poi: dover scendere da un vagone in fiamme o bloccato da rami caduti sotto il peso della neve (Milano-Varese, 3 dicembre 2005), essere morsi da una zecca (Terni-Milano, 5 settembre), prendere le cimici (Genova-La Spezia, 7 ottobre), essere punti da uno scorpione (Morbegno-Milano, 19 dicembre). Le Fs, che adesso si chiamano Trenitalia, hanno più fantasia di Jorge da Burgos l'assassino del Nome della Rosa , che oltretutto non rideva mai. «Andate a trovare lo zio a Matera» dice invece, burlone, l'ultimo spot delle ferrovie. Lo zio forse sì, ma la stazione certo a Matera non esiste.
Il Paese che litiga sull'alta velocità non riesce a portare i pellegrini a Loreto; anzi, blocca la linea adriatica fermando una decina di convogli e dividendo la penisola. Nel mese in cui partiti e intellettuali si azzuffavano sul supertreno Lisbona-Kiev, ogni giorno in Lombardia 60 mila pendolari arrivavano in ritardo al lavoro per colpa degli accelerati da Busto Arsizio o da Codogno. È un'Italia non solo sempre in ritardo ma anche poco rispettosa di se stessa, della sua gente, della sterminata provincia su cui si regge e a cui da decenni sotto ogni regime non riesce a dare un servizio ferroviario decente. La regola vale per le piccole tratte come per le grandi: se l'asse Nord-Sud tra mille disagi è ormai quasi completato, almeno fino a Napoli, l'asse Est-Ovest langue da oltre un secolo. Liberali e fascisti, democristiani e socialisti, berlusconiani e ulivisti: niente da fare, tra Torino e Milano o tra Milano e Venezia ci si impiega come ai tempi di Giolitti.
Di tanto in tanto, a scuotere il disservizio quotidiano, la tragedia. Anche il 7 gennaio dell'anno scorso fu un giorno nero per le ferrovie. Diciassette morti a Crevalcore, sulla linea a binario unico Bologna-Verona («sarà raddoppiata per i Mondiali di calcio del 1990!» fu l'annuncio), a causa di un semaforo rosso non visto nella nebbia. Se sulle linee ad alta velocità e su quelle considerate più importanti è in vigore il blocco automatico a correnti codificate, che ferma automaticamente il treno se il macchinista non risponde alla duplicazione in cabina dei segnali presenti lungo la ferrovia, sulle altre tratte è in funzione il sistema Vacma - ribattezzato dai ferrovieri per la sua affidabilità «Uomo morto» -, che si limita a chiedere al macchinista delle operazioni di tanto in tanto; in caso di errore, il sistema non può intervenire. Nel 2004 gli scontri mortali erano stati tre. Il 2005 si è chiuso con l'incidente di Roccasecca, alle porte di Roma. Quello stesso 20 dicembre, il treno che portava i pendolari da Voghera a Milano è arrivato con 53 minuti di ritardo; quello che li riportava da Milano a Varese era invece in ritardo di 87 minuti. A Natale poi è accaduto di tutto. Nel periodo più intenso dell'anno sono state messe fuori servizio 508 carrozze su 8 mila. Treni più corti per le feste. E mille passeggeri hanno scoperto in loco che il vagone indicato sul loro biglietto era in manutenzione straordinaria. La protesta ha assunto forme spontanee tipo gruppuscolo maoista anni Settanta. Hanno cominciato i centomila pendolari liguri, con lo sciopero del biglietto. Quelli emiliani hanno proclamato una forma più evoluta, lo sciopero della lumaca: il biglietto si compra, ma si perde più tempo possibile al momento di tirarlo fuori per il controllo. Ma l'epicentro dei disagi e della rivolta resta la Lombardia, dove i pendolari studiano per gennaio uno sciopero comune con i ferrovieri.
Almeno questo è palese: non è colpa loro. Erano 220 mila nei dissipati anni Ottanta, ora sono meno della metà. Hanno dovuto reinventarsi il mestiere. Paolo Cinti, il ferroviere alla guida del convoglio di Crevalcore, era un capotreno e non un macchinista. Sulle Ferrovie gli ultimi governi hanno tenuto una politica quanto meno contraddittoria. Prima investendo intelligenze manageriali e denari - Cimoli e Catania; 10 miliardi di euro per l'alta velocità, un'altra decina di miliardi tra ricapitalizzazione e contributi per i contratti di programma solo nel biennio 2001-2002 -. Poi impugnando la scure. Lunardi, ministro dei trasporti e dei trafori, non ha l'aria di considerare le vie ferrate una priorità. La Finanziaria taglia a Trenitalia 640 milioni di euro. E per volontà dell'azionista, il ministero dell'Economia, le tariffe sono ferme da cinque anni. I treni italiani costano la metà di quelli tedeschi e francesi; il servizio è conseguente. Dopo la gaffe dello zio di Matera, il presidente Catania se non altro ha reagito da uomo di spirito: «La pubblicità deve sempre stupire». Ma, più che dai suoi spot, è dai suoi treni che ci si attende di tutto.
Divisi si vince
Andrea Colombo su il Manifesto 7 gennaio
La «pace» siglata al telefono da Romano Prodi e Massimo D'Alema è un cerottino piazzato là di fretta per nascondere la ferita aperta più che per provare a curarla. Anche solo riuscire a impecettare alla meno peggio la lacerazione tra Quercia e Margherita è stato duro. I generalissimi, con l'aggiunta di Fassino e Rutelli a completare il quadro di comando, hanno dovuto sudare per ore. Ce l'hanno fatta solo perché obbligati a limitare l'incasso di Silvio Berlusconi, il miracolato di Unipol. La finzione dell'unità in progress tra Quercia e Margherita si è sgretolata sotto i colpi degli scandali bancari. Ma non sono state le intercettazioni, né l'«inopportunità politica» di cui l'ex demitiano Prodi, disinvolto, accusa i Ds, a far crollare la fragile baracca. Diluvia sul bagnato. L'unità tra Quercia e Margherita è sempre stata una barzelletta buona tutt'alpiù per assecondare gli elettori di sinistra, che considerano l'unità un valore in sé. Per il resto, gli unitari hanno iniziato a sbranarsi sin dalla vigilia per la ripartizione di seggi e candidature.
Nel merito, avranno pure idee simili, ma le sfumature contano. Al punto che se l'Unione non riesce a partorire uno straccio di programma da presentare fra pochi mesi al popolo votante, lo si deve più alla necessità di non turbare gli equilibri tra i partiti unificati nel listone che a quella di non litigare con un Bertinotti peraltro mansuetissimo. Anche troppo.
Posticcia nel presente, la lista unitaria lo è ancora di più in futura proiezione. Dovrebbe essere il nucleo d'acciaio di un partitone democratico che tutti sono pronti a sventolare ma che solo Prodi, il senzapartito, vuole davvero. La Quercia se ne dichiara sostenitrice ardente, ma non al punto di unificare le liste anche al senato. L'unità non si discute, ma ci dovrà pure essere una sede in cui contarsi e verificare, voti alla mano, chi pesa di più e merita pertanto più potere. Quanto a Rutelli, la conversione da un'esagerata ostilità a una infatuazione altrettanto fuori dalle righe per il partito democratico è stata più repentina di quella di san Paolo. Già era sospetta: la recente rissa sui rapporti fra cooperative bianche e rosse, la rende ancor più dubbia.
Far finta di nulla, negare l'evidenza, portare in campagna elettorale il cadavere giurando che sta benissimo, è il classico rimedio peggiore del male. Sarebbe più onesto, molto più limpido e forse anche più proficuo, presentarsi alle urne con liste divise, pur assicurando l'alleanza in caso di vittoria. Nata sotto mediocri auspici ai tempi già remoti del maggioritario, la lista unitaria non ha più motivo di esistere col proporzionale. Gli elettori avrebbero così modo di esprimersi davvero, anche per quel che riguarda gli orientamenti di un futuro governo di centrosinistra, e se poi fossero chiamati a pronunciarsi anche sul programma, oltre che sui baffetti dell'uno o sugli occhi cerulei dell'altro, sarebbe in questo pease quasi una rivoluzione democratica. Un passo serio e non propagandistico in direzione opposta al berlusconismo. Quello del cavaliere, e quello non troppo diverso dei suoi rivali.
Una domanda da 50 milioni di euri
Editoriale su Il Foglio 7 gennaio
Ripubblichiamo, contro ogni intimidazione, l'editoriale del Foglio del 30 dicembre 2005, nel quale ponevamo una chiara domanda politica.
C'è un partito del Corriere della Sera e del suo patto di sindacato? E' in corso un'opa segreta dei poteri forti finanziari sul partito democratico e sui futuri equilibri di governo in caso di vittoria del centrosinistra? A questa scalata partecipa anche il gruppo di Carlo De Benedetti, editore di Repubblica e tessera n° 1 che designa pubblicamente i leader e gli amministratori del nuovo partito? Negli organici del plotone d'assalto stanno Confindustria, editrice del Sole 24 Ore, e la Fiat con la Stampa? E' vero che l'attacco in corso è anche contro l'autonomia della politica, e dunque colpisce allo stesso modo Berlusconi in una prefigurazione dell'eterno ritorno dell'identico, cioè la famosa nuova Tangentopoli? E' questa l'origine dell'offensiva mediatica e giudiziaria che ha travolto Fiorani, Fazio, il vertice dell'Unipol e ora anche la compagnia assicurativa, e poi Gnutti il raider, e Ricucci e Coppola e insomma i cosiddetti immobiliaristi? A queste domande, più o meno apertamente, i dalemiani rispondono di sì. La novità di ieri è che anche due numeri due ex aequo di Berlusconi, Sandro Bondi che dice a D'Alema “liberiamoci insieme di questi tecnocrati” e Bonaiuti che denuncia l'indegna voglia di politica del Corriere, tendono a rispondere nello stesso modo.
A noi piacciono gli outsider, che quando non siano rubagalline funzionano da sempre nella storia come elementi di rinnovamento. Ci piace l'autonomia della politica fino al punto che per difenderla abbiamo abbracciato per anni l'antipolitica, unico antidoto a un'universale soggezione al partito mediatico-giudiziario e al suo circo nell'Italia degli anni Novanta e seguenti. Ma non ci piace essere presi per il culo.
Con il massimo rispetto per le persone e per il loro diritto all'immagine, specie per quelle persone (e gruppi e partiti e movimenti) che non lo hanno riconosciuto agli altri, osserviamo dunque che prima di partire in crociata contro la galassia del nord, contro il Corriere e la regia politica di Paolo Mieli, vogliamo un'adeguata spiegazione politica di quella provvista generosa di denari messa insieme in quote percentuali identiche da Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti. Cinquanta milioni di euri sono cento miliardi di vecchie lire. Qualcosa di simile alla provvista Enimont. Qualcosa di molto diverso da un cumulo di consulenze finanziarie. Qualcosa di molto diverso da generici “arricchimenti personali”. Questi soldi hanno cominciato a passare di mano quando il premier di sinistra D'Alema sosteneva i “capitani coraggiosi” dell'opa Telecom, quando l'ex senatore della sinistra indipendente e avvocato d'affari di grido della Milano che conta, l'avvocato Guido Rossi, replicò a quella affermazione con una battuta celebre e temeraria, ma mai spiegata bene né dal mittente né dal destinatario: “A Palazzo Chigi funziona l'unica merchant bank in cui non si parla l'inglese”.
D'Alema e i suoi hanno sostenuto i capitani coraggiosi e gli ex capi delle cooperative ora dimissionari, e hanno in modo obliquo segnalato la loro contiguità e solidarietà politica a un personale di gestione di banche, assicurazioni popolari, gruzzoli mobiliari e patrimoni immobiliari ora sotto inchiesta per diversi reati. Sono stati politicamente parte di una rete amica e trasversale, di soldi e di potere, che ora viene smantellata da loro vecchie conoscenze, primo fra tutti il grande inquisitore finanziario Francesco Greco. E quella provvista finanziaria, insieme con una scalata bancaria collegata in modo opaco a grandi maneggi in azioni Rcs e a una complicata partita giocata intorno all'Antonveneta e alla Banca d'Italia, non è uno di quei dettagli che si possano cancellare ricorrendo alla denuncia di un grande disegno di annientamento della forza politica costituita dagli ex comunisti.
Non ci accontentiamo dei silenzi di Prodi, delle denunce a tempo di Parisi, del solito passo laterale di Amato, delle richieste di autocritica di Napolitano, della difesa pelosa dei diritti del mondo cooperativo, dell'interpretazione dell'ultima dichiarazione di Veltroni o di Rutelli o di De Benedetti, dei mille fumi e fuochi fatui che ci danzano davanti. Quando fu sotto attacco, anche Craxi se la prese con i giornali e con i poteri forti, mentre tutto il mondo politico e degli affari sobbolliva come oggi al calore della viltà e della dissimulazione all'italiana, ma poi andò alla Camera e disse intera la sua verità sul rapporto tra i soldi e la politica, andò al processo Enimont e disse intera la sua verità sul rapporto tra soldi e politica davanti a un impietrito Tonino Di Pietro. I nuovi Craxi, alleati di Di Pietro e delle procure di mezza Italia, ora facciano lo stesso. Poi parleremo di Paolo Mieli e del Corriere della Sera.
Feltri: svolta antiberlusconiana?
Gianguido Vecchi sul Corriere della Sera 8 gennaio
MILANO — Assioma: «Un governo, in Italia, ha già rotto le palle dopo due anni. Figuriamoci dopo cinque». Vittorio Feltri sorride sornione, «credo che nel frattempo lo abbia capito pure lui, negare ogni errore e dire "tutto va ben, madama la marchesa" è controproducente». Perciò è inutile che il Cavaliere se la prenda se la sua navicella corsara, sempre meno navicella e sempre più corsara, ogni tanto gli assesta qualche ceffone: «Silvio socio di Consorte», titolava ieri a tutta prima pagina Libero, con tanto di fotomontaggio dei due che si guardano sorridenti e un'intera pagina a ricostruire le partecipazioni Fininvest (2,53%)e Mediaset (2,73%) nell'Hopa di Gnutti e via andare, «Berlusconi si ritrova azionista di Unipol».
Con tanti saluti all'indignazione di Berlusconi sugli intrecci tra affari e politica: «Per carità, in politica ci sta questo e altro. Ma se sei in società con questi devi starci attento, no? Lui può sempre dire che sono stati i figli, ma non mi dica che non lo sapeva. E allora, quando salta fuori il casino, almeno evita di fare la predica ai tuoi soci...». Non è la prima volta e non sarà neppure l'ultima, «che diavolo, le critiche si fanno, no? Noi siamo un giornale d'opinione, abbiamo un pubblico prevalentemente di centrodestra, però questo non ci impedisce di vedere le cose». E pazienza se dalla Cdl lo guardano male e c'è chi sospetta una svolta antiberlusconiana del temutissimo Feltri. «Ma va là, è una stupidata — ride — di articoli contro Berlusconi ne abbiamo sempre scritti, quand'era il caso. Lui li interpreta come segni di ostilità, e in questo si rivela un po' infantile. È abituato alle labbra morbide e alla lingua umida dei lacché di cui ama circondarsi, mi sa».
Adesso, col suo sodale pubblicitario Gad Lerner, s'è messo pure a girare uno spot per i krumiri (nel senso dei biscotti) con battute del tipo: «Caro Silvio, i sondaggi non sono più quelli di una volta?». Ma niente virate, assicura, anche perché «berlusconiano» non è mai stato, «anzi io ho sempre detto che era Berlusconi ad essere feltriano. Se poi non lo è più, amen».
Il direttore di Libero sa d'essergli un po' indigesto e ricorda benissimo la faccia del premier mentre lui, a Porta a porta,
gli diceva che i famosi poliziotti di quartiere non li aveva mai visti, «basta vedere come mi guardava! Era ostile, faceva il duro, stava lì a mostrare un grafico e non si capiva niente... Le cose girano, ho anche saputo che non mi vede molto volentieri, quando vado in tv. Pazienza». Comunque c'è poco da fare, «io sono critico con tutti, anche con coloro che ho votato e rivoterò, e non perché sia ideologizzato ma per mancanza di alternative. Certo mica mi metto a votare Prodi, gli avversari mi fanno senso...». Deluso? «A sessant'anni s'immagini se può deludermi qualcosa. Tutto sommato il governo ha delle attenuanti e gliele riconosciamo, ma questo non significa che si debba agitare il turibolo, non è il nostro mestiere, facciamo i giornalisti».
Chiaro che nella Cdl non siano felicissimi, anche se il coordinatore di Forza Italia Sandro Bondi fa mostra di sportività: «Feltri è un giornalista libero e fa un giornale libero, non condizionabile. In qualche caso possiamo non essere d'accordo, però lo rispettiamo». Quello dell'Hopa è uno di quei casi, «credo che Berlusconi non sappia nemmeno di 'sta cosa, del resto si tratta di cose minime, inapprezzabili, che sono state ingigantite in modo abnorme, oltre ogni limite. Davvero sorprendente». E l'insofferenza alle critiche? «D'accordo la libera dialettica, ma non è detto che abbia sempre ragione». Qualcosa di simile, dalla parte di An, la dice anche Ignazio la Russa: «I politici sono sempre insofferenti alle critiche, si figuri se D'Alema fosse attaccato così da un giornale di sinistra. Il problema è che di là, al massimo, usano il fioretto. Feltri invece picchia duro e non fa sconti. Però è vero, ultimamente la faccenda è peggiorata, noto una certa incomunicabilità con una parte del centrodestra».
Feltri, lui, non se ne dà per inteso. «Berlusconi è padronissimo di pensare che chi lo critica è un suo nemico, ma noi siamo tutt'altro che nemici e nei momenti topici su tante cose lo abbiamo difeso, le tasse, la guerra, anche il conflitto d'interessi: lui ha fatto un brodino, ma gli altri zero». Certo di errori ne ha combinati, «l'accanimento nel far passare a tutti i costi le leggi ad personam, anzitutto. E le altre? Cosa gli costava cancellare i reati di opinione? Me lo aveva promesso e invece niente». E poi «da una maggioranza liberale mi attendevo provvedimenti liberali che non ho visto: l'abolizione degli ordini professionali o del valore legale dei titoli di studio, per dire. Mi ha infastidito pure il no al divorzio breve e l'atteggiamento sui referendum, ero più d'accordo con Fini». Rapporti personali? «Inesistenti. Qualche telefonata cordiale, al massimo. Anche quando ho diretto il Giornale per quattro anni, dopo Montanelli, non mi ha mai scocciato». Consigli? «Non attacchi in modo sgangherato, ché tanto il centrosinistra si fa male da solo. Stia buono. Deve sempre fare i conti con il pulpito da cui viene la predica. E il suo pulpito non è dei più adatti».

 8 gennaio 2006
8 gennaio 2006
![]() 8 gennaio 2006
8 gennaio 2006