



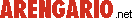
La settimana in rete
a cura di Primo Casalini - 14 agosto 2005
La suburra in casa
Eugenio Scalfari su la Repubblica 14 agosto
Ai tempi della dinastia Giulio-Claudia la Suburra era un quartiere e una strada, a poche centinaia di metri dalla Casa imperiale. Cominciava dalle pendici dell´Esquilino e finiva a poca distanza dalla spianata del Foro. Sotto scorreva la cloaca massima che sbucava nel Tevere davanti all´Isola Tiberina, all´altezza dei templi di Vesta e della Fortuna Virile.
Era un quartiere popolare e malfamato, ma non mancavano case patrizie e di liberti arricchiti, circondate da taverne, bordelli, bische, fondachi, abitati da lenoni, prostitute, commercianti, ladri, tagliagole e anche da qualche persona perbene.
Così era il cuore della Roma di allora. Sullo sfondo a est Vespasiano costruì il Colosseo, a sud si vedeva l´Arco di Tito, a ovest il Tempio di Nettuno e la Rocca Capitolina sovrastante la Rupe Tarpea.
Da allora la parola Suburra acquistò anche un significato traslato, denominò un degrado sociale e morale, coesistente con la forza e la dignità dell´imperium. La "Via sacra" sulla quale passavano le legioni vittoriose e i loro comandanti, correva in perpendicolare rispetto alla Suburra.
Questo quadro geopolitico è quanto mai d´attualità. In un certo senso lo è sempre stato, non solo a Roma e non solo in Italia, ma in tutti quei luoghi del mondo dove vi sia intensa lotta per l´accaparramento della ricchezza e per la conquista del potere. Cioè dovunque.
Talvolta è la ricchezza a creare il potere, talaltra è il potere a creare ricchezza; si tratta infatti di due elementi fortemente interattivi. Ogni paese ha la sua Suburra, il che non è affatto consolatorio. È semplicemente un dato di fatto.
Gli uomini di Stato (di tanto in tanto ne nasce qualcuno) stabiliscono regole adatte a bonificare le suburre e inducono con l´esempio a comportamenti meno degradati. La morale serve a questo: a immaginare e praticare il bene comune superando gli appetiti primordiali.
Se la storia non fosse punteggiata anche da queste fasi positive, sarebbe solo un susseguirsi di sopraffazioni, intrighi, delitti. Cesserebbe di essere storia.
La vera fine della storia è la Suburra permanente. Nei tempi e nei luoghi in cui la permanenza della Suburra si è protratta, quei paesi sono infatti usciti dalla storia. Non sempre sono riusciti a rientrarvi.
Domenica scorsa ho scritto un articolo intitolato "Alla ricerca della morale perduta" dove, con riferimento ad attualissime vicende, distinguevo tra il sentimento morale che fa tutt´uno con l´identità della persona e le morali parziali che emergono a modello degli interessi, delle passioni, degli appetiti.
Mi ha fatto piacere trovare analoghi concetti negli articoli di Ilvo Diamanti e di Berselli su Repubblica, di Giovanni Sartori e di Lucia Annunziata sul Corriere della Sera e sulla Stampa di ieri.
Questa convergenza di convinzioni costituisce un fatto positivo. Un segnale confortante. Di fronte alla Suburra dilagante i maggiori quotidiani italiani hanno opposto, senza bisogno di alcun "concerto" tra loro, una salda linea di resistenza. Forse la sola che, ispirandosi al sentimento morale, stia cercando di preservare due beni pubblici di fondamentale importanza: la libertà d´informazione e l´oggettività dei banchieri nell´erogazione del credito.
Tutte le volte che si è tentato di distruggere lo Stato di diritto, l´offensiva è sempre cominciata dalla libertà d´informazione e dall´oggettività nell´erogazione del credito.
Per impedire che questi tentativi riescano nei loro perversi intenti non c´è che opporvisi mobilitando l´opinione pubblica. I giornali che ne sono la voce mostrano d´aver compreso quale sia il loro ruolo. Così accadde anche ai tempi della P2, che coltivava analoghi progetti contro lo Stato di diritto da realizzare con la consueta tecnica della conquista del potere bancario, il bavaglio alla libertà di stampa, l´asservimento delle istituzioni di garanzia a cominciare dalla magistratura.
Il disegno della P2 fu alla fine sconfitto. Così mi auguro accada anche oggi nonostante i molti e molto trasversali errori che vediamo commettere a destra e a sinistra.
* * *
Dal formicaio dell´attuale Suburra sono emersi alcuni personaggi confinanti con l´imperium poiché forniti di poteri decisionali o a essi contigui.
Indichiamoli questi emergenti: Gianpiero Fiorani, amministratore delegato della Banca popolare italiana (ex Lodi), Emilio Gnutti finanziere e brasseur d´affaires, Stefano Ricucci e i suoi compagni "immobiliaristi", Francesco Gaetano Caltagirone costruttore edile, editore del Messaggero e del Mattino di Napoli.
Con la sola eccezione di Caltagirone, tutti gli altri sono inquisiti dalla Procura di Milano che ha da tempo disposto l´intercettazione dei loro telefoni affidandola alla Guardia di Finanza in veste di polizia giudiziaria. I reati dei quali sono accusati vanno dall´aggiotaggio al falso in bilancio al depistaggio delle autorità di controllo. Il tutto con riferimento all´Opa sulla banca padovana Antonveneta.
La Consob, nei suoi poteri di tutela del mercato e della trasparenza delle operazioni, ha sospeso l´Opa e la Banca d´Italia ha confermato (assai tardivamente) la decisione della Consob. Il gip di Milano ha disposto il sequestro del 40% delle azioni Antonveneta rastrellate da Fiorani e dai suoi alleati, delle plusvalenze realizzate e ha sospeso per due mesi Fiorani, Gnutti e Ricucci da ogni attività amministrativa.
Nel frattempo sono diventate di dominio pubblico le intercettazioni telefoniche effettuate. I giornali ne hanno dato ampia (e spesso confusa) notizia. L´impressione che se ne ricava è appunto quella d´un gruppo animato soltanto da appetiti, vanità, manie di grandezza, disprezzo d´ogni regola, volpi e faine da pollaio, servilismo verso i potenti accompagnato da abbondante disprezzo. Insomma la Suburra è la cloaca che scorre sotto la superficie con i suoi miasmi e il suo liquame.
Non sappiamo se i reati dei quali sono accusati saranno provati in giudizio, ma dal punto di vista morale essi sono già condannati. La pubblica opinione è più rapida; talvolta la rapidità va a detrimento del vero e del giusto, ma in quest´occasione a me non pare ci possano essere equivoci e fraintendimenti. I contesti di quelle conversazioni, i progetti che se ne ricavano, i metodi adottati, sono quelli del malaffare. Non emergono finalità d´altro genere che non siano quelle di soddisfare l´appropriazione di ricchezza che produca ricchezza, per se stessi e unicamente per se stessi.
Mi ha colpito, tra i tanti spunti di quelle registrazioni, la furbata (meglio sarebbe chiamarla mascalzonata) di Fiorani che finanzia una sessantina di clienti della sua banca affinché comprino azioni Antonveneta e poi le rivendano entro un certo termine alla banca stessa, guadagnandoci sopra; il tutto per andare avanti sotto mentite spoglie nel rastrellamento pre-Opa (autorizzato dal governatore Fazio contro il parere dei suoi stessi ispettori). Del resto analoghe pratiche Fiorani le aveva svolte in favore di Ricucci e dei suoi compagni.
Mi ha colpito altresì l´entità dei fondi che alcune banche italiane hanno messo a disposizione di Ricucci fin dal 2004: in totale i prestiti a buonissimi tassi ammontano a 934 milioni, pari a 1.850 miliardi di vecchie lire. Da aggiungerci 350 milioni di euro provenienti dalla Deutsche Bank.
Garanzie? In gran parte i titoli dell´Antonveneta rastrellati, dell´Rcs, della Bnl comprati con quegli stessi prestiti e messi a garanzia delle banche creditrici. In gergo tecnico si chiama leverage by out ed è praticato, anche se con le doverose cautele, ma mai per Opa, che una volta conclusa vede la caduta del titolo e quindi dei margini di garanzia. Ma soprattutto mai per scalare la casa editrice di un giornale.
Dov´è in tutto questo il peccato (mortale) di Fazio?
La vigilanza della Banca d´Italia aveva il compito di ispezionare la consistenza patrimoniale della Popolare Italiana e confrontarla con il patrimonio dell´Antonveneta, le cui dimensioni superano largamente quelle della "Lodi".
Gli ispettori dopo attento esame arrivarono alla conclusione che la "Lodi" non fosse in regola e che quindi l´operazione non potesse essere intrapresa.
Il governatore viceversa firmò. Sembra la manzoniana Monaca di Monza: "La sciagurata rispose".
Non è la pretesa difesa dell´italianità delle banche che lo condanna, ma il mancato rispetto dei parametri patrimoniali e la partigianeria con la quale impedì alla Abn-Amro di comprare azioni Antonveneta mentre lo consentì alla "Lodi" la quale se ne servì nei modi che abbiamo già visto. Questi peccati sono ampiamente sufficienti a squalificare il governatore agli occhi di tutta Europa. E con lui purtroppo la credibilità del paese.
* * *
Resta da parlare della scalata alla Banca Nazionale del Lavoro da parte dell´Unipol e di Giovanni Consorte che l´amministra; nonché delle frenetiche telefonate dello stesso con mezzo mondo politico (di sinistra e di destra) e con i protagonisti delle scalate parallele su Antonveneta e Rcs (più ipotetici progetti di scalate a Mediobanca, Fiat, Capitalia da parte dello stesso branco lodigiano-bresciano - romano).
Qui i problemi sono tre: le modalità dell´Opa su Bnl lanciata da Unipol per contrastare la Banca di Bilbao, l´ipotesi di un patto segreto che vede Consorte in combutta con Fiorani-Gnutti-Ricucci e quindi unifica strategicamente le tre scalate (tutte ormai sotto l´occhio della procura di Milano e di quella di Roma per quanto riguarda la Bnl), i rapporti che emergono dalle telefonate numerose e frequenti tra lo stesso Consorte e numerosi esponenti dei Ds, tra i quali Fassino, Bersani e il tesoriere di quel partito Ugo Sposetti.
Sul primo problema c´è da notare che anche Unipol, come la Popolare italiana (ex Lodi) non sembra disporre delle risorse necessarie per acquisire il controllo della Bnl. Di più: in questo caso emerge anche la circostanza che, essendo la dimensione patrimoniale di Bnl notevolmente superiore a quella di Unipol, la sua acquisizione cambierebbe le finalità di compagnia assicurativa di Unipol prevista come prevalente nelle sue attività nello statuto sociale e quindi darebbe agli azionisti dissenzienti il diritto di recesso, con ulteriore e notevole aggravio delle finanze di Unipol.
C´è una motivazione valida per portare avanti un´operazione così onerosa? Secondo il presidente della Lega delle cooperative sì, c´è una finalità d´interesse generale: far nascere una nuova nervatura del capitalismo italiano; accanto a quello familiare e a quello manageriale, un capitalismo cooperativo o comunitario che dir si voglia.
Non sto a discutere se sia una motivazione valida. A occhio mi pare alquanto utopistica. Comunque c´è ed è sempre meglio che niente.
Ma se questo è il fine bisogna pur dire che i mezzi adottati stravolgono quel fine in modo devastante. Se per costruire un capitalismo comunitario il manager incaricato di realizzarlo si trasforma in un elemosinante di appoggi politici a destra come a sinistra e di appoggi finanziari, tattici e strategici, con il gruppo Fiorani-Gnutti-Ricucci, al punto di scambiare con essi finanziamenti, promesse per il futuro, finti disimpegni, acquisti di azioni compensati con laute plusvalenze; se questi sono gli strumenti adoperati da Consorte, Dio ci scampi da un capitalismo cooperativo di tale fatta.
Infine i rapporti con i politici. Nessuno si stupisce che Tremonti e altri esponenti di centrodestra possono aver dato appoggio all´intraprendente Consorte. Diverso è il problema a sinistra.
Che Fassino, D´Alema, Bersani, abbiano più volte dichiarato la loro simpatia politica verso le Coop non può suscitare alcuno scandalo: i legami della sinistra con le Coop (e quindi anche con Unipol) hanno caratteristiche storiche ben note e sempre ribadite. E nessuno, neppure i più feroci avversari, mette in dubbio l´onestà privata delle persone sopra indicate.
Neppure stupisce che i dirigenti di partito abbiano colloqui orientativi con imprenditori, fa parte dei loro diritti e vorrei dire del loro dovere d´essere informati su quanto avviene nell´economia del paese.
Il tema del resto è stato lucidamente esposto dallo stesso Fassino nell´intervista a Repubblica di pochi giorni fa: l´impresa ha i suoi diritti e piena autonomia di farli valere nel rispetto della legge; alla politica spetta dettare le regole; alla magistratura (ma anche alla politica) controllare che siano rispettate.
Perfetto. Ciò significa che i politici debbono astenersi da appoggi e interventi di qualsiasi tipo quando un´impresa (specie se amica) si cimenta sul mercato in concorrenza con un´altra.
Di qui l´inevitabile sconcerto per le molte, troppe, telefonate intercorse nei giorni caldi dell´operazione Bnl tra Consorte, Fassino, Sposetti e compagni. Che cosa c´era di così urgente da comunicarsi? Di che cosa parlavano? Di vacanze, di maltempo, o di che cosa? Il magistrato, in ossequio alla legge, ha secretato quei colloqui. Né potrebbe rivelarli, neppure se l´interessato lo chiedesse rinunciando all´immunità. Ma Piero Fassino può dire di che cosa si trattò in quelle frequenti conversazioni. Secondo me può e deve dirlo. E dovrebbe anche dire se i legami emersi tra Consorte e le altre cordate scalatrici non suscitino nel suo animo franca e onesta riprovazione. Questo ci aspettiamo da un uomo onesto, che crede nelle sue idee e nell´etica che le anima.
Le mezze parole a questo punto non bastano.
* * *
Mi resta ancora un punto da affrontare e cioè il cosiddetto scandalo delle intercettazioni. Pera e Casini ne hanno fatto una questione preminente per quanto riguarda i membri del Parlamento. È in corso a questo proposito una discussione con il Tribunale di Milano della quale attendiamo con interesse il risultato.
Le intercettazioni si svolgono con una procedura prevista dalla legge. Si vuole cambiare la legge? Certamente si può.
Vedremo come. Ma allo stato dei fatti una legge c´è e si tratta di controllare se sia stata rispettata oppure no.
Ricordo a chi si scandalizza per il fatto stesso che vi siano intercettazioni che in Usa non solo la magistratura ma perfino la Sec (cioè la Consob americana) può disporre intercettazioni per accertare e perseguire reati contro il diritto societario, l´insider trading, l´aggiotaggio, il falso in bilancio. Lo sapeva onorevole Casini? Lo sapeva onorevole senatore Pera?
Comunque, vediamola questa legge di riforma e ne discuteremo. Ma le intercettazioni sono comunque un contenitore; poi c´è il contenuto, cioè le conversazioni registrate. Si vorrebbe conoscere che cosa ne pensino i presidenti Pera e Casini dei contenuti che stavano in quei contenitori. Finora sono stati avarissimi di giudizi sui contenuti quanto loquacissimi sui contenitori. C´è dunque una lacuna. Volete per favore colmarla?
Gli anticorpi a difesa della democrazia
Barbara Spinelli su La Stampa 14 agosto
La questione morale di cui si torna a parlare in questi giorni non è un'invenzione dei magistrati, né di giornalisti allettati da pettegolezzi, né di politici che vogliono farsi strada demolendo non solo il comportamento ma l'essenza stessa dell'avversario, o del concorrente, o dell'alleato. La questione morale non è neppure qualcosa che emerge di tanto in tanto come denuncia assurda, irrealistica, addirittura destabilizzante d'un male italiano endemico, che si trascina nel tempo, che per sua natura non è curabile, che è dunque elemento inevitabile e in definitiva trascurabile della convivenza tra cittadini e dei modi in cui essi son governati.
La questione morale ha avuto nella storia nomi diversi - in passato si chiamò questione delle virtù, del valore o coraggio, dell'onore, della decenza, o più semplicemente dell'esser perbene, come ricorda Sartori sul Corriere della Sera di ieri - ed è innanzitutto una domanda che nasce dentro la società e le sue classi dirigenti, quando gli uomini che compongono l'una e le altre non sono, per dirla con Leonardo, meri transiti di cibo.
La domanda suona così: i politici che governano o vogliono governare si comportano come si deve? (dal che si vede che morale è anche scabro, ripido senso del dovere). Le autorità pubbliche incaricate d'esser neutrali vigilano in modo veramente neutrale su imprenditori, banchieri, politici, o permettono a amici e protetti di violare o aggirare le leggi? Tutti costoro rispettano quell'insieme di regole scritte e anche non scritte che tengono insieme la società ed evitano lo sprofondare in guerre di tutti contro tutti? La questione morale non è molto diversa dal contratto sociale: se non viene posta quotidianamente, è la società stessa a perder la bussola e sfaldarsi. Considerarla una questione antiquata o astratta, e liquidarla affibbiandole l'attributo sprezzante di moralismo, equivale a una rottura del contratto e a una defezione delle élite.
Questo vale per ciascun cittadino e qualsiasi politico; per la destra, il centro e la sinistra. Ciascuno ha l'obbligo di porsi la domanda sul corretto modo di agire prima ancora che intervenga il magistrato, prima che la scorrettezza o il reato vengano consumati, nel momento in cui la tentazione di trasgredire insorge e non solo quando alla tentazione già si è ceduto. L'agire morale riguarda la fase che precede la linea di confine a partire dalla quale i comportamenti diventano penalmente rilevanti. Se la morale viene dopo e non prima ci saranno espiazioni o punizioni o revisionismi storici, ma non ci sarà agire etico in senso stretto. Anche in questo Sartori vede giusto - a mio parere - quando scrive, a proposito dell'alleanza tra affaristi che De Benedetti ha stipulato e poi revocato con Berlusconi politico: "Ho dato le dimissioni (dall'associazione Libertà e Giustizia di De Benedetti, n.d.r.) in risposta a un comportamento che c'è stato, e perciò non le ritiro".
C'era un tempo in cui la sinistra storica in Italia, impersonata dai comunisti, pretendeva di avere una sorta di primato morale, e di esser perciò esentata da indagini riguardanti l'etica. Ma da allora i tempi sono cambiati, è come se da una dismisura fintamente etica i Ds fossero passati a una dismisura fintamente liberista, e la trasformazione appare radicale se si guarda a numerosi fatti comprese le ultime intercettazioni. Questo primato, il partito di Fassino e D'Alema non solo non l'ha più, ma apparentemente non vuole più averlo. Non di rado l'aspirazione di molti suoi dirigenti - da quando il comunismo mondiale è caduto - sembra esser quella di mostrarsi eguali a tanti altri, spregiudicati come tanti altri, condiscendenti come tanti altri, su punti essenziali: sul rapporto fra giustizia e politica, fra politica e affari, fra politica e informazione.
Questo loro mettersi al passo coi tempi moderni fa pensare alla traiettoria di molti postcomunisti dell'Est Europa: convertitisi all'economia di mercato, questi pensano ora che il capitalismo non abbia una storia fondata su pratiche di autolimitazione e su leggi disciplinanti, ma che assomigli quasi per intero all'immagine statica che Marx si fece dell'economia di mercato, quando descrisse il capitalismo speculatore e selvaggio. Questo capitalismo caricaturato si son messi ad abbracciare.
Tale singolare metamorfosi è come fosse spesso oscura agli stessi eredi del Pci. Pur volendo rinunciare al primato nelle condotte del Bene, sanno di avere quell'antica aspirazione nel sangue e non consentono che altri s'indignino là dove loro non s'indignano più. Per questo non sopportano che nel centro sinistra non siano i Ds a porre con determinazione la questione morale, ma che per primi abbiano parlato Rutelli, e poi Parisi. I Ds in genere, tranne qualche eccezione, son stati circospetti, su tutte le questioni riguardanti etica ed economia, finanza e vigilanza bancaria. Molto del loro tempo e della loro cura, l'hanno dedicato a difendere la scalata delle cooperative di Unipol sulla Banca Nazionale del Lavoro e a sottolineare una diversità - tra Consorte Presidente di Unipol e Fiorani scalatore di Antonveneta - che col passare dei giorni tende a svanire.
Non sembrano esserci illeciti, nella condotta dei Ds. Ma sembra esserci corrività verso comportamenti probabilmente illeciti, soprattutto sembrano esserci strane pericolose amicizie che nella loro qualità di politici essi hanno stretto con uomini d'affare, e questa confusione di ruoli è già non morale. Per il cittadino comune, non c'è poi molta differenza tra un governante che difende le proprie aziende (Berlusconi), e un governante in pectore che difende le sue. I principali dirigenti Ds richiamano tutti gli imprenditori e banchieri alla legge, ma spesso non nascondono i loro favori e in tal modo stravolgono il ruolo del politico che da arbitro diventa regista.
Perfino il linguaggio risente di simile stravolgimento, mescolando categorie del privato e del pubblico. Le parole chiave sono: amicizia, simpatia, ricorrenti nelle interviste di D'Alema, Fassino, Bassanini. Non ci fu forse sostegno a Unipol ma ci fu e c'è simpatia (i sinonimi usati sono: vicinanza, neutralità benevola). Le telefonate intercettate di Fiorani e di Consorte sono illuminanti. Ogni tre minuti Consorte sente il bisogno impellente di telefonare a massimi dirigenti dei Ds o al loro tesoriere. Per ottenere che? Per promettere cosa? Può darsi che siano chiamate innocue, può darsi di no. I cittadini sono in diritto di chiedere che i politici spieghino cosa esse significhino, e quale sia la natura di simpatie che poco hanno a che spartire con l'amicizia tra Achille e Patroclo. L'amicizia è un bene sublime, nell'esistenza d'ognuno, ma in politica e affari la sua essenza è equivoca. Il giudice Falcone, per meglio descrivere la propria frontale battaglia contro la mafia, soleva dire di sé: "Tutti devono sapere che di me non ci si può fidare" (Film di Mauro Parissone, A Futura Memoria).
Le amicizie non chiare tra politica e affari sono il male d'Italia, che Berlusconi ha aggravato trasformandolo in tentazione diffusa. E gli eredi di Berlinguer non ne sono immuni, per il fatto d'avere alle spalle una storia di presunto primato morale. È la prima lezione che forse potrebbero apprendere, dalla prova odierna. Essendo molto cambiati non possono dire, come tendono a dire: "Noi non riceviamo lezioni da nessuno". Possono riceverle invece, perché la loro diversità antropologica non esiste e loro stessi l'hanno revocata. È D'Alema che ha fatto compromessi sulla giustizia con Berlusconi, ai tempi della Bicamerale, che si è implicato nella scalata della Telecom quand'era premier, che usa scegliere tra le scalate come se l'uomo che governa non avesse da essere completamente sopra le parti. Il conflitto d'interessi contagia la destra, e anche la componente maggiore della sinistra.
* * *
Chi denigra la questione morale dice che tutto è cominciato con magistrati e intercettazioni, e s'indigna in primo luogo con essi. Ma abbiamo visto come la morale cominci ben prima delle effettive scorrettezze legali, come lo sforzo di ristabilirla cominci con quegli anticorpi che sono la coscienza in ciascuno di noi, e nei vari organismi della società e dello Stato: anticorpi cui spetta il compito di espellere le cellule malate prima che il male cresca in maniera tale da necessitare il giudice. Questi anticorpi non mancano in nessuna democrazia, e neppure in Italia. È quello che spiegano bene Salvatore Carrubba sul Sole-24 ore del 6 agosto e Marco Onado sul sito di LaVoce.info.
Ben prima che intervenissero magistratura e intercettazioni c'è stata azione morale in senso stretto, dunque hanno agito anticorpi. Ci sono state inchieste di giornalisti e denunce di studiosi, che ipotizzavano abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e aggiotaggio informativo e manipolativo. C'è stato poi l'intervento dell'autorità che vigila sulle società e la Borsa (Consob): fin dal 10 maggio essa ha illustrato in una delibera gli illeciti gravissimi commessi da Fiorani (violazione delle regole di funzionamento del mercato finanziario e bancario, aggiotaggio, insider trading). All'interno stesso di Banca d'Italia infine, nei primi di luglio, vi sono stati funzionari che con fermezza hanno fatto prevalere le considerazioni tecniche sulle pressioni ricevute. Anche questa è condotta morale, come sappiamo.
L'etica infatti non è solo reazione a virtù lese da altri: c'è agire virtuoso anche quando ciascuno - nell'ambito che è il suo - fa il proprio dovere. Chi s'indigna per l'emergere della questione morale non scorge evidentemente altro, di cui indignarsi. Ritiene che il male non sia in fondo curabile: di esso non si sdegna più, in parte per cinismo disilluso, in parte per rassegnazione, in parte per complicità, in parte per ignoranza di quelli che sono i doveri d'ognuno. È quello che spiega l'odierno contagio di comportamenti non virtuosi. In genere chi non denuncia la questione morale si perde nei meandri del passato e a questi anticorpi bada poco perché essi contraddicono la visione di una storia ineluttabilmente negativa.
Ma esiste in Italia anche una storia di anticorpi possenti, grazie ai quali la società e la politica sempre tornano a riprendersi. Sono le storie che narrano di coraggiosi e solitari come Falcone e Borsellino. Di studiosi e giornalisti come Sylos Labini, Sartori, Montanelli. Di politici come Luigi Einaudi, Nino Andreatta. Si può immaginare che il Presidente della Repubblica, quando parla di schiena diritta, non si riferisca solo alle schiene dei giornalisti. Anche se rari, gli anticorpi dimostrano ogni giorno di esistere, confermando come la questione morale ci stia di fronte a ogni ora, e come il valore forte delle persone non sia polvere d'altri tempi. La magistratura occupa l'intero spazio solo quando essi s'assottigliano, o tacciono. Gli anticorpi hanno funzionato in passato. Possono tornare a funzionare, se sappiamo coltivarne il ricordo e apprezzarli prendendone esempio.
Segno Bilancia, ascendente Toro
Claudio Magris sul Corriere della Sera 14 agosto
Da settimane si susseguono continue notizie—voci, documenti, ipotesi, smentite, fantasie — concernenti un possibile mutamento dell'assetto proprietario del Corriere della Sera. Quando si profila — e si profila periodicamente, con o senza fondamento — una simile evenienza, è ovvio che essa desti, a seconda dei casi e degli orientamenti personali, preoccupazioni, speranze, diffidenze, consensi, allarmi. Data la rilevanza oggettiva del Corriere, del suo ruolo e della sua funzione, è naturale che l'eventualità di una diversa maggioranza proprietaria e di un possibile diverso atteggiamento del giornale interessi non solo i suoi dipendenti e collaboratori, ma anche le forze politiche e l'intero Paese.
Inevitabile quindi che si analizzi la situazione e se ne preconizzino gli sviluppi, che si valutino le persone e i gruppi potenzialmente coinvolti nella "scalata" del Corriere, che si cerchi di capirne l'affidabilità, gli intenti, gli indirizzi, gli eventuali collegamenti politici, gli elementi che possono indurre ad attendere con fiducia o a stare guardinghi allerta. Mi stupisce perciò che nessun autorevole commento abbia messo nella giusta evidenza uno degli elementi più rassicuranti emersi dalle discussioni e dichiarazioni di queste settimane e riguardanti uno dei protagonisti di questa ridda di illazioni, timori e auspici, Stefano Ricucci. Quest'ultimo, in un'intervista rilasciata al Corriere il 6 agosto, ha dichiarato, dando cospicuo rilievo a tale aspetto, che il suo segno zodiacale è la Bilancia, con ascendente Toro, combinazione che attesta la sua fattiva determinazione e dunque la sua fiducia di giungere alla meta agognata, tanto più che — ha aggiunto — la sua consorte è un Toro con ascendente Bilancia. C'è da tirare un respiro di sollievo e tornare ai sonni tranquilli, lieti che non si profili all'orizzonte del destino corrieresco e nostro un azionista di maggioranza nato sotto il segno dei Pesci o dei Gemelli, un padrone Vergine o Capricorno. Sarebbe bene che ognuno, specie se potenzialmente chiamato ad alte responsabilità, seguisse questo esempio e dichiarasse non tanto le sue precarie idee politiche, filosofiche o religiose, la sua fiducia nelle teorie di Keynes o in quelle della scuola di Chicago, la sua fede in Dio o la sua incredulità, le sue opinioni in materia di libertà di stampa, concentrazioni monopolistiche o conflitti di interesse, bensì il ben più importante proprio segno zodiacale, con annessi e connessi. Dopo tutto, c'è stato qualche ardimentoso ingegno che ha interpretato Cristo e i dodici apostoli quale allegoria del sole e dello Zodiaco.
Purtroppo — e la cosa mi era sempre apparsa sospetta, ma non osavo dirlo—nessuno degli azionisti di maggioranza (e nemmeno dei Direttori, nel loro discorso programmatico tenuto alla redazione al momento della loro nomina) che ho visto susseguirsi in trentotto anni di collaborazione ha mai svelato la propria ascendenza zodiacale, fondamentale per amministrare e dirigere un quotidiano. Su questo punto regna ancora l'omertà. Sappiamo che Repubblica guarda con simpatia al centro-sinistra e Libero invece al centro-destra, ma di che segno sono? E l'Osservatore Romano, dietro il paravento vaticano, da quale combinazione astrologica è realmente mosso? Eil nostro Corriere? Nel mio piccolo, sono andato a controllare la mia anagrafe astrologica, finora da me ipocritamente trascurata e dissimulata; so che il 10 aprile, giorno della mia nascita, mi assegna agli Arieti, ma non so come si fa a calcolare l'ascendente. Provvederò a informarmi e a informarne lealmente i miei lettori.
Berlusconi e l'anomalia della destra italiana
Ezio Mauro su la Repubblica 8 agosto
Ma questa destra italiana è anomala oppure no rispetto ai canoni delle democrazie occidentali, e rispetto alle forze conservatrici della parte del mondo in cui noi viviamo? Io sono convinto di sì, e lo sono dal 1994, quando ho visto nascere con Forza Italia non il moderno partito conservatore europeo che il nostro Paese (abituato ad una destra reazionaria o dorotea) non aveva mai conosciuto, ma un´avventura a mio parere del tutto inedita nella geografia politica del nostro continente: riassunta fin dalle origini nel leaderismo carismatico di un populismo "rivoluzionario", costruito tecnicamente per la presa del potere e non per il governo del Paese, con la televisione a far da moderno balcone e la biografia del leader spacciata in campagna elettorale come un programma politico, un fotoromanzo collettivo, il sogno di una nazione.
Pochi giorni fa, spiegando le ragioni non ideologiche, ma nell´interesse del Paese della nostra opposizione al governo Berlusconi e al suo progetto politico, indicavo i quattro elementi-cardine di questa anomalia occidentale incarnata a mio parere dalla destra italiana: la cultura populista, appunto, il monopolio dell´universo televisivo, il conflitto d´interessi e le leggi ad personam. Come si può facilmente capire, sono quattro elementi costitutivi di un potere improprio in ogni moderna società occidentale, e distorsivi di una corretta regola democratica. Se non si vuole parlare di regime, ove queste quattro anomalie sussistano bisogna però convenire che la qualità della democrazia ne risulta fortemente impoverita. Questo mi è sempre sembrato il cuore del problema berlusconiano, in questo sventurato decennio, e questo Repubblica ha testimoniato, semplicemente, anche se spesso da sola. Un problema che non ha nulla di giacobino, com´è evidente, ma molto di liberale: se solo ci fossero liberali, in Italia.
Ieri Silvio Berlusconi ha scritto a Repubblica una lettera per contestare alla base questo mio ragionamento. La mia, secondo il Presidente del Consiglio, è un´ostilità di tipo personale, dunque illiberale, perché le quattro anomalie in realtà non sussistono.
Per Berlusconi, come i lettori hanno avuto modo di leggere, il conflitto d´interessi è regolato da una legge "severa", che non ha riscontrato illegittimità in nessun atto del governo: dunque il conflitto non esiste. Non esiste nemmeno il monopolio televisivo: secondo il Cavaliere "basta guardare i telegiornali, compresi quelli di Mediaset" per scoprire che il Capo del governo è sottoposto a critiche e polemiche "più di ogni altro governo precedente". Non esistono poi le leggi ad personam, ma solo la necessità assoluta di "proteggere le più alte cariche istituzionali dall´azione penale durante il loro mandato", come avviene "in quasi tutti i Paesi europei". Quanto al populismo, per Berlusconi è solo un problema di linguaggio: l´intellighenzia nazionale "è distante anni luce dai problemi dei cittadini", come dimostrano le poche copie di giornali vendute in Italia, mentre il "parlare ai cittadini con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti" è "l´essenza della democrazia". Questa è la sintesi dell´obiezione berlusconiana. Poiché considero la discussione sull´anomalia della destra utile per il nostro Paese, provo a rispondere al Presidente del Consiglio sui quattro punti da lui contestati.
A mio giudizio, una delle caratteristiche di fondo della cultura populista è la negazione della realtà, non per puro spirito menzognero, ma per non intaccare con elementi concreti, reali, veritieri, quello specchio artefatto dentro il quale si svolge tutta la narrazione dell´epopea leaderistica, fatta di titanismi e anche di vittimismi, in una concezione eroica della storia che non prevede errori ma solo congiure interne e manovre esterne: da cui il Capo può uscire vincitore o anche vinto, o almeno ferito, ma sempre innocente o meglio ancora "intatto" nella purezza del suo progetto al servizio della nazione, e in ogni caso – ciò che politicamente più conta – privo di ogni responsabilità negativa.
Esattamente questo mi sembra l´impianto della lettera del Cavaliere. Il conflitto d´interessi non esiste perché una legge berlusconiana dice che non esiste. La tautologia è ideologia. Le proprietà private, personali di Silvio Berlusconi sono tutte ancora riconducibili direttamente alla sua persona, e sono così estese da incrociare ogni giorno – persino involontariamente – il percorso del governo. Tra questi interessi attivi e patenti, ne esistono alcuni particolarmente sensibili in una democrazia politica e in una democrazia economica. La televisione è il caso più clamoroso, e come ha scritto ieri Eugenio Scalfari la nomina del direttore generale Rai va ricondotta direttamente alla volontà e ai desideri del Cavaliere: mentre il nuovo presidente della televisione pubblica è stato nominato solo dopo aver fatto visita al premier nella sua abitazione privata. Ma a queste evidenze, gravi per qualsiasi democrazia, vorrei aggiungere una notazione psicologica. L´ultima volta che ho incrociato Berlusconi in uno studio televisivo, sei anni fa, ho parlato del conflitto d´interessi. Immediatamente il Cavaliere si è voltato verso di me, e mi ha interrotto in diretta: "Ma lei – mi ha chiesto – è ancora lì con quella roba"? Ecco lo stato d´animo, l´atteggiamento psico-politico davanti ad un problema per Berlusconi eterno. Ma voi, pensa davvero il Premier ogni volta che qualcuno parla dei suoi interessi in conflitto, anche se siamo rimasti in pochi – siete ancora lì con quella roba? Quella "roba", a mio giudizio, è la precondizione di base per far politica correttamente.
Al conflitto si lega ovviamente e direttamente il monopolio televisivo. Le "mani pulite" che il Cavaliere rivendica nel merito delle scelte televisive, atteggiandosi anzi a vittima, sono sconcertanti alla fine di un quinquennio in cui sono stati epurati dal video (e in qualche caso su sua richiesta pubblica) Biagi, Santoro, Guzzanti (Sabina), Luttazzi, Paolo Rossi mentre personaggi organici alla destra politica come Del Noce, Ferrario, Masotti e Berti sono saliti al potere in Rai. Ma c´è molto di più. Il controllo di tre reti private per via proprietaria e di tre reti pubbliche per via politica significa la confisca del moderno agorà, lo spazio delicatissimo dove si svolge il moderno mercato del consenso. Che tutto ciò sia in mano di un solo soggetto politico, capo di un partito, della maggioranza parlamentare e del governo, altera di per sé questo mercato.
Le leggi ad personam – dobbiamo ancora vedere l´epilogo di quella fabbricata in questi giorni per Cesare Previti – sono un´altra alterazione, questa volta della regola base della democrazia, la separazione dei poteri. L´esecutivo attraverso il legislativo ha più volte, in questi anni, interferito con il giudiziario. Che poi alcune norme siano state inapplicabili o perché esistono ancora istituti di garanzia (la Corte, il Quirinale) o perché scritte male, come la legge sulle rogatorie, conferma soltanto che il diavolo è tradizionalmente più esperto in pentole che in coperchi. Ma Berlusconi sa che alcune prescrizioni a suo favore (come nel processo per falso in bilancio sul consolidato Fininvest) sono scattate grazie alle sue "riforme" legislative. E in ogni caso, proviamo a giudicare la questione da questo punto di vista: c´è un Paese dove il Capo del governo, imputato per reati gravissimi ma estranei alla politica, commessi secondo l´accusa prima di "scendere in campo", usa la maggioranza parlamentare per costruirsi uno scudo legislativo d´emergenza da usare nei processi in corso, immediatamente prima che i tribunali della repubblica si pronuncino con la sua assoluzione o la sua condanna. E´ un Paese normale, questo, oppure è anomalo per le abitudini dell´occidente?
L´anomalia, per concludere, non sussiste soltanto se accettiamo la cultura populista del decennio berlusconiano. In una concezione che io chiamo tecnicamente rivoluzionaria, il voto assegna un potere indiscusso e incontrollabile, una sorta di unzione, con la quale il popolo e il Capo entrano a far parte di un solo corpo mistico, mentre la nazione deve aderire a quel progetto politico come si accetta un destino. In questo schema, i controlli sono interferenze, gli istituti di garanzia sono intrusivi, la magistratura è un nemico, l´Europa è un inutile vincolo, la Costituzione è un vecchio libro ideologico. Persino i giornali, come rivela la lettera del Cavaliere, sono fastidiosi. Vendono poco? Ma perché il Capo del governo non si domanda come mai costino in Italia il doppio rispetto agli Stati Uniti, dove le aziende editoriali possono contare su un tetto alla pubblicità televisiva che in Italia (unico caso al mondo) raccoglie invece il 54 per cento del mercato totale, contro il 25-35 degli altri Paesi europei? Vendono magari poco (anche se seicentomila copie ogni giorno, per quanto ci riguarda, non sono poche) ma evidentemente danno fastidio, almeno alcuni, perché non sono controllabili come i telegiornali e i loro "panini".
Cosa concludere? Non so se il Cavaliere avesse retropensieri, chiedendo di aderire al "fondo" di De Benedetti. So che De Benedetti ha detto di no. E che Repubblica aveva già anticipato una cosa semplice: di non poter comunque cambiare giudizio sul berlusconismo, finché sussistono le quattro anomalie che rendono la nostra destra inaccettabile in Europa.
Il trionfo della rendita
Silvano Andriani su l'Unità 12 agosto
Di questi tempi si fa un gran discutere del capitalismo italiano, e a ragione considerate le misere performances della nostra economia. Bisognerebbe tuttavia distinguere tra i limiti propri del nostro sistema economico e talune tendenze generali del capitalismo contemporaneo. Per esempio, si lamenta che il valore dei beni patrimoniali aumenti più del reddito nazionale, ma questo è una tendenza mondiale. Se si bada ai dati, si vede benissimo dall'inizio degli anni 80.
Ovvero da quando Reagan e Thatcher avviarono la gran ristrutturazione neo-liberista, l'aumento del valore dei patrimoni sopravanza dappertutto la crescita del reddito nazionale.
Questa tendenza è stata più volte interrotta da crisi finanziarie ed esplosioni di bolle immobiliari, ma finora, tranne che in Giappone, è sempre ripresa, e dopo il crollo delle borse del 2001 è nettamente accelerato sopratutto nel settore immobiliare.
Si può certo parlare del trionfo della rendita, ma tenendo presente che quella tendenza origina da una distribuzione del reddito che dappertutto ha comportato la riduzione della quota di reddito destinata al lavoro produttivo ed un aumento della quota destinata alla remunerazione del capitale. Nel caso italiano il fenomeno è più accentuato poichè il reddito nazionale cresce meno e diventa più evidente l'apparente paradosso di un'economia che non cresce, ma genera alti profitti che per insufficienza di domanda interna non sono investiti per l'aumento della capacità produttiva e della produttività ma sono utilizzati per l'acquisto d'assets mobiliari ed immobiliari dei quali fanno aumentare i prezzi. Tali acquisti, nelle situazioni più organizzate, assumono la forma di scalate a società quotate. Ma né le scalate, né gli speculatori sono una prerogativa italiana; le scalate organizzate da speculatori negli USA erano molto di moda già negli anni '80, mentre negli anni '90 ne sono diventate protagoniste le grandi banche d'affari.
La tendenza delle imprese a finanziarizzarsi non è tipica dell'Italia. La serie di scandali societari statunitensi, e non solo, ha reso evidente la tendenza delle imprese a diventare conglomerate, in pratica a trasformarsi da organizzazioni specializzate nella produzione di determinati beni o servizi, la cui crescita graduale dipende dall'accumulo di nuove conoscenze nei propri campi d'attività, a centri specializzati nell'uso, anche molto spregiudicato, della leva finanziaria per entrare, attraverso acquisizioni e fusioni, rapidamente in nuovi mercati ed in diverse attività.
In questa storia tuttavia una specificità italiana esiste: quella tendenza da noi si è manifestata con molto anticipo. Negli anni '80, quando nel mondo, come risposta all'accelerazione del processo di globalizzazione, le imprese si concentravano sulla propria attività principale per eccellere ed internazionalizzarsi, le grandi imprese italiane si dettero ad acquistare in Italia le attività più disparate, i loro leader mostrarono una forte propensione ad agire come uomini di finanza piuttosto che d'industria e ne provocarono spesso la crisi. Ed ancora oggi ci tocca sorbire lezioni sul capitalismo da parte di qualche protagonista di quegli affondamenti.
Veniamo così ai nodi tipicamente italiani. Il primo è largamente noto e riguarda lo Stato: questo vuol dire un sistema politico instabile, immerso in un'infinita transizione, un debito pubblico enorme, un'amministrazione inefficiente in alcune parti importanti. Ma l'altro grande nodo riguarda il sistema delle imprese. In pratica il modo di fare impresa degli italiani nei decenni precedenti è entrato in crisi. L'area delle imprese pubbliche è stata drasticamente ridimensionata. Le grandi imprese private, tutte a controllo familiare, sono scomparse o andate in crisi. Le piccole imprese non sono adeguatamente evolute e mostrano crescenti difficoltà a tenere il passo della globalizzazione. La nascita di nuovi medi imprenditori di successo è una nota positiva, ma non sufficiente; inoltre anch'essi danno l'impressione di non resistere alla tentazione italiana di trasformarsi in uomini di finanza.
In questo quadro la nascita di nuovi raggruppamenti d'imprese controllati da coalizioni di investitori, tanto più se istituzionali, può rappresentare un sostanziale passo in avanti in un sistema d'imprese tradizionalmente contrassegnato dal controllo pubblico e familiare. La riorganizzazione del sistema bancario e finanziario è avvenuta tutta così e così sta avvenendo ancora, come dimostra il caso Unipol-Bnl, dove investitori societari si stanno alleando per realizzare il primo blocca banca- assicurazione in Italia, operazione sperimentata con successo in altri paesi europei.
Nel valutare le operazioni in corso bisognerebbe sforzarsi di distinguere gli speculatori, che ci sono e dappertutto, dagli investitori: quest'ultimi investono per realizzare dei progetti di lunga lena e le loro alleanze andrebbero valutate per la validità e la durata del progetto sulla base del quale si formano. In ogni caso chi governasse il paese dovrebbe proporsi di favorire l'evoluzione della conformazione del sistema delle imprese italiano e la formazione di una nuova generazione d'imprenditori e di managers.
Tutto ciò ci porta a parlare del sistema finanziario. Il sistema economico italiano è tradizionalmente considerato bancocentrico: in passato in quanto il credito alle imprese era fornito quasi tutto dalle banche e nel presente in quanto le banche controllano la gran parte del risparmio. Ma se si considera la capacità delle banche di intervenire nella nascita di nuove imprese, nell'evoluzione dei loro assetti proprietari, di esercitare, alcune funzioni imprenditoriali in appoggio allo sviluppo delle imprese, tale capacità era in passato inesistente ed oggi assai scarsa. Da questo punto di vista quelli anglosassoni, che sono considerati sistemi economici di mercato, sono invece assai più bancocentrici e sono prevalentemente banche anglosassoni che svolgono quelle funzioni anche a livello mondiale.
Chi fosse chiamato a governare l'Italia, paese con un enorme debito pubblico, ma con risorse finanziarie private ancora relativamente abbondanti dovrebbe proporsi di regolare la conformazione del sistema finanziario in modo da renderlo idoneo a convogliare adeguatamente le risorse verso l'economia reale e ad intervenire attivamente nell'evoluzione del sistema delle imprese.
La questione morale
Giovanni Sartori sul Corriere della Sera 13 agosto
Sappiamo da Machiavelli in poi che la politica è diversa dalla morale. Secoli dopo si è stabilito che anche l'economia è diversa dalla morale. Ma la distinzione tra etica, politica ed economia distingue tra sfere di azione, tra campi di attività. In concreto, e a monte di queste differenziazioni, esiste la singola persona umana che non è trina ma soltanto una, e che può variamente essere una persona morale, amorale o immorale. E quando si dibatte la "questione morale" è di questo che si dibatte, è da qui che si deve partire.
Le persone morali sono tali in tutto: anche in politica e anche in economia. Le persone amorali non promuovono il bene ma nemmeno si dedicano al male, anche perché sono fermate, nel malfare, da freni interiorizzati. Invece le persone immorali ridono dei cretini che credono nei valori e non sono fermate da nulla (o soltanto dal pericolo di finire in prigione). Per i primi non è vero che il fine giustifica i mezzi. Per i secondi il fine può giustificare qualche mezzo scorretto, ma non tutti. Per le persone immorali il fine di fare soldi o di conquistare potere giustifica qualsiasi mezzo: non c'è scrupolo, non c'è "coscienza" che li fermi.
Mio padre era un industriale il cui stabilimento venne distrutto dal passaggio della guerra nel 1944. Lui si incaponì nel tentativo di ricostruirlo per non lasciare i suoi operai — circa 400, che conosceva uno per uno — sul lastrico. Quel tentativo non poteva riuscire e difatti fallì. È che mio padre era una persona perbene, e io lo rispetto per questo. Ma è di tutta evidenza che per i vari Ricucci, Gnutti e Fiorani mio padre era soltanto un fesso. E ai loro occhi lo sono sicuramente anche io, visto che anche io cerco di essere una persona perbene.
Tanto le persone perbene quanto le persone "permale" esistono sempre e ovunque. Ma la crisi dell'etica che contraddistingue il nostro tempo ne ha modificato le distribuzioni. I perbene diminuiscono, i "permali" crescono. Inoltre i perbene restano a terra, i "permali" salgono e comandano. Infine sta sempre più dilagando un intreccio perverso tra economia e politica. E la questione morale è la denunzia di questo andazzo. Ma perché scoppia ora? E perché la questione morale è più grave in Italia che altrove? Scoppia ora, rispondo, perché tardi è meglio che mai; e scoppia ora perché i neo-pescecani di assalto del capitalismo speculativo sono finalmente stati scoperchiati. Finora i vari Ricucci, Fiorani e Gnutti l'avevano fatta franca; ma ora sono indagati per insider trading, aggiottaggio, falso in bilancio, falso in prospetto, abuso di ufficio, e altro ancora. Aggiungi l'aggravante che su tutto questo andazzo aleggia l'ombra lunga e sempre sospetta di Berlusconi. Il cattivo esempio e il contagio vengono da lui. Come scrive Ilvo Diamanti su Repubblica, con il berlusconismo non c'è più "scandalo che riesca a scandalizzare", ed "è dilagato un profondo disincanto. La convinzione che tutto è lecito. Basta non farsi scoprire. L'evasione fiscale... il ricorso alle relazioni informali e amicali. In ogni campo, in ogni occasione. Il senso cinico ha avvolto e logorato il senso civico". Il che ci lascia con "un Paese soffocato dal sottobosco, con la città cinica retta dalla tribù dei più furbi". Non si potrebbe dire meglio. Il nostro è ormai un Paese sporco, molto sporco.
Sono un moralista? Sì, ma non perché faccio confusione tra etica e politica; lo sono in quanto sostengo che deve esistere una moralità politica e, alla stessa stregua, una moralità economica; e che in tutti i settori della vita associata devono esistere regole che le persone perbene rispettano. Appunto, le persone perbene.
La mia colpa?
Gian Carlo Caselli su Liberazione 7 agosto
E' ufficiale: lassù qualcuno non mi ama. E ha fatto di tutto per impedirmi di partecipare al concorso per la nomina del nuovo Procuratore nazionale antimafia. Trascinato mio malgrado in una viscida querelle, non mi è facile intervenire. Ma poiché sono convinto che non si tratta di questioni personali, ma di ben altro, provo a farlo. Con tutti in rischi che la scelta comporta.
Punto di partenza della riflessione non può che essere il nuovo ordinamento giudiziario. Chiunque abbia occhi per vedere sa che vero obiettivo della controriforma non è la giustizia ma sono i giudici: quelli colpevoli di aver fatto il loro dovere non solo verso i deboli e gli emarginati, ma anche verso le deviazioni del potere, perciò da sottoporre a controllo ad opera di un potere politico che per se stesso di controlli non ne accetta.
Ecco quindi che il nuovo ordinamento traccia un percorso ad ostacoli per chi voglia accertare la verità senza soggezioni diverse dalla legge: reclutamento e progressione in carriera congegnati in modo da favorire chi è "omogeneo"; svuotamento dei poteri del Csm con conseguente indebolimento della sua funzione di tutela dell'indipendenza della magistratura; esercizio dell'azione penale riservato ai soli Procuratori della Repubblica, veri "mandarini" della giustizia; previsione di forme, indirette ma incisive, di controllo politico del Governo sull'attività giudiziaria; predisposizione di una "autostrada" che inesorabilmente porterà alla separazione delle carriere: tutto "congiura" - nella controriforma - perché lo stigma del magistrato modello sia il conformismo, nemico giurato della rigorosa ( e spesso scomoda) ricerca della verità.
Sono convinto - immodestamente, lo confesso - che il cosiddetto "caso Caselli" vada proiettato su questo scenario più vasto, nel senso che l'emendamento Bobbio (da costui pubblicamente ricollegato all'obiettivo specifico di impedirmi di concorrere alla carica di Procuratore nazionale antimafia) è un segmento del tentativo di "sterilizzare" l'indipendenza della magistratura che caratterizza la controriforma. Prima dell'emendamento c'era stato addirittura un decreto legge. Con il decreto e con l'emendamento si sono poi intrecciate varie iniziative, tutte finalizzate ad influire pesantemente sul regolare svolgimento dei concorsi banditi dal Csm, col rischio non solo di viziare la procedura ma anche di mettere a repentaglio la serenità del relativo giudizio.
Con un "volume di fuoco" senza precedenti nella storia della Repubblica, si sono - in corso d'opera - più volte sovvertite le regole stabilite. I "garantisti" come Giuliano Pisapia dovrebbero - io credo - prima di tutto inorridire per questo. E poi provare a chiedersi perché mai vi sia stato e vi sia tanto accanimento da arrivare al punto di inventarsi decreti legge, emendamenti "contra personam" e via bombardando… Evidentemente la "vittima" designata di questa forsennata campagna non gode delle simpatie di coloro che hanno votato la controriforma dell'ordinamento giudiziario.
Difficile pensare che tale antipatia sia ricollegabile alle centinaia di ergastoli e all'infinità di anni di reclusione che la procura di Palermo diretta da Caselli (che ha semplicemente operato, dopo le stragi, com'era dovere di qualunque magistrato: nessun "merito" da rivendicare, quindi, se non il normale adempimento dei propri compiti istituzionali) ha contribuito a far infliggere ai mafiosi dell'ala militare di Cosa nostra.
Oppure ai 10.000 miliardi di vecchie lire che rappresentano l'ammontare complessivo dei beni sequestrati ai mafiosi dal 1993 al 1999. Sono risultati, questi, che non interessano certi commentatori. Quel che non si perdona, invece, è il rigore con cui quella Procura - nel rispetto delle regole - è andata oltre l'ala militare. Con il risultato che numerose sentenze, alcune definitivamente confermate dalla Cassazione, hanno (per la prima volta con tanta ampiezza e precisione) univocamente dimostrato la sussistenza di fatti gravissimi a carico di soggetti appartenenti alla borghesia politica, imprenditoriale e professionale (settori che da sempre, secondo le analisi più accreditate, hanno avuto un ruolo centrale nella storia della mafia). Fatti, non teoremi. Fatti non inventati ma realmente accaduti (come riconoscono tutte, proprio tutte, le motivazioni delle sentenze, quale che sia il loro dispositivo). Fatti che era obbligatorio perseguire e portare a giudizio, se la legge (ne sono ancora convinto, anche se mi costa tanti guai…) deve essere uguale per tutti. Fatti che avrebbero potuto innescare concreti percorsi di “bonifica politico-morale”, prosciugando finalmente l'acqua in cui nuota il pescecane mafioso.
Invece, pur di scongiurare il salto qualitativo nell'azione di accertamento dei legami e delle collusioni con Cosa Nostra, c'è chi ha preferito una strategia rinunciataria, articolata in particolare sull'accusa a pubblici ministeri e giudici di costruire teoremi per ragioni politiche o, più brutalmente, di essere “comunisti” o “toghe rosse”. Di qui la celebrazione di un vero e proprio “processo” alla stagione che ha seguito le stragi del '92: con tanto di commentatori più o meno autorevoli pronti a pronunziare verdetti di presunto fallimento, deliberatamente ignorando i risultati investigativi e processuali ottenuti ed anzi ricorrendo ad un massiccio stravolgimento della verità o alla sua “cancellazione” (leggere le sentenze e partire da questi dati di fatto è ormai un lusso per pochissimi…). E' troppo ipotizzare che la verità e certa politica siano non perfettamente compatibili? Che autoassolvendosi in perpetuo (o addirittura pretendendo di esser sottratta al controllo di legalità) certa politica voglia sfumare la linea di confine fra lecito ed illecito, fra morale ed immorale? E' troppo presuntuoso (magari anche un po' arrogante…) ipotizzare che a forza di regolari beatificazioni di imputati, ancorché responsabili - a livello penale o politico-morale - di fatti gravissimi, e di altrettanto regolari aggressioni ai magistrati che non si decidono a chinare la testa, tutto questo possa poi avere uno sviluppo “coerente” in controriforme ed emendamenti “contra personam”? E' azzardato ipotizzare che mi si voglia far pagare la colpa di essere stato coerente con i miei doveri, non disponibile ad aggiustamenti o compromessi? Non so se questa coerenza sia assimilabile al “giustizialismo”, ma se così fosse sarei un “giustizialista” orgoglioso di esserlo stato. Comunque sia, la posta in gioco riguarda le regole. Le persone (e le legittime preferenze di ciascuno per questo o quel candidato) vengono in secondo piano. Salvo che non si voglia fare come gli struzzi…
L'italianita' offesa
Mario Monti sul Corriere della Sera 12 agosto
Le recenti vicende finanziarie italiane offrono all'opinione pubblica internazionale uno spettacolo che umilia il nostro Paese. Sono vicende che — maneggiate da pochi nell'ombra dietro il paravento della difesa dell'italianità, suggestione alla quale all'inizio credettero in molti — recano grave offesa all'italianità di noi tutti. E nel modo più insidioso, cioè regalando alcuni riscontri oggettivi a quella scarsa considerazione che spesso circonda l'Italia: poca affidabilità, applicazione elastica delle norme, con ampi margini per l'arbitrio, le influenze politiche, i rapporti familiari e di amicizia. In presenza di tali riscontri — e in assenza di un rigetto tempestivo, energico ed unanime da parte del mondo politico ed economico — sarà più difficile per noi italiani parlare di "pregiudizi" contro di noi.
C'è un danno ancora più grave. È colpita non solo l'immagine dell'Italia agli occhi del mondo, ma anche l'immagine dell'economia di mercato agli occhi degli italiani. Dopo queste vicende sarà ancora più difficile far avanzare risolutamente l'Italia sulla via di una moderna economia di mercato, come è necessario per la crescita e la competitività ben oltre un pur confortante risultato trimestrale. Un tale progetto, come si è potuto constatare in questi anni, non è certo un'idea-forza del centrodestra ed è anzi osteggiato da alcune sue componenti. Quanto al centrosinistra, non è emerso finora un programma articolato in tale direzione, che peraltro è anche in questo caso osteggiata da alcune componenti. Forse un centro, se esistesse, avrebbe una più credibile affinità con un progetto del genere, ma una simile ipotesi sembra sollevare una serie di altri problemi (che superano la mia capacità di comprensione).
Su questo humus politico non propizio, dopo le recenti vicende finanziarie vi è il rischio che anche la gente non abbia tanta voglia di vedere in Italia più economia di mercato. Probabilmente il cittadino comune percepisce che il mercato è una cosa scomoda, che sarebbe più confortevole esserne al riparo, dietro questa o quella protezione; ma capisce che se c'è mercato c'è più efficienza, tutti si sforzano di più e in definitiva c'è più benessere. Però intuisce che questo meccanismo funziona — e vale la pena di appoggiarlo, anziché chiedere solo protezione — se c'è un minimo di serietà: il mercato deve premiare il merito, non deve portare gli uni a ricchezze illimitate e gli altri alla fame, deve esserci un arbitro imparziale, che vigila sul rispetto delle regole.
Mettiamoci nei panni del cittadino che ha letto i giornali o visto la televisione in queste settimane. Avrà capito che in quello che dovrebbe essere il mercato con la M maiuscola, il mercato finanziario, girano grandi capitali. Per molti di essi non è chiaro quale sia stato il "merito" che li ha generati. Quando lo si sa, si vede che spesso il "merito" è stato quello di aver saputo sfruttare con intelligenza le opportunità di "rendite" disponibili in certi settori. Un comportamento di per sé legittimo. Ma in una moderna economia di mercato si cerca di ridurre quelle opportunità, tutelando e promuovendo la concorrenza, così da indurre i capitali ad investimenti che siano produttivi per l'insieme dell'economia, per le esportazioni, per l'occupazione. E si interviene con la politica fiscale per rendere il gioco del mercato — soprattutto finché sussistono rendite rilevanti — compatibile con un'accettabile distribuzione del reddito.
E l'arbitro imparziale, che vigila sul rispetto delle regole del mercato? Qui si resta davvero senza parole. Già il cittadino italiano, per atavica inclinazione, ritiene di solito — sbagliando, credo, nella gran parte dei casi — che non vi sia un "potere pubblico" capace di essere imparziale. Che cosa penserà, dopo ciò che legge sulla più prestigiosa e rispettata tra le autorità arbitrali? "Se questo è il più perfetto dei mercati — dirà tra sé, in definitiva, il nostro lettore o telespettatore — non vengano a raccontarmi che in Italia bisogna dare più spazio al mercato! Grazie, basta così".
Ecco come ci troviamo, dopo avere assistito a un virtuosismo della via nazionale (v e n minuscole) alla difesa dell'italianità. Derisi da una comunità internazionale incredula. E qualche passo più indietro di prima, sulla via di una moderna economia di mercato. C'è di che rimboccarsi le maniche, soprattutto in una fase in cui quello che è stato per decenni il principale motore di modernizzazione dell'economia italiana, l'integrazione europea, è quanto meno in panne.
Per chi tifa Repubblica?
Editoriale su Il Foglio 11 agosto
Roma. Per chi fa il tifo la Repubblica? A chi augura la conquista del Corriere della Sera? Per chi trepida davvero, la notte, prima di dormire, mentre si appunta le battaglie di libertà, laicità e democrazia da combattere il giorno dopo? E' il momento di scegliere da che parte stare: con il partito del Corriere o con il partito del Quartiere, anzi “del quartierino”, come direbbe Stefano Ricucci, principe degli scalatori? Con l'establishment che già regna su via Solferino o con i nuovi barbari, quelli dai tratti antropologici studiati da Lina Sotis (“colpisce in questa situazione la romanità della situazione, gli ahò che emergono dalle intercettazioni: questa romanità è un fatto assolutamente politico”), da Diego Della Valle (“un ragazzotto presuntuoso… evito polemiche da parrucchiere”), da Luca Cordero di Montezemolo, ora idolo dell'Unità (“Ricucci assomiglia a uno dei personaggi dei film di Vanzina”). Bisogna scegliere, ma la Repubblica è un'anima spezzata in due, tra speranza e indignazione, tra purezza e godimento. Gli affari coi barbari del quartiere, è ovvio, non si dovrebbero fare, anche se Carlo De Benedetti, l'editore santo e puro, di affarucci ne fa parecchi, per esempio nella Banca Intermobiliare, sia con il salotto buono di Montezemolo sia con i nuovi ricchi come Danilo Coppola, quello coi capelli ancora più lunghi di Ricucci. Ne avrebbe realizzati parecchi altri, per la verità, ma la Repubblica ha detto no, fermo, qui decidiamo noi. E ora che si è levata dall'incubo degli insostenibili patti con il Cav., ora che l'ortodossia antiberlusconiana è salva, ora la Repubblica spera moltissimo (ma segretamente) che il quartierino ce la faccia. Che scali. Che vinca. Che espugni con un gran calcio la fortezza del Corriere, e lo svuoti di ogni forza. Perché Repubblica è nata contro il Corriere, è cresciuta contro il Corriere, si batte contro il Corriere per dirigere l'orchestra culturale italiana. Se il Corriere crolla sotto i colpi dei parvenu, se dal Corriere si fugge, si fugge verso la Repubblica. Giovanni Sartori l'ha annunciato proprio su quelle pagine: “Se arriva Ricucci è certo che me ne vado”, e lo stesso ha fatto Enzo Biagi sull'Unità. La Repubblica non deve far altro che gironzolare loro intorno, in attesa. Come accadde quando il Corriere della Sera fu scardinato e commissariato per la P2 di Licio Gelli. “Se ne andarono tutti – ricorda un corrierista importante – Umberto Eco, Alberto Ronchey, Enzo Biagi, e andarono ovviamente a Repubblica, che diventò il primo giornale italiano: fu quello un momento di grande fulgore e la speranza, adesso, è la stessa di allora”. Camuffata, ovviamente, da preoccupazione per la libertà di stampa, di cui Repubblica si fregia di rappresentare il centro, il fulcro, la massima e migliore espressione. “Anche noi, per quanto è in nostro potere, cerchiamo di contribuire all'autonomia giornalistica del Corriere della Sera – ha scritto il Fondatore Eugenio Scalfari domenica scorsa, nella epocale lettera in cui ringrazia De Benedetti per l'obbedienza deferente nel rinunciare per sempre agli affari con Berlusconi e nel chiedere, soprattutto, pubblicamente scusa per avere osato tanto – che, esso sì, è esposto al rischio di invasioni da dentro e da fuori dell'assetto proprietario esistente”.
Il nipotino di Scalfari
A Repubblica adesso si sentono forti come non mai (“e lo siamo, infatti, siamo fortissimi”, dicono da dentro, “e il Corriere in difficoltà è una pacchia”), perché la rinuncia di De Benedetti ha dimostrato che nessuno può nulla, nemmeno l'editore (“Caro Carlo, caro amico nostro, la lettera che ci hai inviato ti rende piena giustizia e rafforza in noi affetti e fiducia” ha scritto Scalfari dall'alto del club dei saggi; e ha scritto come si scrive a un nipotino con le calze corte e le idee bizzarre, a cui si tiene il guinzaglio lungo). Sono così forti, si sono talmente autoconsacrati garanti della libertà di stampa che ora possono fingere di scatenarsi contro il quartierino (e intervistare, lo stesso giorno, Diego Della Valle e Luca Cordero di Montezemolo, del salotto buono). Possono mostrare felicemente e senza imbarazzo tutto l'orrore per gli invasori (e chiudere un occhio sulla Mediobanchina o sorvolare su Emilio Gnutti e Giovanni Consorte). Pubblicano con orgoglio le intercettazioni che riguardano il giornale, Ricucci al telefono: “Repubblica dice un sacco di baggianate”, “Repubblica è l'unica che non si è fatta viva”, “Voglio chiamare Repubblica per capire cosa devo dire per fargli scrivere un bel pezzo”, mostrano di battersi per il partito del Corriere, di soffrire per la sporcizia che accerchia il grande giornale. “La libertà di stampa siamo noi”, gridano a Repubblica, e anzi tutto questo chiasso intorno alla minacciata libertà del Corriere un po' li infastidisce, perché mantiene al centro del mondo laico, libero e democratico via Solferino e non Largo Fochetti. Ma la notte, quando si mettono a punto le battaglie del giorno dopo, a Repubblica si libera il tifo: “Forza Ricucci, facce sognà”.
Perché i kamikaze portavano il casco?
Umberto Eco su L'espresso
Tempo fa, certamente prima dell'undici settembre fatale, tra i vari giochi d'Internet circolava la domanda perché i kamikaze (quelli giapponesi) portassero il casco - cioè, perché mai delle persone che stavano per andare a schiantarsi su una portaerei si proteggessero la testa. Portavano davvero il casco? Non si mettevano una benda rituale intorno alla fronte? In ogni caso le risposte suggerite dal buon senso sono che il casco serviva anche per volare senza essere assordati dal motore, per difendersi da eventuali attacchi prima di poter dare inizio alla picchiata mortale e sopratutto (credo) perché i kamikaze erano tipi che osservavano rituali e regolamenti, e se i manuali dicevano che in aereo si saliva col casco loro obbedivano. A parte lo scherzo, la domanda tradiva l'imbarazzo che ciascuno di noi prova di fronte a chi freddamente rinuncia alla propria vita per poter uccidere altre persone.
Dopo l'undici settembre noi pensiamo (giustamente) ai nuovi kamikaze come a un prodotto del mondo musulmano. Questo induce molti all'equazione fondamentalismo-Islam, e consente al ministro Calderoli (che vedo sempre volentieri sugli schermi sembra un collega d'ufficio di Fantozzi) di dire che questo non è uno scontro di civiltà perché 'quegli altri' non sono una civiltà. Oltretutto gli storici ci dicono che, nel Medioevo, una variante eretica dell'islamismo praticava l'omicidio politico col sicario inviato a colpire sapendo che non sarebbe tornato vivo, e la leggenda vuole che il kamikaze dell'epoca fosse dovutamente trattato, per renderlo succube dei suoi mandanti, con lo hashish (da cui la Setta degli Assassini). È pur vero che gli informatori occidentali, da Marco Polo in avanti, avevano un poco esagerato sulla faccenda, ma sul fenomeno degli Assassini di Alamut ci sono anche studi seri che forse andrebbero riletti.
Però in questo periodo trovo in Internet una vasta discussione intorno al libro di Robert Pape, 'Dying to win. The strategy and logic of suicide terrorism', che, sulla base di una vasta documentazione statistica, contiene due tesi fondamentali. La prima è che il terrorismo suicida nasce solo in territori occupati e come reazione all'occupazione (tesi forse discutibile, ma Pape mostra come il terrorismo suicida si sarebbe arrestato, per esempio in Libano, appena terminata l'occupazione). La seconda è che il terrorismo suicida non è fenomeno solo musulmano, e Pape cita le Tigri Tamil dello Sri Lanka, e ventisette terroristi suicidi in Libano, tutti non islamici, laici e comunisti o socialisti.
Non ci sono stati soltanto kamikaze giapponesi o musulmani. Gli anarchici italo-americani che avevano pagato il viaggio a Bresci perché andasse a sparare a Umberto I, gli avevano comperato un biglietto di sola andata. Bresci sapeva bene che dalla sua impresa non sarebbe tornato vivo. Nei primi secoli del cristianesimo c'erano i Circoncellioni, che assalivano i viandanti per avere il privilegio del martirio, e più tardi i Catari praticavano quel suicidio rituale che si chiamava 'endura'. Per arrivare infine alle varie sette dei giorni nostri (tutte del mondo occidentale), sulle quali ogni tanto si legge di intere comunità che scelgono il suicidio di massa (e chiederei agli antropologi di raccontarci di altre forme di suicidio 'offensivo' praticato in altri gruppi etnici nel corso dei secoli).
Insomma, la storia (e il mondo) sono stati e sono pieni di persone che per religione, ideologia, o qualche altri motivo (e certamente aiutati da una struttura psicologica adatta, o sottoposte a forme di plagio molto elaborate) sono state e sono pronte a morire per ammazzare. C'è quindi da domandarsi se il vero problema che dovrebbe suscitare l'attenzione e lo studio di chi è preposto alla nostra sicurezza non riguardi soltanto il fenomeno dell'islamismo fondamentalista, ma il problema psicologico del suicidio offensivo in generale. Non è facile convincere una persona a sacrificare la propria vita, e l'istinto di conservazione ce l'hanno tutti, islamici, buddisti, cristiani, comunisti e idolatri. Per superare questo istinto non basta l'odio per il nemico. Bisognerebbe capire meglio quale è la personalità del kamikaze potenziale. Voglio dir che non basta frequentare una moschea dove un imam assatanato predica la guerra santa per diventare kamikaze, e forse non basta chiudere quella moschea per assopire la pulsione di morte che probabilmente preesiste in certi soggetti - che continuerebbero a circolare.
Come andare a individuare questi soggetti, con quale tipo di indagine e sorveglianza, che non diventi un incubo per qualsiasi cittadino, è difficile dire. Ma forse bisogna lavorare anche in questa direzione e chiederci se questa pulsione non inizi ad essere una malattia del mondo contemporaneo (come l'Aids o l'obesità) che potrebbe manifestarsi anche presso altri gruppi umani non necessariamente musulmani.

 14 agosto 2005
14 agosto 2005
![]() 14 agosto 2005
14 agosto 2005