



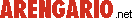
sulla stampa
a cura di P.C. - 24 dicembre 2003
Fazio: Bankitalia senza colpe
Ma ora rafforzare la Consob
Massimo Giannini su la Repubblica
"Sono sereno. Sereno sul piano personale, sereno per l'attività dell'Istituto, e sereno anche per la tenuta del mercato...". In questa burrascosa vigilia delle feste di fine d'anno, Antonio Fazio non si scompone. Si tiene accuratamente fuori dalla folta schiera di quelli che "lanciano allarmi". Il governatore della Banca d'Italia preferisce lanciare messaggi rassicuranti: "C'è persino chi ha detto che starei per dimettermi. Ma certe voci non mi toccano proprio, sono solo manovre destabilizzanti...". E ci tiene a lanciare un appello: "Nessuno sottovaluta le crisi Cirio e Parmalat. Tuttavia, è dovere di tutti noi cercare di mantenere la calma e la ragionevolezza. Solo così sarà possibile, e auspicabile, tirar fuori qualcosa di buono da queste vicende...". "Queste vicende" sono quelle che il ministro del Tesoro Giulio Tremonti ha ribattezzato come le "Enron italiane".
E "qualcosa di buono", dal punto di vista di Via Nazionale, non è la nuova "Authority per il risparmio", che per ora è stata accantonata dal governo. "Qualcosa di buono", per Via Nazionale, è invece il rafforzamento dei poteri di vigilanza esistenti sul mercato azionario. I poteri attribuiti alla Consob, che "è l'unico organismo a cui spetta il controllo delle società".
Osservato dall'interno, respirata la sua atmosfera, ascoltati i suoi vertici, Palazzo Koch non ha l'aria del Palazzo d'Inverno che la politica si prepara ad espugnare. E Fazio, che pure sa di essere al centro di quello che Cesare Geronzi ha ribattezzato come "il tiro al piccione", non ha l'aria preoccupata di chi si sente una "preda". Nel suo ufficio al primo piano tutto è immutato. Il solito San Sebastiano trafitto sulla parete alle sue spalle, i soliti libri di finanza e di patristica medievale, il solito terminale acceso sui cambi minuto per minuto, i soliti divani di cuoio marrone, le solite foto in cornice: il Papa, Modigliani, una stretta di mano con Ciampi. Anche il governatore è il "solito".
Completo blu da banchiere centrale, con panciotto d'ordinanza. Toscano acceso, poi spento, poi riacceso. È tranquillo. Anche in queste ore difficili, che malgrado tutto vedono lui e la sua Banca d'Italia sul banco degli accusati per il default del gruppo di Cragnotti e, adesso, anche per lo scandalo dell'impero di Calisto Tanzi. Che faceva la Banca d'Italia, quando questi nostri "capitalisti" emettevano obbligazioni-spazzatura degne dei junk-bonds americani, o truccavano i bilanci "fotocopiando persino i soldi" come dicono gli inquirenti che stanno indagando a Parma?
Di fronte a queste domande spinose, Fazio non si tira indietro. Si accomoda sulla sua poltrona, congeda per un po' la sua segretaria, l'onnipresente signora Martini, e comincia a parlare. La Banca d'Italia era al suo posto come sempre, dice. E scinde la questione, nei suoi diversi aspetti. Il primo è l'aspetto normativo.
"Tutto nasce dalla debolezza della Consob, e dall'inadeguatezza della disciplina del mercato azionario e obbligazionario", osserva. Fazio non vuole gettare la croce addosso alla Commissione guidata da Lamberto Cardia. Anzi, considera "molto spiacevole, questo reciproco scarico di responsabilità tra gli organismi di Vigilanza, innescato purtroppo dal clima di strumentalizzazione politica". Tuttavia il governatore, Testo unico delle leggi bancarie alla mano, è fermamente convinto che in casi come quello della Cirio e della Parmalat "il controllo spetta alla Consob, che non per caso si chiama Commissione di vigilanza sulle società e la Borsa. Se il sistema di controlli che la Consob può svolgere fosse più stringente e più penetrante, molti problemi sarebbero risolti...".
È questo, secondo il numero uno di Via Nazionale, che fino ad oggi non si è voluto capire: la Banca d'Italia vigila sulla stabilità del sistema bancario, del quale Fazio si dice "assolutamente soddisfatto". Conferma che anche nelle vicende del collocamento dei bond "gli accertamenti ispettivi effettuati finora hanno confermato che, "negli atti", non si sono segnalati casi di irregolarità formale". Può esserci stato qualche singolo caso di "scorrettezza morale" da parte di qualche funzionario del singolo istituto. Ma questa "è una situazione completamente diversa" da come qualcuno, a livello politico soprattutto, ha voluto finora descrivere il caso Cirio. È una situazione che non prefigura affatto "una crisi di sistema". E non sembra configurare nemmeno una "culpa in vigilando" da parte di Bankitalia.
…
Ma anche sullo scandalo Parmalat, i vertici di Palazzo Koch si sentono inattaccabili. Le banche italiane non hanno responsabilità specifiche. Se ce ne sono, riguardano principalmente le banche estere. E comunque, di nuovo, è in ballo la tutela del mercato azionario. "Il controllo riguarda l'emittente dei titoli, perché il rischio è diretto", osserva Fazio. E così si ripropone il problema della Consob. Al governatore si può obiettare il "diverso parere" di Lamberto Cardia, che in un'intervista al Sole 24 Ore ha affermato: "Se la legge ci avesse consentito di accedere alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, probabilmente la Consob si sarebbe accorta in anticipo" dei guai del gruppo di Collecchio. Fazio, sia pure senza fare polemiche, scuote il capo, si riassesta sulla sua poltrona, e respinge l'addebito. "Noi, alla Consob, abbiamo sempre dato il massimo della collaborazione, ed abbiamo sempre fornito tutte le informazioni possibili. Certo, i dati della Centrale dei rischi sono riservati, sono cifre che la banca comunica ad altre banche su basi "private"". E comunque, precisa il governatore, "anche in base ai numeri della Centrale dei rischi, la valutazione sulla Parmalat non sarebbe potuta cambiare...".
Sembra un'auto-assoluzione, ma dall'osservatorio di Via Nazionale non c'era nulla che potesse far pensare che nei bilanci di quel gruppo potessero nascondersi tanti buchi neri. "Da quel che mi diceva un banchiere pochi giorni fa, se solo sei mesi fa qualcuno avesse proposto Calisto Tanzi come l'imprenditore italiano dell'anno nessuno, ma proprio nessuno avrebbe avuto nulla da eccepire...". E invece, in pochi giorni, è arrivato il tracollo. "L'impressione è che, ad un certo punto della sua parabola imprenditoriale, le cose siano diventate più grandi di lui, e gli siano sfuggite di mano...". Fazio punta il dito sui controlli interni, sul management, sui revisori dei conti. Ma in queste ore c'è chi punta il dito sulla Banca d'Italia, oltre che per l'omessa vigilanza, anche per un altro risvolto della vicenda: è mai possibile che a Via Nazionale non scatti l'allarme, di fronte a un gruppo industriale con un indebitamento così elevato? Il governatore accenna un sorriso. Prende un fiammifero, si riaccende il toscano, e risponde misurando le parole: "Vede, anche su questo si è fatta molta, troppa confusione.
L'indebitamento va visto sempre in proporzione all'attività industriale e al fatturato. Nel caso della Parmalat non c'era nessun allarme da lanciare, perché il gruppo rientrava ampiamente nei "ratios" previsti dalla Vigilanza. Nella concessione dei grandi fidi è fissato un limite del 25% al rapporto tra debiti e patrimonio, e Parmalat era ampiamente al di sotto". Insomma, con questo quadro normativo la voragine della Parmalat era quasi "imponderabile".
A questo punto, chiarite le insufficienze legislative in materia di controlli, il governatore apre un altro capitolo. Queste brutte storie da capitalismo di ventura, osserva, hanno anche "un'altra origine". "Qui si parla di bilanci falsi. Di documenti contabili manipolati. Quando ci sono bilanci falsi, il mercato non funziona. Non può funzionare. Mai come oggi - riflette Fazio - si pone un problema di rapporti tra etica ed economia. L'ho ribadito pochi giorni fa, e purtroppo sono stato buon profeta...".
…
Quello che serve a ridare fiducia al nostro mercato, secondo il "custode" di Via Nazionale, è "un rigoroso rafforzamento dei poteri ispettivi, di prevenzione e di controllo, sui bilanci delle società". In altre parole, Fazio condivide le richieste formulate al governo da Cardia: si diano più poteri alla Consob in materia di vigilanza sulle imprese non finanziarie. Si adotti il modello della Sec statunitense, che può sequestrare atti e documenti contabili, mentre il controllo delle banche e delle holding finanziarie è strettamente riservato alla Federal Reserve. Ma urge anche un intervento sul fronte delle procedure internazionali. "Abbiamo fatto la liberalizzazione dei mercati - ragiona il governatore - ma non abbiamo unificato le normative fiscali. Così la rete della vigilanza diventa più perforabile, e finché ci saranno le società offshore controllare fino in fondo sarà quasi impossibile. Fare vigilanza in un sistema chiuso è facile, ma in un sistema aperto è molto più difficile, se manca un'armonizzazione normativa con gli altri Stati e un sistema più vincolante di collaborazione tra le vigilanze dei diversi paesi".
…
Quanto è il buco, 8 o 12 miliardi?
Prime tracce del "bottino" Parmalat
Vittorio Malagutti sul Corriere della Sera
MILANO - La chiamano la fase due dell'inchiesta. Obiettivo: il bottino. Centinaia di milioni, forse miliardi di euro, sottratti alle casse della Parmalat grazie a quella che ormai appare come la più grande truffa della storia d'Italia. In questi giorni concitati gli investigatori stanno cercando di capire in che misura il dissesto è servito anche ad arricchire qualcuno che stava ai vertici del gruppo di Collecchio. E' un'indagine a dir poco complicata, ma ci sono già alcuni spunti concreti. Ancora una volta tutto parte dal famigerato fondo Epicurum delle isole Cayman, quello che, a novembre, ha fatto da detonatore allo scandalo. E le tracce del denaro conducono fino a un altro paradiso fiscale, decisamente meno esotico, come il Lussemburgo. Proprio qui, circa un anno fa, Calisto Tanzi ha costituito una nuova finanziaria, la Satalux. Alcune operazioni transitate dalla finanziaria Satalux del Granducato potrebbero fornire una traccia per capire dove sono spariti i soldi. Già, perché ci vorranno settimane, forse mesi, per tirare le somme della catastrofe Parmalat. Magistrati, investigatori della Guardia di Finanza, periti contabili dovranno spulciare a lungo le carte del gruppo emiliano (quelle che non sono state preventivamente distrutte) per accertare le dimensioni del buco. Sette miliardi di euro, otto, nove e, chissà, forse 10 o 12 miliardi. Nessuno, neppure chi l'ha creata, sembra in grado di dire con una qualche accettabile approssimazione quanto denaro sia scomparso dalle casse della multinazionale di Collecchio.
Proprio per questo appare davvero complicata la fase due dell'inchiesta. Ovvero stabilire dove sono finiti i soldi, trovare l'origine e la destinazione dei mille rivoli di denaro che nel corso degli anni sono stati sottratti alla Parmalat. Molto denaro, semplicemente, non è mai esistito: pura invenzione contabile. In parte i bilanci sono stati taroccati per coprire le perdite di aziende del gruppo, in particolare in Sudamerica, negli Stati Uniti, in Canada e in Sudafrica. Poi ci sono le speculazioni finanziarie sbagliate: sulle valute, sui tassi d'interesse, con tutto l'armamentario classico degli strumenti derivati.
Ancora non basta, però. Non è umanamente possibile, anche nel corso di molti anni, riuscire a perdere, nella migliore delle ipotesi, sette miliardi di euro, quasi 14 mila miliardi di vecchie lire, solo con l'industria e la finanza. "No, non può essere", si ripetono in queste ore gli investigatori, attoniti, più che stupiti, dall'enormità della vicenda. E allora il sospetto è che qualcuno, anno dopo anno, abbia prelevato, come fosse un bancomat, centinaia e centinaia di milioni di euro da quella che era un'azienda modello del made in Italy.
D'altra parte era un gioco da ragazzi. In una rete pressoché infinita di società off shore, domiciliate nei più diversi paradisi fiscali (Malta, Cayman, Antille olandesi, British Virgin Islands, Lussemburgo, Irlanda, Uruguay) tutte sotto l'ombrello della capogruppo Parmalat finanziaria, c'era solo l'imbarazzo della scelta sulle procedure da adottare per far sparire i soldi. Anche perché alla Parmalat amavano le scorciatoie. Perché perdersi in complicati castelli finanziari quando basta dare sfogo alla fantasia? Non per niente, il vertice della tesoreria del gruppo, a cominciare dal cassiere capo Fausto Tonna, si era specializzato nella produzione di documenti falsi.
Facile capire, a questo punto, perché l'ipotesi che esista un bottino nascosto da qualche parte sia ormai ben più che un sospetto. E infatti alcune operazioni finanziarie sembrano confermare le supposizioni degli investigatori. Piccole cose, per adesso. Semplici elementi di un puzzle ben più vasto che va ricomposto tassello per tassello.
Parte proprio da qui, però, la pista del denaro, quella che può portare a capire dov'è finito il bottino della truffa più grande della storia d'Italia. E allora torniamo in Lussemburgo, alla finanziaria Satalux, nata il 20 dicembre del 2002. A fondarla è la famiglia Tanzi tramite la Sata, una società di Parma controllata da Calisto Tanzi e presieduta da Tonna. Ebbene, risulta dalle indagini che alcuni milioni di euro provenienti da Epicurum siano stati trasferiti sui conti della Satalux. Epicurum a sua volta è stato finanziato dalla Parmalat. Quindi, il denaro del gruppo quotato in Borsa sarebbe passato, via Lussemburgo, nelle disponibilità della famiglia Tanzi.
Epicurum, allora, era un semplice schermo che serviva a occultare il trasferimento di risorse finanziarie verso i padroni di Parmalat? Proprio su questa ipotesi investigativa stanno ragionando in queste ore i magistrati. E' interessante notare che la Satalux viene costituita alla fine dell'anno scorso, quando esplode anche il caso dei Ciriobond, ed era quindi prevedibile una stretta nei controlli in Italia sui gruppi, come la Parmalat, che avevano emesso obbligazioni in grande quantità. Non solo. Proprio in quei mesi le banche creditrici stavano facendo pressione sul cavalier Calisto perché ripianasse l'enorme deficit (oltre 300 milioni di debiti) delle attività turistiche di famiglia raggruppate sotto le insegne di Parmatour.
Un'altra coincidenza merita di essere segnalata. Nel ruolo di revisore dei conti di Satalux compare la Themis Audit, sconosciuta società domiciliata nel paradiso fiscale delle Isole Vergini britanniche. Non è la prima volta che la Themis Audit incrocia la Parmalat story. Per scoprire quando e dove basta bussar alla sede della Satalux, in rue Sainte Zithe al numero 38. Allo stesso indirizzo è infatti registrata anche la Third Millenium holding, finanziaria lussemburghese di Tonna. Anche l'ex direttore finanziario di Parmalat ha arruolato Epicurum come socio. E la Thesis Audit delle Isole Vergini Britanniche come revisore. Un caso. O no?
Lo Stato tiene a balia l'industria del latte
Come sempre: fornitori, dipendenti, creditori.
Editoriale su il Foglio
Roma. Enrico Bondi non l'avrebbe mai detto, chiusi i capitoli della sua permanenza in Telecom e in Sai meditava di ritirarsi tra gli ulivi della campagna aretina. E' nata invece ieri una legge che a tutti gli effetti porta il suo nome, anche se si chiamerà magari legge Marzano o decreto Parmalat. Le richieste che Bondi aveva illustrato al ministero delle Attività produttive erano volte a salvare il gruppo industriale disastrato distinguendolo dal crac finanziario. Rappresentavano il distillato della task force congiunta dello studio Origoni-Grippo, di Price Water House, di Mediobanca e Lazard. Sono stati tutti – “quasi tutti”, dice l'incontentabile Bondi ai suoi – assorbiti nel decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, oggi stesso in Gazzetta ufficiale. Bondi aveva bisogno di mani libere e di essere amministratore unico e non collegiale, e lo sarà come commissario straordinario nominato dal governo. La Parmalat di oggi non ha i requisiti minimi per essere ammessa da un Tribunale all'amministrazione controllata, e il decreto nasce per attenuare quei requisiti puntando però allo stesso obiettivo, cioè la continuità industriale, dei suoi livelli occupazionali e – attenzione – della sua “italianità”. Irrompe nella legislazione italiana un'eco francese, sull'onda dei vari modelli Alstom e Bull. Perché lasciare alla Francia i salvataggi dei grandi gruppi? La Commissione europea obietterà, ha subito avuto a che ridire Pierluigi Bersani, portavoce economico dell'Ulivo. “Vorrà dire che tratteremo a muso duro come i francesi”, è la risposta dell'ala più “sociale” del governo, guidata da un soddisfatto Gianni Alemanno, ministro dell'Agricoltura: “L'Ulivo voleva l'applicazione della legge Prodi, ma è totalmente inappropriata, avrebbe portato diritto a uno spezzatino e a una vendita all'incanto a prezzi di realizzo”. Dalla quale non avrebbero beneficiato gli interessi che l'amministrazione straordinaria mira a tutelare, quelli dei creditori, obbligazionisti, azionisti e dipendenti. Nessuno può fallire, salvo i piccoli Da ieri, in Italia, non sono più solo le banche, a “non poter” fallire. Anche per i grandi gruppi privati sopra i mille dipendenti, vale il “too big to fail”. “Bisogna credere che il governo disponga di una ragionevole certezza che le banche concederanno a Bondi nuove basi patrimoniali per rimettere Parmalat in piedi oppure il decreto va letto come una disponibilità di denaro pubblico, magari con formule a tempo tipo Sviluppo Italia”, è il primo commento raccolto ieri ai desk londinesi che analizzano l'Italia per Goldman Sachs. Non è la linea di un governo liberista, insomma. Dove il Consiglio dei ministri ha confermato che i problemi esistono, è invece sul delicato riordino dei poteri di vigilanza in materia di credito e finanza. Alemanno e Rocco Buttiglione, ministro per le Politiche europee, sottolineano che il premier in persona ha chiesto una regia attenta del provvedimento, senza nessuna personalizzazione e forzatura ostile verso la Banca d'Italia come verso la Consob. Nel tentativo, che sta a cuore anche al Quirinale, di non perdersi subito per strada l'opposizione visto il rilievo istituzionale dei punti da modificare, secondo il modello accortamente seguito nel varo della commissione d'indagine a Montecitorio. Si tenta di giungere a un accordo entro pochissime settimane.
…
Le angosce di Tremonti
Parmalat e tranvieri
Edtoriale su il Riformista
La sera di lunedì 22 dicembre, al ministero del Tesoro, Giulio Tremonti ha riunito per una breve e frugale cena di auguri il top dei grand commis e dei manager di stato. Un'occasione puramente conviviale, senza grandi discorsi, né decisioni da prendere. Le chiacchiere in libertà che in genere si accompagnano a queste occasioni, si sono concentrate, ça va sans dire, sulle emergenze più gravi di fine anno. La prima, davvero drammatica, si chiama Parmalat. Il ministro dell'Economia è consapevole della portata del crack. Non solo per le sue ricadute sull'industria e sull'occupazione, non solo per l'entità del buco che supera i 7 miliardi di euro, ma anche per le ripercussioni che potrà avere sul sistema Italia. Ieri il Financial Times, in un allarmante editoriale, adombrava la possibilità di un rischio paese, cioè che anche i titoli sull'immenso debito pubblico italiano collocati sul mercato internazionale, possano subire un downgrading. Tremonti non vuol crederci, ma già gli tremano i polsi.
La seconda preoccupazione riguarda la rivolta degli autoferrotranvieri. Il problema non è solo che non ci sono i quattrini per soddisfare le loro richieste. No, davvero inquietante è che gli scioperi selvaggi sono la spia di un malessere di fondo. Esprimono frustrazione, disperazione, il senso di un degrado e di un impoverimento di categorie che una volta erano l'"aristocrazia operaia". I garantiti di un tempo non lo sono più. Non servono appelli alla ragionevolezza. I sindacati non controllano, hanno perduto consenso e autorità. E' inutile persino il ricorso alla legge. Ma ancora peggio è la percezione che, disagi a parte, i tranvieri ribelli trovino un appoggio muto, un sostegno silenzioso della gente che sembra dire: oggi a loro, domani può capitare a me. La crisi è così profonda che sembra senza via d'uscita. E può provocare disgregazione, fino a spinte anarcoidi e populistiche. E tra gli ospiti di via XX Settembre, si sentiva parlare di nuovi movimenti sociali, di tensioni che possono diventare incontrollabili. Il Natale scorso teneva banco la crisi Fiat. Ora il gruppo torinese sembra aver imboccato la via di una lenta e difficile ripresa (anche se il 2004 sarà ancora duro, come ha avvertito Umberto Agnelli). Il collasso Parmalat e il tranviere selvaggio preparano un anno da brividi. E ci sono pure le elezioni alle porte.
Giorno nero per la Repubblica
Pasquale Cascella su l'Unità
"Scusateci, ma noi adesso dobbiamo allontanarci...". La sceneggiata è andata in onda come da copione: lo ha presieduto Silvio Berlusconi l'ultimo Consiglio dei ministri del 2003, e Gianni Letta ha verbalizzato da scrupoloso sottosegretario fino a quando non è arrivato all'ordine del giorno l'esame del decreto legge sulle "disposizioni urgenti concernenti le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997 n.249".
La formula è ambigua: sposta di quattro mesi una scadenza già cogente per sentenza della Corte costituzionale; restituisce all'Authority delle comunicazioni l'accertamento effettivo dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri ma non anche l'applicazione concreta e immediata delle sanzioni conseguenti alla eventuale violazione; "considera" il messaggio di rinvio della legge Gasparri al Parlamento ma evita accuratamente di assumere "nello spirito e nella lettera", come pure Gianfranco Fini e Marco Follini ritengono giusto e doveroso, i rilievi del capo dello Stato. E però lo stesso titolo del decreto deve riconoscere che l'attuale regime di duopolio tv è "definitivamente cessato", come sancito dalla Consulta. Le "modalità", dunque, riguardano un'altra "transizione", quella dalla legge che porta la firma dall'allora ministro del centrosinistra Antonio Maccanico (che pure consentiva a Rete4 di organizzare per tempo il passaggio dall'etere al satellite), alla nuova legge sul sistema integrato delle comunicazioni. Che però è sospesa. Perché il ministro Maurizio Gasparri e la maggioranza di centrodestra l'hanno forgiata sul modello del duopolio tv, costringendo il presidente della Repubblica a chiedere al Parlamento di a rimuovere i vecchi e i nuovi ostacoli alla piena espressione della libertà e del pluralismo dell'informazione.
Il Consiglio dei ministri si è limitato a lanciare una corda sul vuoto, tra un assetto che non dovrebbe più esserci e un sistema che ancora non c'è. Avrebbe potuto provvedere con la chiarezza e la nettezza con cui si è pronunciato Carlo Azeglio Ciampi. Ha, invece, preso dal messaggio del presidente della Repubblica solo quel che serve a ottenere l'emanazione del decreto. Niente di meno: anzi, il "meno peggio", per dirla con Maccanico. Ma tutto il di più è segnato dagli interessi del premier tycoon. Anche se Berlusconi ha lasciato la sala di conserta con Letta, lasciando a Fini e al resto dei ministri di sbrigare in appena dieci minuti la bisogna di salvare, con il soldato Emilio Fede, i 40 miliardi al mese di vecchie lirette che Rete4 e Mediaset avrebbero perso in fatturato pubblicitario (per non dire delle conseguenze sul valore patrimoniale) con il trasferimento dall'etere al satellite. Calcolo preciso, meticolosamente effettuato dallo stesso premier-tycoon nella conferenza stampa di fine anno in diretta tv. Con l'aggiunta di una insinuazione sulle "pressioni" nei confronti del capo dello Stato da parte della "corporazione" degli editori, beninteso della carta stampa, essendo stato prima e restando adesso il mercato televisivo saldamente monopolizzato dal tycoon di Arcore.
…
Come credere che sia un caso che quella legge sia stata rinviata ancora tre giorni fa? E se non è un caso, come non sospettare che il rinvio della Gasparri da parte di Ciampi sia stato messo in conto assieme ai 485 miliardi in bilico per Rete4? E se tutto è stato calcolato prima, come non temere nuove forzature sul percorso di revisione della legge rinviata al Parlamento ottenere comunque, e imporre alla controfirma del capo dello Stato, ciò che l'Authority delle comunicazioni contestualmente dovesse sanzionare soltanto moralmente, come guarda caso puntualizza Gasparri? E, forzatura per forzatura, come escludere che lo stesso personale interesse economico che consente al solo Berlusconi - lo ha ricordato Massimo D'Alema - di disporre delle grandi risorse necessarie per occupare spazi e spot di propaganda, sia legato all'interesse politico ed elettorale della manomissione della par condicio? Tutto si tiene per immaginare che il decreto possa procedere su un binario morto, e non in parallelo con la legge sul sistema integrato delle comunicazioni. Ricordando, nella giornata nera della Repubblica, che questa costituzionale ancora non è. Parola di Ciampi.
"E' esploso il conflitto d'interessi"
Ulivo all'attacco, ma è soddisfatto per l'Authority
Nino Bertoloni Meli su Il Messaggero
ROMA Gli strali, le rasoiate, le bordate sono tutti indirizzati sul conflitto d'interessi. Su questo sparano ad alzo zero Fassino, Rutelli, Angius, Violante, Chiti, Gentiloni, Giulietti, insomma lo stato maggiore ulivista che ha seguito da vicino la vicenda Gasparri. Ma dietro le bordate, scontate, sul padre di tutti i conflitti, si intravede un Ulivo alquanto cauto, per non dire soddisfatto degli esiti del decreto Gasparri. Quella data ultima - il 30 aprile, cioè quattro mesi - e soprattutto quella novità del passaggio dei controlli da palazzo Chigi all'Authority per le comunicazioni è salutato con malcelata soddisfazione da quasi tutta l'opposizione. Che infatti sul tema si guarda bene dall'attaccare. Anzi. Ai piani alti dell'Ulivo fanno spallucce e invitano a non prendere sul serio quanti, come il verde Paolo Cento, parlando di decreto "incostituzionale". Il motivo?
E' molto semplice. Sia i quattro mesi sia il passaggio all'Authority sono stati il frutto di un braccio di ferro tra parti della maggioranza e il Quirinale, tra i falchi del centro-destra e il capo dello Stato. I primi avrebbero voluto un decreto di sei mesi (il leader Udc Marco Follini si era espresso per non andare oltre i due mesi), ma sul Colle sono stati irremovibili: non oltre quattro. E il braccio di ferro, grazie anche ad alcune crepe nella maggioranza e allo schieramento dell'opposizione, hanno reso la posizione del Quirinale inespugnabile. Sicché il centrosinistra che conta, e anche Fausto Bertinotti, sono di fatto riusciti a imporre un alt e possono dire di avere riportato se non una vittoria, certamente un pareggio fuori casa. Non a caso il leghista Roberto Calderoli, commentando il decreto e le reazioni al medesimo, definisce esplicitamente un "regalo alla sinistra" il potere conferito all'Authority. E adesso, che cosa potrà succedere?
Dal 7 gennaio la legge Gasparri ”riformata” dal Colle sarà di nuovo all'esame del Parlamento. E nell'opposizione già affilano le armi, si fanno annunci, si mettono a punto tattiche e strategie. Anticipa Paolo Gentiloni, il dirigente della Margherita esperto in materia: "Per noi l'atteggiamento da scegliere è abbastanza semplice e scontato: se la maggioranza si presenta con proposte peggiorative di questo decreto, se non terranno conto dei rilievi di Ciampi, allora il nostro obiettivo sarà di impedire l'approvazione della legge entro il 30 aprile, anche ricorrendo a forme di ostruzionismo. Se invece recepiscono i rilievi del Colle, allora sarà anche possibile sedersi attorno a un tavolo e ragionare su una buona legge per il sistema radiotelevisivo. Ma dubito che abbiano in mente soluzioni del genere".
Le reazioni dell'opposizione al decreto, nella parte destruens, nella parte volta a denunciare il conflitto di interessi, sono state molto dure. "Uno scandalo", lo ha definito Francesco Rutelli, "neanche nelle ex repubbliche sovietiche sarebbe stato tollerato". Per Piero Fassino, "il premier ha firmato un decreto che riguarda una sua azienda, è la dimostrazione più lampante di un conflitto di interessi non risolto". Sullo stesso tasto Vannino Chiti, coordinatore della segreteria Ds: "Il presidente del Consiglio, proprietario di Mediaset, firma un decreto che reca vantaggio alle sue proprietà a discapito di altri possibili concorrenti". Un altro diessino, Beppe Giulietti, commenta sarcastico: "Il premier aveva promesso un grande futuro alla famiglia Italia, per il momento ha assicurato un grande presente alla famiglia Berlusconi. Neanche il regista di ”Totò truffa” avrebbe saputo fare di meglio".
Senza vergogna
Norma Rangeri su il Manifesto
Il presidente Ciampi aveva appena riaperto una importante, cruciale partita per la democrazia italiana, che il presidente Berlusconi l'ha subito richiusa apponendo la sua firma in calce al decreto che salva una televisione altrimenti fuori legge. La sua. Si tratta di circa trecento milioni di euro (alias Rete4), un malloppo che deve restare dov'è. Se ne riparlerà tra cinque mesi. Forse, sempre che un altro decreto non si aggiunga a spostare più in là i termini di nuovi salvataggi. Sembra una di quelle barzellette che non fanno ridere, invece è quel che è successo ieri, a palazzo Chigi, in quindici minuti.
La decisione del consiglio dei ministri di favorire, con un apposito decreto, il core-business di Berlusconi, sbatte in faccia a tutti gli italiani il sigillo del Biscione e segna un punto di non ritorno nella ventennale storia del berlusconismo. In passato, per ottenere decreti utili alle sue televisioni, il Cavaliere doveva fare anticamera, rivolgersi all'amico Craxi che lo accontentava volentieri. Oggi fa da sé. Altro che favola metropolitana, come l'inquilino di palazzo Chigi ha definito, con irridente strafottenza, il conflitto di interessi. Questo è un incubo.
In quale paese civile può accadere che il capo del governo firmi un decreto ad hoc per difendere il suo portafoglio? E da oggi con quali argomenti si impedirà ai lavoratori minacciati di licenziamento, ma privi del privilegio di essere dipendenti di Berlusconi, di rispettare le regole anziché erigere barricate per manifesta ingiustizia?
I telegiornali hanno battuto la grancassa delle tv da salvare, infilando nel calderone anche Raitre e facendo grande attenzione a non dire che il governo si apprestava a varare semplicemente un decreto Berlusconi in difesa di una tv di Berlusconi. Direttori e mezzibusti hanno ubbidito all'ordine di scuderia dettato dal direttore generale di viale Mazzini. Flavio Cattaneo ha cantato in coro con i ministri di palazzo Chigi agitando lo spauracchio dei licenziamenti. Così da indurre a credere che, con Fede sul satellite, si sarebbe mortificato il pluralismo dell'informazione e togliendo la pubblicità a Raitre si sarebbe recato un grave danno economico al servizio pubblico. Falso. La Terza Rete con la sentenza della Corte Costituzionale non c'entra nulla, e il bollettino di partito di Fede (che in molti insistono a chiamare telegiornale) si sarebbe finalmente potuto giovare delle nuove tecnologie (satellite e digitale) della legge Gasparri. O sono bufale anche quelle?
La verità che sfonda il fragile muro del pudore, mostrando al "pubblico" cosa c'è dietro il venditore di sogni, è che il decreto Berlusconi salva solo le tasche di Berlusconi, particolarmente gonfie dopo questi primi anni di governo. Gli uomini di Mediaset hanno passato l'autunno a sventolare gli utili da record dell'azienda di famiglia (362 milioni di euro nello scorso anno, un incremento pubblicitario ancora nel 2003) e con la legge Gasparri si preparavano a festeggiare il regale bottino. Il presidente della repubblica gli ha tolto il boccone di bocca, ma la famiglia non si è persa d'animo.
Altro che licenziamenti e dipendenti senza il panettone. Colpire anche solo un anello della catena Mediaset, come sarebbe accaduto rendendo esecutiva la sentenza della Corte, avrebbe interrotto il ciclo economico dell'unica macchina televisiva europea capace di accumulare una vertiginosa rendita. Forse era questo che l'ex presidente del consiglio, Massimo D'Alema, intendeva quando, per rassicurare l'avversario sulla sua politica di buon vicinato, disse che Mediaset era "una ricchezza e un valore del paese".
La linea dura a senso unico
Bruno Ugolini su l'Unità
“Adesso basta, tolleranza zero”. La furiosa parola d'ordine, nata all'indomani dell'orribile tragedia delle Torri Gemelle, a New York, l'ha fatta risuonare in queste ore, non il capo del governo, ma un sottosegretario del ministro Roberto Maroni.
Radio Radicale ieri mattina, nel corso della trasmissione "Stampa e regime", ironizzava su questo sottosegretario che fa il ministro. Il problema è che il vero responsabile del "Welfare" (così oggi modernamente si chiama il dicastero del Lavoro) in questi giorni compariva nelle cronache, anche lui appiedato in quel di Varese, mentre era intento allo shopping natalizio. E così il sottosegretario, Maurizio Sacconi, prende il sopravvento e tuona a tutto spiano. E a noi ricorda, irresistibilmente, Stefano Parisi, un altro funzionario, direttore della Confindustria che quando parla non pare il neo assunto direttore generale dell'associazione imprenditoriale, ma il presidente stesso della Confindustria medesima.
Fatto sta che il suddetto sottosegretario ancora ieri è tornato alla ribalta, minacciando addirittura le aziende dei trasporti, sparse nelle diverse città. Perché? Perchè non osino promuovere, per avere la pace sociale, intese integrative al contratto nazionale, già firmato da Cgil Cisl e Uil.
Ma mentre costui alza i toni, invoca la "tolleranza zero", implora le precettazioni ad oltranza, gli scioperi proseguono e gli accordi si fanno.
…
Ma questo governo e questo sottosegretario, prima di parlare o minacciare, dovrebbero riflettere su altre regole. Quelle ad esempio contenute nell'accordo del 1993, stabilito sotto l'egida di Carlo Azeglio Ciampi.
Decine d'autorevoli osservatori avevano scritto, allora, che finiva una fase, quella degli odiati automatismi nel collegamento tra i salari e l'inflazione e si apriva un'altra epoca. Quella della contrattazione, quella di un ruolo importante, non burocratico, riservato a sindacati e controparti, finendo con un metodo che, attraverso la scala mobile, addormentava anche il salutare conflitto. Con regole precise, appunto. Ma da due anni queste nuove norme per gli autoferrotranvieri - e non solo per loro, se andiamo a vedere come sono andate diverse trattative sindacali in questi mesi - non sono rispettate. Sono state calpestate, ignorate. E nessun ministro, nessun sottosegretario, se n'è accorto e, indignato, ha alzato la voce. Nessuno ha gridato "Tolleranza Zero. È ora di finirla".
Invece avrebbe fatto bene a farlo. Ora non saremmo in queste condizioni. Condizioni che convincono addirittura un foglio non certo estremista come Il Sole 24 ore che le agitazioni in corso richiedono una risposta non solo repressiva e che governo e controparti pubbliche dovrebbero farsi una "severa autocritica".
Ha capito bene, signor ministro del Welfare? Ha capito bene signor sottosegretario? "Severa autocritica". Ascoltino almeno anche questa voce del padrone.
Anche così potrebbero calmare gli animi degli autoferrotranvieri e fare un favore ai cittadini.
Un Natale di guerra
Gianni Riotta sul Corriere della Sera
Il 2003 passerà alla storia come l'anno cruciale in cui gli Stati Uniti decisero di sfidare lo status quo seguito alla Guerra Fredda, e Francia, Germania e Russia provarono invano a difenderlo. La rottura tra Usa e parte degli alleati potrebbe rivelarsi assai più gravida di conseguenze del decisivo conflitto in Iraq. L'Occidente poteva muovere insieme guerra a Saddam Hussein o, insieme, accerchiarlo e disarmarlo. Non c'è riuscito, dividendosi all'alba della prima guerra globale.
L'11 settembre 2001 ha persuaso la Casa Bianca del presidente George W. Bush a mutare strategia. Propenso a una politica estera mirata ai soli rapporti con i potenti, Russia, Cina, Europa e America Latina, Bush s'è trovato invece a combattere nelle regioni del disordine che voleva evitare a tutti i costi, Afghanistan e Iraq. Malgrado gli strateghi del caos siano attivi a Bagdad come a Kabul, il successo degli americani si deciderà sulla democrazia e sui diritti civili, l'agenda più importante del 2004, elezioni presidenziali Usa incluse. Quando Malalay Joya, assistente sociale di 25 anni, velo islamico sui capelli, si alza a parlare alla loya jirga, l'assemblea costituzionale afghana, e, sfidando per la prima volta da millenni gli uomini, dice “Tutti i signori della guerra, compresi quelli che qui siedono, dovranno essere giudicati come criminali” una corrente rivoluzionaria attraversa elettrica il mondo islamico. Non sarà stata questa l'intenzione del Pentagono nell'inviare oltremare le proprie armate, ma adesso semi di libertà sono stati piantati a sorpresa, come tante volte nella storia. Sorprende che la sinistra europea, Tony Blair escluso, non voglia coltivarli, ed è auspicabile che lo faccia presto. Il segretario di stato Colin Powell percepisce la solennità del momento e scrive all'Economist: “Combattiamo il terrorismo perché costretti a farlo, ma desideriamo un mondo migliore, con democrazia, sviluppo, salute e diritti umani. Non si tratta di decorazioni per camuffare i nostri interessi. Sono questi i nostri veri interessi”. Ecco la posta in gioco in un Natale di guerra, malgrado shopping e luminarie, sia per gli americani che per noi europei: affermare senza ipocrisie i diritti umani fondamentali non è la chiamata dei velleitari di buona volontà. E' la pietra d'angolo di ogni realpolitik. Il filosofo Michael Ignatieff ricorda che i tiranni blanditi quando torturano i propri sudditi, perché offrono in cambio “stabilità” geopolitica, prima o poi si rivoltano contro i padrini, costringendoli a intervenire. Ultimo della lista Saddam Hussein. Se la frattura Usa-Ue si perpetuerà, a Washington trionferanno i falchi, anche nel caso di vittoria democratica, in rimonta, alla Casa Bianca. E nelle capitali europee dilagherà una petulante impotenza, incapace di dialogare con il mondo nuovo.
…
E-mail sotto controllo per 5 anni
Rodotà: “Norma incostituzionale”
Massimo Martinelli su Il Messaggero
ROMA - Nel telefono in salotto. Nel cellulare. Persino dentro il nostro computer. Il Grande Orecchio della magistratura si prepara a entrare nella nostra vita; in quella di tutti: delinquenti e gente perbene fino a prova contraria. Con un unico ostacolo facilmente aggirabile: quello di evitare la contemporaneità tra controllo e atto da controllare. Basterà aspettare un giorno e un investigatore qualsiasi, delegato dal pm di una procura qualsiasi, potrà chiedere tutto di voi, o quasi, ai gestori telefonici e ai provider che garantiscono l'accesso a Internet. Lo ha stabilito ieri il Consiglio dei ministri. Con un'unica, laconica, motivazione: misure necessarie a contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata.
Significa che per cinque anni (30 mesi più altri 30 rinnovabili) saranno conservate le nostre telefonate, i nostri messaggini Sms, le nostre email e l'elenco completo dei siti Internet visitati, dai quali è chiaramente possibile intuire gusti, abitudini e tendenze di ognuno di noi. Il Garante per la Privacy, Stefano Rodotà, è fuori di sè; ma siccome è uomo all'antica si limita a "prendere atto con preoccupazione del decreto legge sulla conservazione dei dati del traffico telefonico e su Internet". Fa notare che "la nuova disciplina può anche entrare in conflitto con le norme costituzionali sulla libertà e segretezza delle comunicazioni e sulla libertà di manifestazione del pensiero". Infine si appella alle Camere affinché valutino "attentamente" il decreto stesso.
Il Guardasigilli Castelli e il ministro per l'Innovazione, Stanca, tra i firmatari del decreto, cercano di essere tranquillizzanti: "Il provvedimento riguarda solo l'accesso ai dati in transito ed è consentito solo ai magistrati inquirenti". E ancora: "In nessun modo il provvedimento riguarda e può riguardare il contenuto di conversazioni ed e-mail". Ma su questo punto, non la pensano allo stesso modo coloro che hanno fatto di Internet un mestiere, cioè i gestori dei provider: "L'archiviazione coatta di tutte le email con i relativi allegati, comporterebbe la creazione di archivi dai quali si potrebbe risalire agli interessi culturali, sociali, politici, religiosi, sessuali, nonché alla cerchia di relazioni di ciascun utente creando, nei fatti, un dossier a carico di ciascun cittadino da cui rimarrebbero esclusi, in una sorta di paradossale digital divide alla rovescia, solo coloro che ancora non usano la Rete", dicono i vertici dell'Associazione italiana Internet provider e anche i Provider indipendenti.
…

 24 dicembre 2003
24 dicembre 2003
![]() 24 dicembre 2003
24 dicembre 2003